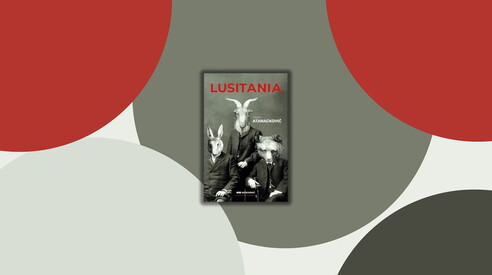Ansa
Piccola posta
A Srebrenica la memoria ha il segno delle madri e delle spose, che non hanno smesso di cercare giustizia
Nel trentennale del massacro, sette nuovi corpi trovano sepoltura. Tra preghiere e silenzi, le donne presidiano ancora il cimitero di Potocari e i giovani riscoprono la storia mentre i governi europei esitano a guardarla in faccia
Srebrenica, 11 luglio. Ogni volta che ho partecipato alla commemorazione del genocidio, e questa volta era il trentennale, sono stato colpito dalla confidenza con cui le donne, le anziane donne soprattutto, stanno fra le tombe solenni, stendono le coperte, siedono in cerchio, pregano, parlano, fumano, mangiano, piangono e ridono. Stanno coi loro uomini, mariti, figli, fratelli. Stanno in famiglia. Il monumento al genocidio di Srebrenica è stato eretto soprattutto dalle leggendarie donne, le padrone di casa, cui nemmeno l’infamia di consegnare alla Republika Srpska la città del suo più orrendo crimine è riuscita a incrinare. Finita la commemorazione, una gentile dirigente del Museo di Potocari mi ha prestato un tavolo dell’ufficio annesso alla biblioteca. Mi ha solo raccomandato di non toccare gli oggetti ordinati sul tavolo. Sono gli strumenti con cui si continua a lavorare alla ricognizione delle reliquie dei corpi, li guardo con reverenza, non sembrano molto differenti da quelli di un normale laboratorio di restauro di altri monumenti. Qui hanno a che fare con la memoria, fuori da ogni significato astratto o metaforico: la restituzione di ossa frantumate consumate e disseminate dal furore del mattatoio e dal terrore che gli assassini all’ingrosso provano nei confronti delle loro vittime e di chi sopravvivrà loro. Ci sono povere reliquie identificate con certezza il cui funerale è sospeso da anni, per anni, nella speranza tenace di scoprire le ossa che mancano, o almeno una parte rilevante, da qualche altra delle fosse comuni in cui furono più volte esumate e disperse per cancellare le tracce del lavoro compiuto.
Oggi sono state seppelliti solennemente i resti di sette nuovi corpi ricomposti nell’ultimo anno, a trent’anni dai giorni della carneficina. Una moltitudine di persone, centomila, si è detto, è convenuta al cimitero di Potocari. Chi non ha visto la distesa di stele di marmo bianco che copre i fianchi della collina non può avere idea di quanti siano, quanto spazio prendano, ottomilaquattrocento esseri umani morti. Né, nei fabbricati di fronte, del poco spazio in cui si stringevano le decine di migliaia di esseri umani vivi che avevano confidato nella promessa del mondo, delle Nazioni Unite, dell’Europa, dei suoi governanti e dei suoi generali, di proteggere chi fosse venuto a rifugiarsi nella città santuario. Mancano ancora, dicono i curatori e le curatrici, almeno altre mille persone all’attesa dei loro cari. È ammirabile la cura che si dedica ancora alla riparazione di quel luglio e alla pietà dei loro cari. Delle loro care soprattutto, perché il mattatoio scelse gli uomini, dai ragazzi agli anziani, e delle donne si contentò di stuprarle, quando le valutò passabili, e braccarle nella fuga. Ammirabile, anche se viene dopo, e spesso fa coincidere negli stessi autori, nelle stesse autorità, crimini e riparazioni. La memoria insegue il desiderio struggente di riavvolgere la storia alla rovescia. Alla vigilia della commemorazione, come ogni anno ormai, più di settemila persone hanno rifatto al contrario la marcia di tre giorni di donne bambini e fuggiaschi che allora era stata della morte e ora si intitola alla pace, i 100 chilometri a piedi da Tuzla a Srebrenica.
La memoria ha da sempre il segno delle madri e delle spose, che non hanno mai smesso di cercare giustizia. Trent’anni dopo, i vuoti sono cresciuti nelle loro file, e però arrivano le ragazze e i ragazzi. Questo è un paese di giovani, così si spiegano i racconti: “In quei giorni ho perso 22 persone della mia famiglia…”. I giovani che sono venuti “dopo”, “dopo il genocidio”, pronunciato senza altre determinazioni, in trent’anni sono diventati la maggioranza, e oggi si vede. Ci hanno messo un po’ ad aver voglia di conoscere il passato, le persone grandi spesso avevano pensato di risparmiargliene i racconti, poi si sono rotti gli argini. Qualcuna, qualcuno, vuole tornare dagli angoli della terra in cui la guerra sparpagliò i bosniaci musulmani, altri, i più numerosi, tornano alle storie dei loro antenati falciati, e alla storia.
La storia. L’anniversario di oggi, così solenne, è stato trattato più avaramente dai governanti. L’Italia era rappresentata dall’ambasciatrice a Sarajevo, Sarah Eti Castellani, e dal messaggio del presidente Mattarella. L’Europa dal presidente del Consiglio europeo António Costa e dalla commissaria per l’allargamento Marta Kos. Solo la Croazia è stata presente col suo premier, Andrej Plenkovicć. Erdogan, in video, ha rivendicato il suo patronato, il suo padrinato, sui musulmani di Bosnia, e ha insistito sul legame fra Srebrenica ’95 e Gaza oggi. Quel legame era al fondo della stessa preparazione bosgnacca: “Ieri Srebrenica. Oggi Gaza. Domani?" Nella commemorazione è stato presente in modo misurato, e uno sparuto drappello di islamisti con la fronte nerobendata e la vocazione al martirio, sì e no una decina, è stato messo fuori alle porte dai militari della Federazione. Quanto ai serbi, il traballante presidente Aleksandar Vucčicć ha mandato un messaggio di circostanza: ma il suo governo è strenuamente impegnato a negare il genocidio, “in guerra si commettono crimini da tutte le parti”, e a favorire a Belgrado una campagna impudente con lo slogan: “C’è stato un solo genocidio, e l’hanno patito i serbi”. A grandi caratteri, intatti dai vigili urbani.