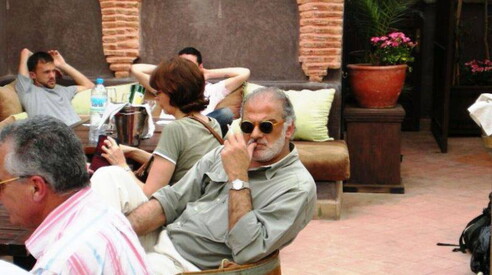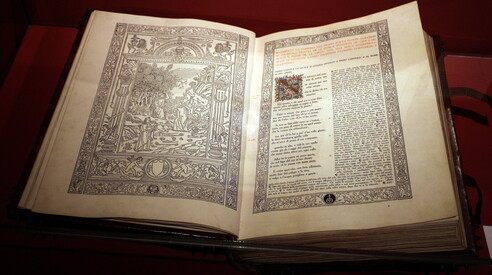piccola posta
Tre vite, due guerre, le impiccagioni. Come a volersi staccare dalla terra
Mariia Buhaiova, Ferida Osmanovic, Alexander Langer. Storie conosciute che hanno incontrato un nuovo intreccio
Oggi voglio scrivere di tre vite. Le loro storie sono conosciute, hanno incontrato un nuovo intreccio. La prima è appena avvenuta, a Carovigno, Brindisi. Mariia Buhaiova, ucraina, studentessa, era in Puglia per un’esperienza di lavoro turistico organizzata dalla sua università slovacca, e terminata. Aveva compiuto 18 anni da pochi giorni, senza festeggiare: era timida e riservata, hanno detto di lei i coetanei. Venerdì 4 luglio ha spedito per telefono 750 euro a suo fratello, ha lasciato nella sua stanza altri spiccioli, i documenti e un biglietto con i numeri dei famigliari da chiamare, e si è incamminata sola verso un terreno incolto poco distante. Ha portato con sé uno zainetto, c’era dentro un lenzuolo bianco, che sarebbe servito, dice qualche cronaca, a farla coprire da chi l’avesse ritrovata. Si è tolta le scarpe e si è impiccata a un albero. Con il lenzuolo, dicono altre cronache. C’è una sua fotografia sui giornali, l’avrete guardata.
Una storia straziante per chiunque. Io sono a Sarajevo, e andrò domani, 11 luglio – Ako Bog da, se Dio vuole, come si dice qua – a Srebrenica, per la commemorazione a trent’anni. E non posso mancare un ricordo, una storia straziante e famosa, ne scrissi tante volte. Il 17 luglio del 1995 dei bambini che giocavano in un bosco fra Srebrenica e Tuzla, giusto fuori dalla inutile base aerea delle Nazioni Unite, trovarono un corpo di donna appeso a un albero. Una donna giovane, con una gonna bianca e una maglia rossa, e i piedi nudi. La cintura e lo scialle le erano serviti da corda e cappio. Un freelance croato, Darko Bandicć, la fotografò, e la fotografia prese le prime pagine dei giornali del mondo con la didascalia senza nome: “La donna impiccata”. Solo più tardi si seppe. Aveva 31 anni, si chiamava Ferida Osmanovic. Si era sposata nel 1980, sedicenne, con Selman, più grande di sei anni, contadino, nel loro paese, Podševar, al confine con la Serbia. Ne erano fuggiti all’inizio della guerra, a Srebrenica, promessa come un rifugio protetto dall’Europa e dalle Nazioni unite, cui si erano affidate migliaia di famiglie. Quando Ratko Mladicć e i suoi arrivarono e gli ufficiali olandesi brindarono con lui e lasciarono il campo, Selman rifiutò di scappare, o forse lei non insistette abbastanza, non seppero immaginare che cosa stesse per compiersi, per lui e altri più di 8 mila uomini, dai ragazzi ai vecchi. Ferida andò via con le donne, e coi due figli, Damir, 12 anni, e Fatima, 9. La seconda notte, a sera si sdraiarono sulla strada, lei li coprì con delle coperte, augurò loro la buona notte. Più tardi, quando Damir si svegliò, sua madre non c’era più. La trovarono quegli altri, Damir e Fatima visitarono più tardi la sua tomba, videro che sul legno che la segnava era scritto solo “Impiccata”, scrissero il suo nome con un pennarello.
Ero allora a Sarajevo, arrivarono donne stremate che venivano da Tuzla, precedute da voci così spaventose che si stentava a crederle. Dicevano che avevano trucidato tutti gli uomini, migliaia, che avevano stuprato le giovani, che le avevano cacciate. Non le avevano risparmiate, al contrario. Si erano divertiti a mostrare che loro, le donne, non valevano niente, una volta trucidati i loro uomini.
La terza storia è anche lei famosa, ed è stata appena ricordata da tanti, come merita. È la vita di Alexander Langer. Il 3 luglio 1995 ha lasciato la casa fiorentina di Valeria e si è incamminato per il Pian dei Giullari, poco distante. Aveva comprato – a Firenze, lui di Vipiteno – una corda da montagna, aveva scritto i suoi biglietti. Dicevano che i pesi erano diventati per lui insostenibili. Non siate tristi, dicevano, “continuate in ciò che era giusto”. L’imperfetto per lui, il presente per chi restava. Aveva scelto un albicocco. Un albicocco in quei giorni è carico di frutti. Si era tolto le scarpe e si era impiccato. Riconsiderate la data: il 3 luglio, mancavano otto giorni all’inizio del mattatoio di Srebrenica. C’era stata una strage, orribile, a fine maggio, di 71 ragazzi che festeggiavano il loro diploma, a Tuzla, la città con cui Alex aveva più legato, e il suo amico sindaco aveva scritto a lui perché lo leggesse al parlamento europeo: “Se restate in silenzio, se anche dopo questo non agite con la forza come unico mezzo legale, allora senza alcun dubbio voi eravate e restate dalla parte del male, del buio e del fascismo”. È stupido e irrispettoso voler spiegare il suicidio di Alex, e tanto più volerlo spiegare con la disperazione per la tragedia impunita della Bosnia. Ma fra gli innumerevoli pensieri irrispettosi e stupidi che mi accompagnano da allora c’è anche quello, che forse, appena dieci giorni dopo, conosciuta Srebrenica, forse Alex…
Erano queste tre vite. La guerra della ex Yugoslavia, quella d’Ucraina. Le impiccagioni. E i piedi nudi, come a volersi staccare meglio dalla terra. Soltanto per Alex l’albero ha avuto un nome, gli altri due sono restati, mi pare, anonimi, come se non fosse importante. Come se le coincidenze non fossero l’anima delle cose della vita e della morte, oltre che dei romanzi.