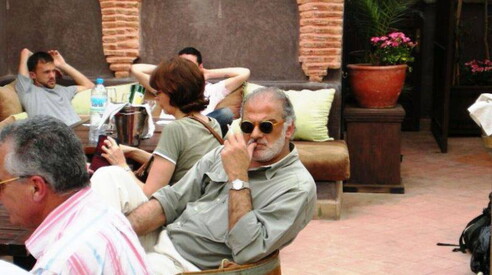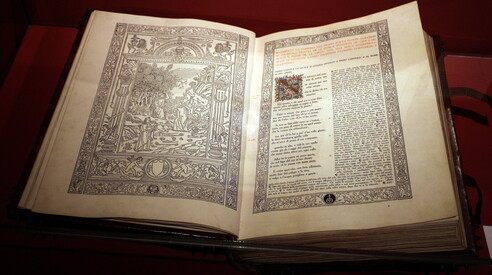LaPresse
Piccola Posta
I sensi di colpa di chi ha visto e continua a vivere
Matteo F. si è suicidato dopo la morte di Micheal, il bimbo annegato in piscina. Ha pensato di non poter più andare avanti dopo una disgrazia simile. Sappiamo capirlo, ma sappiamo capire anche il contrario, che si continui a vivere
In una piscina di paese – un “acquapark”, dal nome Tintarella di Luna – un bambino di 4 anni, Michael, sfugge all’attenzione di suo padre e dei bagnini e muore annegato. Uno dei bagnini, Matteo F., 37 anni, indagato d’ufficio, come i suoi colleghi e il povero padre, scompare e viene trovato morto, cinque giorni dopo, suicida. E’ una piccola doppia tragedia, su misura per gli esercizi d’elzeviro. Dai quali è meglio tenersi alla larga. I moventi si moltiplicano, del resto. La bambina di Villa Pamphilj, sua madre… Ma a Roma c’è stata una malvagità abominevole e criminale, qualcosa che chiama in causa la volontà. Nel paese del Bresciano è avvenuta una disgrazia. E, come saggiamente si dice, “le disgrazie succedono”. Succedono continuamente, e sembrano capricci malvagi della sorte, del destino, di qualche divinità maligna. Della vita.
Nei giorni scorsi un pm milanese ha chiesto al giudice di non procedere nei confronti della giovane madre che aveva inavvertitamente provocato al figlioletto di 18 mesi un danno irreparabile manovrando l’auto nel cortile di casa. Lei, ha detto quel pm, “sconta già una sorta di ergastolo con fine pena mai, e un’eventuale punizione non avrebbe alcuna funzione, né per l’imputata, né per la collettività, e sarebbe anzi controproducente”. Le disgrazie infatti succedono, e sarebbe disumano infierirci su. Le disgrazie infatti succedono più irreparabilmente e angosciosamente quando colpiscono i bambini. Voglio ignorare ora l’avvertimento a evitare il patetismo e l’indiscrezione. E anche l’esitazione che occorre tenere nei confronti dei sentimenti intimi di una persona che non si conosce, di cui si è appena vista qualche fotografia del giorno dopo, di cui si è solo letta qualche parola dei suoi, una persona aperta, altruista, scrupolosa… Matteo F. ha pensato di non poter più vivere dopo la disgrazia che aveva tolto alla vita il piccolo affidato anche alle cure sue, oltre che del suo padre e dei suoi colleghi. Ha avuto il tempo di decidere scrupolosamente come fare a finirla anche con la vita propria. Non ha, salvo errore, ritenuto di lasciare messaggi, forse gli è sembrato superfluo, o era troppo preso dal suo proposito e dal desiderio di realizzarlo a regola d’arte. Le disgrazie non esonerano dal senso di colpa, dalla sensazione di aver mancato, di essere responsabili. Il senso di colpa ha a che fare con la morale, spesso con la religione, e può aggiungerglisi, come in questo frangente, l’avviso d’ufficio dell’indagine giudiziaria sulla eventuale colpa: un’omissione, un atto mancato. D’ufficio, appunto. Ciascuno, che sia coinvolto, reagirà a suo modo. Ora, noi, ciascuna, ciascuno di noi intendo, troviamo non solo doloroso ma eccessivo, per così dire, straordinario, il gesto di Matteo F. Tant’è vero che sentiamo dire dai competenti che in traumi come il suo bisognerebbe prevedere sempre un sostegno, bisognerebbe non lasciare sole le persone, bisognerebbe soprattutto che gli altri, gli estranei, i giudici di propria nomina, non si sbrigassero a emettere condanne senza avvisi di garanzia… Eccessivo, il meticoloso, doloroso suicidio – dunque comprensibile, benché non condivisibile.
Sappiamo capire che un nostro prossimo senta di non poter più vivere dopo una disgrazia come quella, il bambino annegato in un’acqua da gioco, a un passo dal suo custode. Sappiamo capire soprattutto il contrario. Che si possa continuare a vivere. Vedendo ogni giorno corpi di bambini avvolti in sudari, bambini martoriati portati di corsa in braccio a un soccorritore, bambine mutilate e piangenti e atterrite, bambine schiacciate nella calca mentre tendono la loro gamella vuota e guardano disperate e incredule in una telecamera come se guardassero proprio voi, a casa vostra. Molti di noi dicono, si dicono, da chissà quanti giorni: “Non ce la faccio più”, e nel momento stesso si accorgono di stare compiangendo se stessi. Ma noi, direte, diranno, diremo, non siamo bagnini, non siamo addetti al soccorso di quella moltitudine dispersa e umiliata. Forse, forse no. Non siamo bagnini, ma assistere, sapere – continuare a vivere, cioè – è una corresponsabilità. Lo sappiamo, anche quelli di noi che continuano a ripetere che la colpa è dei criminali di Hamas che si fanno scudo della loro gente e vanto del suo martirio. Balle. Il fatto è che la cosiddetta guerra di Gaza – così come altre cosiddette guerre – non è una disgrazia. A differenza delle disgrazie, le cosiddette guerre non “succedono”. Il fatto è che noi siamo “normali”. Matteo F., si legge, “non ce l’ha fatta”. Perfino del bambino Michael le cronache scrivono che, trasportato disperatamente in un ospedale, “si è arreso”. Noi ce la facciamo, noi non ci arrendiamo. Ce ne devono essere altri, altre, eccessivi come Matteo F., a Gaza e fuori, probabilmente senza suicidarsi – è esperienza larga che non ci si suicidi tanto quando si è allo stremo, ma dopo, una volta usciti dal pelago alla riva – più probabilmente “morti di crepacuore”. Come si diceva una volta, quando la medicina non era andata così avanti.