
Ansa
Un Foglio internazionale
Le nostre parole distorte
Decostruzione, mascolinità tossica, benevolenza. Sono alcuni dei termini del dibattito attuale svuotati di significato e riscritti dall’ideologia. Raccomandazioni
"Antirazzismo”, “diversità”, “femminismo” o ancora “razzializzato”… Questi termini onnipresenti nel dibattito pubblico, spesso svuotati del loro significato originario, sono diventati indicatori politici e morali, al punto da imprigionare il pensiero in schemi ideologici, spiega il Point. Opporsi alla scrittura inclusiva equivarrebbe a contestare i valori dell’inclusione, così come negare l’esistenza di un “privilegio bianco” equivarrebbe a negare l’esistenza di un razzismo che colpisce le “minoranze etniche”.
Questi spiacevoli slittamenti semantici, sotto l’effetto di rivendicazioni militanti, spesso neoprogressiste e “benpensanti”, sono stati analizzati con precisione chirurgica in un libro illuminante, “Encyclopédie des euphémismes contemporains” (Éditions du Cerf), pubblicato l’11 settembre sotto la direzione del saggista Sami Biasoni, che ha riunito quarantuno intellettuali, tra cui Pierre-André Taguieff (politologo), Pierre-Henri Tavoillot (filosofo), Caroline Goldman (psicologa) e i linguisto Jean Szlamowicz e Yana Grinshpun. Il risultato finale è all’altezza delle aspettative riposte in questo libro. Gli autori individuano questi termini distorti e connotati, smascherano le manipolazioni militanti e infine raccomandano al lettore dei sostituti, per poter dare un nome alla realtà, senza correre il rischio di finire alienato da sistemi di pensiero che non si condividono.
Decostruire e decostruzione. La “decostruzione”, analizzata in questo libro collettivo da Emmanuelle Hénin, docente di Letteratura, è emblematica. Questo termine filosofico, che in origine “tende a revocare tutti i dogmi per sottoporli al vaglio della ragione” e in un secondo momento a mettere in discussione tutti i luoghi comuni, compresi quelli umanistici, ha completamente cambiato significato nel suo uso nel discorso contemporaneo. “Ora significa ‘analisi critica a scopo demistificatore’ e rimanda ai movimenti decoloniali (incarnati in particolare in Francia da Rokhaya Diallo), intersezionale (portato avanti da Fatima Ouassak) ed ecofemminista (rappresentato da Sandrine Rousseau), che riducono il pensiero occidentale a un semplice prodotto del ‘dominio maschile’ e dell’‘eteropatriarcato’”. Questo slittamento semantico sarebbe stato inaugurato da Michel Foucault e Jacques Derrida, due figure di spicco della French Theory, che hanno fatto di questo gesto – quello di decostruire – una lotta politica contro tutte le presunte discriminazioni. Avendo la militanza progressista – per non dire “woke” – fatto il suo corso, decostruire equivale ormai a delegittimare, emarginare e fustigare.
Raccomandazione: in senso filosofico, consiglia Emmanuelle Hénin, è preferibile utilizzare termini come “dubbio”, “critica” o “demitizzazione” se si desidera ritrovare il significato originale. Dal punto di vista ideologico, i termini “distruzione”, “nichilismo” e “postmodernismo” sembrano più appropriati per descrivere l’opera di demolizione dei militanti neoprogressisti.
Mascolinità tossica. Anche l’espressione “mascolinità tossica”, utilizzata soprattutto dalle attiviste e dalle figure di spicco del femminismo radicale, merita un’analisi. La scrittrice e giornalista Noémie Halioua ricorda che, oltre al processo Pelicot, in Francia si è svolto anche quello della mascolinità. Come riassume la saggista, secondo alcune femministe la mostruosità di Dominique Pelicot non sarebbe altro che “la punta dell’iceberg”. In sostanza, tutti gli uomini sarebbero colpevoli e malati della loro mascolinità. Questo termine, apparso negli anni Ottanta, sarà poi definito dallo psichiatra Terry Kupers come una “costellazione di tratti maschili socialmente aggressivi che servono a incoraggiare il dominio, la svalutazione delle donne, l’omofobia e la violenza gratuita”. Tuttavia, la mascolinità tossica comprende nel linguaggio militante altre attitudini e inattitudini, come l’istinto protettivo, lo spirito di conquista o l’incapacità di piangere. “In questo senso, questa espressione demonizza indiscriminatamente tutti gli esseri dotati di un’escrescenza tra le gambe”, deplora Noémie Halioua. Organizzare un barbecue o bere una birra tutta d’un fiato in uno spogliatoio di rugby – esercizio a cui si è prestato Emmanuel Macron e che ha fatto reagire Sandrine Rousseau – finiscono nello stesso cesto della biancheria sporca di un uomo condannato per aver organizzato gli stupri della propria moglie. Noémie Halioua si rammarica che non esista un equivalente femminile della mascolinità tossica. “Come se le madri che maltrattano, le donne jihadiste e le reclutatrici di prostitute avessero qualcosa da invidiare ai molestatori della metropolitana e ai serial killer”, scrive. Secondo lei, questa negazione suggerisce che solo gli uomini sarebbero affetti da un male ontologico. Il che è falso, ovviamente.
Raccomandazione: al posto di “mascolinità tossica”, la redattrice suggerisce piuttosto di utilizzare, a seconda delle situazioni, i termini e le espressioni “dominazione sessuale”, “violenza” e “maleducazione”.
Benevolenza. La “benevolenza”, interpretata dal filosofo Philippe de Lara, è uno di quei termini che fioriscono tra i banchi di scuola, nel management, nella medicina e nella politica. Definito in senso filosofico come “la volontà di perseguire il bene degli altri” e come “la capacità umana di provare le gioie e le sofferenze altrui”, oggi il suo significato appare quantomeno confuso. Si usa per indicare buone pratiche manageriali, un nuovo fondamento istituzionale o un metodo politico innovativo? Una cosa è certa, come sottolinea Philippe de Lara, questo termine è ormai associato al “concetto correlato di accompagnamento”: quello dei dirigenti in burn-out, dei morenti, degli studenti e delle famiglie in difficoltà. Solo che il suo utilizzo serve soprattutto a nascondere la miseria. Nel 2016, la sociologa Monique Dagnaud scriveva che la benevolenza “naviga come una formula retorica destinata a camuffare i rapporti sociali carichi di tensione”. Cerchiamo di non essere troppo severi: la nuova benevolenza vuole essere sinceramente fonte di benessere. E’ tuttavia deplorevole che la sua istituzionalizzazione, come scrive Philippe de Lara, “la renda una norma opprimente”, quasi un’ingiunzione, nascosta “sotto lo zucchero dei buoni sentimenti”.
Raccomandazione: nel suo nuovo significato, è difficile trovare un sinonimo a questo termine che “è un parassita del vecchio”, che in teoria designa la bontà, la generosità e l’indulgenza.
(Traduzione di Mauro Zanon)
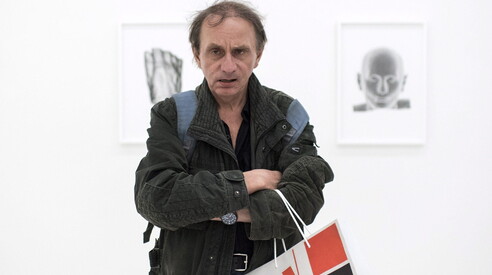
Il Foglio internazionale
L'intervento di Houellebecq: “Dal diritto al dovere di morire”


Un Foglio internazionale


