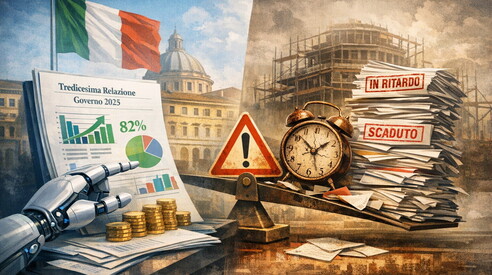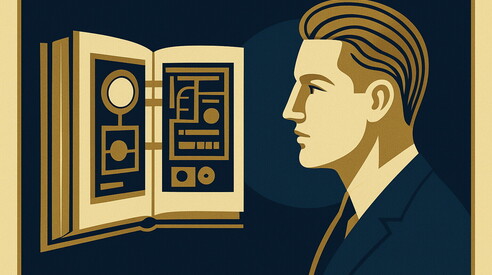
il foglio ai
Un libro da leggere per capire perché l'AI non sostituirà mai la scrittura vera
“Il diritto di odiare” mostra dove finisce l’intelligenza artificiale: una prosa che non inciampa mai, ma nemmeno respira
Non è un brutto libro, "Il diritto di odiare". E’ un libro senz’anima, che è peggio. Un libro nato con un’intenzione intelligente – difendere la libertà di parola fino alle sue zone più scomode – ma cresciuto come un bonsai: educato, controllato, potatissimo. E infatti perfetto, nel senso clinico del termine. E’ il primo volume di una collana che dichiara di voler “scrivere insieme all’intelligenza artificiale”. L’idea, onestamente, è curiosa. La realizzazione, inevitabilmente, fa sorridere. Perché se da un lato la macchina garantisce una precisione impeccabile, dall’altro toglie al testo tutto ciò che lo rende letteratura: il rischio, l’imperfezione, la voce. Il risultato è una prosa che non inciampa mai, ma nemmeno respira. Le pagine scorrono come un algoritmo ben addestrato: frasi limpide, concetti logici, riferimenti inappuntabili. Tutto giusto, tutto calibrato, tutto prevedibile. E’ un libro che sa tutto, tranne come sorprendere. Eppure, non va liquidato. "Il diritto di odiare" è prezioso proprio perché fallisce con eleganza. Mostra cosa accade quando l’AI prova a sostituirsi alla mente creativa: costruisce argomenti impeccabili e frasi composte, ma non immagina. La macchina può combinare significati, ma non sceglierne uno da amare.
Il testo è pieno di idee corrette – sul confine tra parola e violenza, sulla tirannia dell’empatia, sulla debolezza di una società che non tollera le emozioni negative – ma tutte dette con un tono da conferenza universitaria alle nove del mattino. L’AI capisce il concetto di libertà, ma non la vertigine che comporta. Parla di odio come di una categoria morale, non come di un istinto che brucia. Lo analizza, non lo riconosce. E questo, alla fine, è il motivo per cui Il diritto di odiare è utile: è il libro che dimostra, senza volerlo, che l’intelligenza artificiale può sostituire lo scrittore solo quando lo scrittore rinuncia a essere vivo. E’ la civiltà perfetta, quella che elimina i conflitti, e quindi anche le scintille. Tutto è ponderato, bilanciato, filtrato. Nessuna contraddizione, nessun paradosso, nessuna follia. Ma la scrittura creativa vive di questo: del momento in cui la logica cede al ritmo, l’argomento al respiro, la ragione all’immagine. La macchina può fare l’analista, non il poeta. Chi lo legge si accorge che la scrittura non è solo concatenazione di concetti, ma un atto di coraggio, di perdita, di scoperta. L’AI, per ora, non conosce nessuna di queste cose. Scrive con convinzione, ma senza rischio.
Alla fine della lettura si prova un sentimento curioso: non disprezzo, non noia, ma gratitudine. Perché in quelle frasi perfette, in quella voce così lucida e priva di corpo, si riconosce tutto ciò che la scrittura umana ancora può – e deve – difendere. La parola che trema. Il silenzio che pesa. L’imprecisione che commuove. Il diritto di odiare non è un libro da amare, ma da tenere sul comodino come un avvertimento: così scrive la macchina quando l’uomo smette di metterci dentro la pelle. E per fortuna, la letteratura – quella vera – non ha ancora imparato a compiacere un algoritmo.