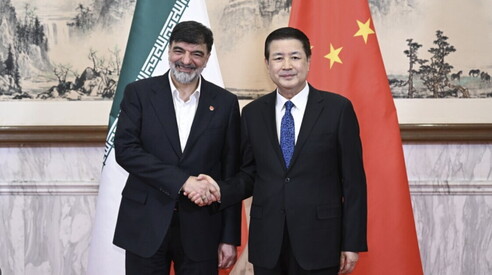Foto Getty
Oltre il coraggio
Il collasso del regime iraniano è probabile, la democrazia molto meno. Dentro ai gangli del potere
"Ciò in cui l’Iran sta entrando non è il finale di una rivoluzione ma un interregno pericoloso – uno in cui la brutalità si è dimostrata efficace, la legittimità è evaporata e il futuro rimane profondamente contestato". Questo saggio di Siamak Namazi è stato pubblicato sul Middle East Institute
Le ultime settimane in Iran ci hanno impartito di nuovo lezioni che già conoscevamo – lezioni scritte nel sangue, nel coraggio, nel rinnegamento e nella crudeltà. Ci è stato ricordato che l’inettitudine del regime teocratico nel governare è pari soltanto alla sua attitudine alla repressione e agli omicidi di massa. Gli eventi hanno dimostrato ancora una volta che sebbene la stragrande maggioranza degli iraniani sia totalmente stufa del governo clericale e capace di un coraggio sbalorditivo, resta comunque sopraffatta da uno stato la cui strategia di sopravvivenza è semplice e spietata: uccidere abbastanza persone, abbastanza velocemente, da terrorizzare gli altri fino alla sottomissione. Abbiamo anche visto che l’opposizione in esilio rimane profondamente frammentata.
I suoi leader sono spesso privi di esperienza nell’organizzare la resistenza civile e, cosa ancora più preoccupante, sono incapaci di comprendere quanto il regime sia pronto a massacrare i propri cittadini. Abbiamo visto persone, da tempo note per il loro patriottismo, che sono diventate tanto disperate da dichiarare apertamente che accoglierebbero favorevolmente un intervento militare straniero – benché non abbiamo un modo affidabile di misurare quanto sia diffuso realmente questo sentimento. E ancora una volta è diventato chiaro che gli iraniani non possono contare sul presidente degli Stati Uniti – o su qualsiasi potenza straniera – per proteggerli dall’essere massacrati, non importa quanto chiaramente o ripetutamente tali assicurazioni possano essere state fatte.
Al momento in cui scrivo, la Repubblica islamica ha imposto il silenzio nelle strade attraverso uccisioni di massa e quello che equivale alla legge marziale. Per nascondere la portata della violenza e paralizzare la capacità della popolazione di organizzarsi o comunicare con il mondo esterno, il regime ha chiuso internet e sta tentando di disturbare le connessioni Starlink. Continuano a emergere segnalazioni di forze di sicurezza che fanno irruzione nelle abitazioni e nei condomini per rimuovere le parabole satellitari, mentre vengono allestiti posti di blocco per perquisire i telefoni dei cittadini alla ricerca di immagini che documentano la carneficina. Nonostante ciò, immagini e video delle forze del regime che compiono uccisioni atroci – incluso l’uso di mitragliatrici pesanti – continuano a trapelare, assieme alle foto dei cadaveri ammassati negli obitori. Le testimonianze oculari e i resoconti dei medici – alcuni ora fuori dal paese, altri in grado di effettuare rare chiamate internazionali – stanno aumentando. Alcune organizzazioni per i diritti umani hanno confermato l’identità di quasi quattromila civili uccisi, mentre report credibili dicono che il bilancio reale potrebbe essere da tre a cinque volte superiore, avvicinandosi a 20 mila uomini, donne e bambini massacrati in pochi giorni. Questa cifra non s’avvicina nemmeno al numero molto più ampio di civili disarmati rimasti permanentemente feriti, spesso colpiti deliberatamente agli occhi o all’inguine – metodi a lungo prediletti dall’apparato di sicurezza del regime, che sta anche facendo irruzione negli ospedali per dare la caccia e imprigionare i feriti.
Come se tutto questo non bastasse, il regime ha chiesto il rimborso per il costo del massacro. Le famiglie che localizzano i corpi dei loro cari dopo aver setacciato centinaia di cadaveri accatastati negli obitori sono costrette a pagare una cosiddetta “tassa per i proiettili” per recuperare i resti per la sepoltura – a meno che non accettino di dichiarare (mentendo) che il defunto era un membro della Forza di resistenza Bassij (un’organizzazione paramilitare di volontari legata al Corpo delle Guardie rivoluzionarie islamiche) ucciso dai “rivoltosi”. Il regime ha ricacciato le persone nelle loro case con la forza bruta. Ma ciò che non può continuare non continuerà.
Perché lo status quo non può reggere
La repressione può aver fatto tacere le strade, ma non ha ripristinato l’equilibrio. L’ultima insurrezione non è scoppiata nel vuoto. E’ stata innescata dall’ennesimo crollo repentino della valuta nazionale – uno choc fin troppo familiare che, questa volta, ha spinto i bazaari (commercianti) nelle strade. Poco prima, erano emersi report secondo cui una delle principali banche private iraniane era di fatto fallita ed era stata “salvata” venendo incorporata in una più grande istituzione statale. Questo era in gran parte teatro. In realtà, l’intero sistema bancario iraniano è insolvente, i suoi bilanci sono sostenuti dalla finzione più che da beni reali.
Otto anni di prigionia nella famigerata prigione di Evin in Iran accanto a esponenti del regime – inclusi alti funzionari, uomini d’affari ben collegati e banchieri – mi hanno offerto un’educazione senza filtri su come funziona questo sistema. L’Iran manca di un vero sistema di informazione creditizia, quindi i grandi prestiti sono garantiti quasi esclusivamente tramite atti di proprietà. Nel tempo, i mutuatari con connessioni politiche hanno perfezionato uno schema: corrompevano i periti per gonfiare i valori immobiliari, a volte fino a dieci volte, ottenevano prestiti massicci e, quando arrivava il momento del rimborso, semplicemente consegnavano la proprietà alla banca. La banca vendeva poi questi asset tossici a un’altra banca realizzando un profitto sulla carta, che registrava. La seconda banca sapeva di stare acquistando spazzatura, ma giocava lo stesso gioco al contrario – scaricando i propri asset tossici e registrando un altro guadagno fittizio. Il risultato è uno schema Ponzi a circuito chiuso, sostenuto da un inganno reciproco e dalla complicità normativa. Questa pratica si è metastatizzata negli ultimi 15 anni ed è molto più estesa di quanto questa descrizione semplificata suggerisca. E questo riguarda solo il sistema bancario. Gran parte del resto dell’economia iraniana è afflitta da corruzione e cattiva gestione altrettanto radicate. Questo decadimento finanziario rispecchia una crisi di governance altrettanto profonda. Negli ultimi due decenni, La Guida suprema, Ali Khamenei, ha sostituito sistematicamente tecnocrati semicompetenti e figure militari esperte con lealisti, elevando l’obbedienza sopra la capacità. Il risultato è una cachistocrazia (il governo dei peggiori) da manuale: proprio nel momento in cui il paese affronta sfide esistenziali, coloro che sono incaricati di gestirle sono spesso i meno qualificati per farlo.
L’Iran sta esaurendo l’acqua. La sua rete elettrica sta cedendo. Lo stato fatica a fornire beni di base, figuriamoci riparare il suo isolamento internazionale o abbattere l’inflazione. Per anni, il regime ha difeso questi fallimenti indicando un ultimo pilastro rimanente di legittimità: la sicurezza. Anche quel pilastro è ora crollato. L’esito umiliante della recente guerra israelo-iraniana durata dodici giorni ha frantumato l’ultimo residuo del contratto sociale implicito del regime. Oggi, si ritiene che circa l’80 per cento degli iraniani consideri il sistema come illegittimo. Nel migliore dei casi, il 20 per cento può essere contato come sostenitori del regime – e anche all’interno di questo gruppo, molti non sono disposti a uccidere i loro concittadini per preservarlo. In un paese di circa 93 milioni di persone, quasi 80 milioni sono effettivamente tenuti in ostaggio da una piccola minoranza violenta. Questo non è un equilibrio stabile.
Perché il 1979 è l’analogia sbagliata
Nei primi giorni delle proteste di massa, molti osservatori prevedevano l’imminente collasso del regime. Dopo che lo stato è riuscito ancora una volta a terrorizzare le persone facendole uscire dalle strade, un crescente corpo di analisi si è spostato nella direzione opposta, enfatizzando la durabilità del regime e sottolineando quanto il momento attuale sia diverso dal 1979, quando Mohammad Reza Shah Pahlavi fu rovesciato. Per molti aspetti, queste differenze sono reali. Lo Shah, nonostante tutti i suoi fallimenti politici, alla fine scelse di lasciare l’Iran piuttosto che aggrapparsi al potere attraverso massacri di massa. L’establishment clericale e le Guardie della Rivoluzione non hanno tali remore. Nel 1979, l’opposizione era anche molto più unita e organizzata di quanto lo sia oggi. Gli analisti notano inoltre che molti alti funzionari sotto lo Shah furono in grado di trovare rifugio in occidente e riprendere le loro vite professionali dopo aver perso il potere, mentre i funzionari dell’odierna Repubblica islamica – molti con le mani macchiate di sangue – non hanno dove fuggire e, pertanto, vedono la lotta in termini esistenziali: uccidere o essere uccisi.
Tutto questo è sostanzialmente corretto. Ma manca la distinzione più importante di tutte. Il governo dello Shah, qualunque fossero i suoi difetti politici, era competente secondo gli standard regionali. L’Iran alla fine degli anni Settanta era economicamente dinamico, internazionalmente coinvolto e ampiamente rispettato. Non era uno stato paria svuotato da sanzioni, corruzione istituzionalizzata e cattiva gestione sistemica. L’odierna Repubblica islamica è l’opposto. Il paragone con il 1979 è, quindi, non semplicemente incompleto – è fuorviante. La situazione in Iran attualmente non assomiglia a quella sotto la monarchia nei suoi ultimi anni. Ma un regime che ha perso competenza, legittimità e credibilità – in patria e all’estero – non può sostituire indefinitamente la pura violenza alla governance. La Repubblica islamica ha finito l’asfalto e non durerà, almeno non nella sua forma attuale, ancora per molto.
La variabile centrale: la fine dell’èra Khamenei
Tutti gli scenari che seguono sono condizionati da un fattore predominante: se – e quando – Ali Khamenei uscirà di scena. Un vero cambiamento in Iran non emergerà finché Khamenei rimane al comando. Da quando ha assunto la posizione di leader supremo nel 1989, ha dimostrato – ripetutamente e in modo conclusivo – che non permetterà un’evoluzione politica significativa all’interno della Repubblica islamica, figuriamoci una trasformazione democratica del paese. Di fronte a pressioni interne, collasso economico o isolamento internazionale, la sua risposta è stata costante: sopprimere, emarginare, imprigionare o uccidere – qualunque cosa sia necessaria per preservare uno status quo che lui solo definisce, anche quando quello status quo è diventato palesemente insostenibile.
Khamenei ha sistematicamente eliminato o neutralizzato ogni figura all’interno del sistema che mostrava segni di indipendenza o ambizione riformista. Presidenti, ministri, chierici, tecnocrati e comandanti hanno tutti imparato la stessa lezione: l’adattabilità è slealtà; la competenza è secondaria all’obbedienza. La cachistocrazia che ora definisce la Repubblica islamica non è un incidente – è il prodotto diretto della filosofia di governo di Khamenei. L’Iran sta già vivendo all’ombra di un ordine post Khamenei. A 86 anni, si dice che il leader supremo stia trascorrendo gran parte del suo tempo nascosto dopo che i recenti attacchi israeliani hanno decimato i vertici militari. La pianificazione della successione ha occupato silenziosamente – ma intensamente – il sistema politico per anni. Ciò che rimane incerto è la tempistica, e la tempistica conta enormemente. Un crepuscolo prolungato – caratterizzato da un’autorità in declino ma dalla sopravvivenza continua – probabilmente rafforzerebbe la repressione, incentiverebbe l’avversione al rischio delle élite e ritarderebbe fratture significative all’interno del regime. Al contrario, la partenza improvvisa di Khamenei – sia per cause naturali sia altrimenti – rappresenterebbe un genuino punto di svolta. Non garantirebbe un cambiamento democratico, ma rimuoverebbe il singolo più efficace detentore di veto contro di esso. Un Iran post Khamenei rimodellerebbe il contesto politico in cui opera ogni altra variabile.
Cosa viene dopo, e da cosa dipende
La domanda, quindi, non è se la Repubblica islamica possa tornare allo status quo ante – non può – ma cosa sostituisca l’attuale impasse, quanto duri questa fase e a quale costo. Il collasso del regime nella sua forma attuale ora sembra più plausibile della sua sopravvivenza come stato funzionante. Eppure l’emergere di un Iran democratico rimane tutt’altro che certo. Tra questi due esiti giace un terreno intermedio volatile e pericoloso. Molto dipenderà da quattro fattori.
Il primo è l’intervento straniero. Se e come gli Stati Uniti e altri attori esterni scelgano di intervenire modellerà – ma non determinerà – la traiettoria dell’Iran. Attacchi militari limitati difficilmente, da soli, faranno cadere il regime, soprattutto in assenza di una strategia politica più ampia. Un’invasione di terra è implausibile, e il record degli Stati Uniti nel produrre democrazia attraverso la forza non è incoraggiante. Inoltre, sarebbe un errore presumere che le priorità di Washington si allineino con le aspirazioni del popolo iraniano. Le decisioni del presidente Donald Trump saranno guidate prima da calcoli personali e politici, poi dagli interessi percepiti degli Stati Uniti. Un accordo con elementi del regime esistente – o con un uomo forte emergente dall’interno delle Guardie della Rivoluzione – in cambio di concessioni su petrolio, questioni regionali o contenimento nucleare rimane un’opzione. Tale sviluppo potrebbe convenire a questa Amministrazione ma farà poco per il popolo iraniano e quindi è improbabile che produca vera stabilità.
Il secondo è il comportamento dell’opposizione. La popolarità simbolica non equivale alla capacità organizzativa: Mentre figure come Reza Pahlavi, il figlio del defunto Shah e principe ereditario, richiamano attenzione e hanno una risonanza emotiva tra alcuni segmenti della popolazione, l’opposizione nel suo complesso rimane frammentata e divisa da profonda sfiducia. L’opposizione all’estero, in particolare, è anche inesperta nel guidare una resistenza civile sostenuta. Inoltre, la reale posizione di Pahlavi all’interno dell’Iran rimane poco chiara all’indomani di una mobilitazione terminata in una repressione di massa. Molte persone hanno risposto al suo appello a protestare solo per affrontare il massacro. Se quell’esperienza abbia rafforzato o indebolito la sua credibilità è sconosciuto, ma quest’ultima ipotesi sembra molto più probabile. E’ anche impossibile determinare quanti di coloro che scandivano il suo nome lo abbiano fatto per genuina convinzione politica, e quanti lo abbiano fatto semplicemente per amplificare la voce dell’opposizione disponibile più forte in un momento di disperazione. All’interno dell’Iran – e anche all’interno della diaspora – esiste un’ampia base il cui principale orientamento politico non è la fedeltà a un particolare leader ma la convinzione che quasi qualsiasi cosa sarebbe preferibile al regime attuale.
Il terzo fattore è il controllo dell’informazione e della connettività. Il coraggio senza coordinamento non può espandersi. La capacità del regime di chiudere internet, disturbare le comunicazioni satellitari e recidere i collegamenti tra città e regioni rimane uno dei suoi strumenti più potenti. La mobilitazione sostenuta, gli scioperi nazionali e l’azione collettiva dipendono tutti dalla comunicazione. Finché lo stato mantiene un controllo quasi totale sui flussi di informazione, i movimenti popolari faticheranno a tradurre l’indignazione in pressione duratura. Il quarto fattore riguarda le dinamiche delle élite all’interno del regime stesso. La Repubblica islamica non è monolitica: dall’interno assomiglia a un sistema basato sul clientelismo in cui le fazioni competono principalmente per risorse e sopravvivenza. Eppure la storia mostra che quando si trovano di fronte a una minaccia esistenziale, queste fazioni si sono serrate nei ranghi e hanno coordinato la repressione. Un cambiamento significativo richiederà fratture all’interno del nucleo duro del regime – particolarmente all’interno dei servizi di sicurezza. Tali fratture sono improbabili finché gli insider credono di non avere via d’uscita e nessun futuro al di fuori del sistema, ma se quei calcoli dovessero cambiare, l’equilibrio potrebbe spostarsi rapidamente.
Dove risiede la speranza per un Iran democratico
Se l’Iran deve emergere da questa crisi come una vera democrazia – piuttosto che la Repubblica islamica con un leader diverso, un uomo forte militare o un altro assetto autoritario – la fonte di quella trasformazione conta tanto quanto la sua tempistica. La speranza più credibile per un Iran democratico risiede all’interno del paese, tra i suoi attivisti civili, studenti, professionisti, gruppi di donne e insider orientati alle riforme che comprendono come l’Iran funzioni realmente. Decenni di governo corrotto e coercitivo hanno trasformato l’Iran in un sistema bizantino da governare. Qualsiasi transizione democratica di successo richiederà una conoscenza intima dell’economia politica del paese, delle sue reti d’élite, della sua burocrazia e – cosa più critica – la capacità di assicurare almeno la cooperazione passiva da grandi parti dello stato e dell’apparato di sicurezza. Non è una cosa che può essere orchestrata dall’estero.
Mentre le figure dell’opposizione in esilio possono amplificare le voci, mobilitare l’attenzione internazionale e aiutare a coordinare la pressione esterna, mancano della conoscenza radicata e della leva operativa necessarie per governare un paese così vasto e diverso. Cosa ancora più importante: è improbabile che i leader nella diaspora saranno in grado di ottenere la lealtà – o anche la conformità – della burocrazia o dell’esercito iraniano da soli. In un mondo ideale, le forze democratiche all’interno dell’Iran e i sostenitori all’esterno del paese lavorerebbero in stretta coordinazione: gli attori interni forniscono legittimità, organizzazione e continuità, mentre gli attori esterni offrono risorse, protezione e leva diplomatica. Insieme, potrebbero aiutare a sbloccare l’immenso potenziale politico, economico e internazionale dell’Iran. Ma l’Iran è ancora lontano da quel punto.
Un interregno pericoloso
La Repubblica islamica come la conosciamo non può durare. Tuttavia, il suo collasso o trasformazione non garantisce la liberazione. Ciò in cui l’Iran sta entrando non è il finale di una rivoluzione ma un interregno pericoloso – uno in cui la brutalità si è dimostrata efficace, la legittimità è evaporata e il futuro rimane profondamente contestato. La tragedia non è che agli iraniani manchi il coraggio: è che il coraggio da solo non è sufficiente.
Siamak Namazi è un ex manager che oggi fa consulenze a leader per gestire crisi e fasi di incertezza. E’ stato ostaggio in Iran dal 2015 al 2023.
Questo saggio è stato pubblicato sul Middle East Institute.