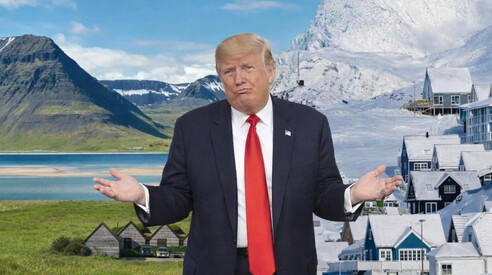Google Creative Commons (Wikipedia)
Il libro
Un islam che combatte l'antisemitismo: la lezione tedesca che manca all'Italia
Il pensiero di Mouhanad Khorchide, che propone una rilettura storica e misericordiosa del Corano, che smonta l’antisemitismo teologico, che invita i musulmani a riconoscere il debito verso l’ebraismo, sarebbe probabilmente ignorato, se non osteggiato, nelle nostre aule
Nei giorni scorsi, in una libreria di Lipsia, mi sono imbattuta in un volume dal titolo coraggioso: “Senza ebrei, nessun islam” di Mouhanad Khorchide. Inutile dire che l’ho acquistato e letto con la voracità di chi, finalmente, si trova davanti non soltanto un libro, ma un messaggio teologico e politico di rara audacia: affermare che l’islam, lungi dall’essere una religione in opposizione all’ebraismo, ne è in larga parte figlio. L’autore è professore di pedagogia religiosa islamica all’Università di Münster e da anni è una delle voci più lucide del pensiero musulmano europeo. Quanto mi piacerebbe invitarlo a una mia lezione all’Università di Torino! Ma non è questo il punto. Il punto è che in Germania si può scrivere un libro che smonta l’antisemitismo teologico, che sprona i musulmani a riconoscere il debito verso l’ebraismo, che propone una ridefinizione dell’identità palestinese non più fondata sull’opposizione, ma sulla costruzione. E lo si può dire da una cattedra universitaria, con il sostegno delle istituzioni, dentro un contesto che ha fatto della memoria ebraica un pilastro della sua democrazia, ma che al contempo non teme di chiedere agli islamici di riconoscere il diritto di Israele a esistere.
In Italia, non è così semplice. Il pensiero di Khorchide – che propone una rilettura storica e misericordiosa del Corano, che smonta l’antisemitismo teologico, che invita i musulmani a riconoscere il debito verso l’ebraismo – sarebbe probabilmente ignorato, se non osteggiato, nelle nostre aule. Mentre, nelle piazze, l’islam viene trattato come questione di sicurezza e di integrazione, oppure esaltato in chiave politica in opposizione a Israele. E le voci riformiste, penso a Yahya Pallavicini ad esempio, faticano a trovare ascolto. Eppure, è proprio da questa articolazione che potrebbe nascere una nuova grammatica del confronto. Il libro di Khorchide, pubblicato nel 2025, e quindi nel pieno della crisi di Gaza e del riemergere di un antisemitismo generalizzato, affronta le interpretazioni coraniche che sono state strumentalizzate per giustificare l’odio antiebraico e propone una teologia in cui il messaggio islamico viene liberato dalle incrostazioni ideologiche, riportandolo alla sua vocazione originaria: quella di riconoscere l’altro, di costruire ponti, di cercare la giustizia. Ma il passaggio più intenso e, forse, più politico del libro riguarda la Palestina.
Khorchide, da figlio di palestinesi, propone una ridefinizione profonda dell’identità del suo popolo. Per troppo tempo, dice, l’identità palestinese è stata costruita in opposizione: contro Israele, contro l’Occidente, contro l’ebraismo. Ma un’identità che nasce dal rifiuto dell’altro è destinata a restare prigioniera del conflitto. Serve un cambio di paradigma: non più vittime, ma soggetti; non più oppositori, ma costruttori. L’identità palestinese deve riscoprirsi come narrazione positiva, capace di generare cultura, spiritualità, visione. Non si tratta di rinunciare alla lotta per i diritti, ma di cambiare lo sguardo. Gli ebrei, gli israeliani (peraltro non tutti ebrei), devono essere riconosciuti come interlocutori, non come nemici ontologici. È una proposta che può sembrare utopica, ma che ha radici profonde nella spiritualità islamica e nella tradizione profetica.
Una riflessione particolarmente significativa arriva nel capitolo VII del libro, dedicato agli Accordi di Abramo. Khorchide li interpreta non solo come svolta geopolitica, ma come opportunità teologica. Il nome stesso — Abramo — richiama la radice comune tra islam, ebraismo e cristianesimo. Può diventare, scrive, “una piattaforma per ripensare il rapporto con l’altro, non in chiave diplomatica, ma spirituale”. Gli Accordi, pur controversi, mostrano che il dialogo è possibile e che la normalizzazione non è necessariamente tradimento, ma può essere gesto di riconoscimento. Khorchide invita pertanto i musulmani a non leggere questi processi come resa, ma come occasione per ridefinire la propria identità in chiave generativa. Anche qui, la Palestina è al centro: “I palestinesi — scrive — non devono rinunciare alla memoria, ma devono imparare a raccontarla in modo da aprire il futuro, non da chiuderlo”. È una teologia del futuro, che non nega il conflitto, ma lo attraversa con la forza della narrazione condivisa.
In Germania — un paese segnato dalla Shoah — con la presenza di una comunità ebraica rinata e di una comunità musulmana numerosa, questa proposta acquista una forza particolare. Dire che l’islam deve riconoscere l’ebraismo come parte della propria identità è un gesto che rompe non solo con l’ortodossia religiosa, ma anche, e forse soprattutto, con le narrazioni politiche dominanti. Nel momento in cui il conflitto israelo-palestinese sembra non vedere la fine e in cui l’antisemitismo torna a manifestarsi nelle piazze europee e persino a Berlino, il pensiero di Khorchide ci obbliga a fare i conti con le identità che costruiamo. La sua proposta di ridefinizione dell’identità palestinese — non più fondata sull’opposizione, ma sulla costruzione — è una sfida che riguarda tutti. Perché anche noi, in Europa, tendiamo a definire l’altro per negazione: il musulmano come non-europeo (anche se all’islam ci si può convertire), l’ebreo come non-italiano (purtroppo accade sempre più sovente), l’arabo come non-israeliano (quando invece più del 21% dei cittadini israeliani sono arabi) e l’israeliano come non-umano (posizione che ricorda le vignette antisemite naziste e che, grazie ai social, sta tornando in voga).
Invece, con semplicità disarmante, questo professore dell’Università di Münster, nato in Libano da genitori palestinesi e cresciuto in Arabia Saudita, dalla sua cattedra e dalle pagine del suo libro ci invita a pensare all’identità non come reazione, ma come generazione. E lo fa da un luogo — la Germania — che ha saputo trasformare la propria storia in spazio di riflessione. Forse è questo che manca all’Italia: il coraggio di fare della propria memoria un terreno di dialogo, anziché di rimozione. Nelle nostre università, invece, si lascia spazio ai boicottaggi, talvolta li si pianifica nei senati accademici. Pare quasi che, come docenti, ci si preoccupi più di aderire a una postura ideologica che di educare al pensiero critico. Si sostengono condanne mascherandole da dissenso politico — sempre contro lo stesso governo, mai contro quello russo o iraniano — e, magari senza volerlo, si contribuisce alla rinascita dello stereotipo del nemico. Anche in questo caso, sempre lo stesso: l’ebreo. L’ebreo che, in quanto tale, diventa complice di chi “uccide i bambini”. Una narrazione tossica, che ricorda certe ossessioni complottiste: una sorta di “Parlateci di Bibbiano” in versione geopolitica, con sfumature da medico vaccinista che avvelena i giovani “punturati”. Appare tristemente evidente che, in Italia, al contrario della Germania, la pedagogia dell’odio non solo trova spazio: attira consensi.
Eppure basterebbe poco, se ci fosse la volontà. Sarebbe sufficiente riconoscere che la questione palestinese non si risolve con slogan, come afferma Khorchide: “Anziché strumentalizzare continuamente il passato per legittimare il presente, occorrono narrazioni del futuro. I palestinesi non dovrebbero parlare solo di resistenza, ma anche di riconciliazione, sviluppo e dignità. Non da ultimo, anche la società civile svolge un ruolo indispensabile. I progetti che rendono possibili incontri tra palestinesi ed ebrei dimostrano quanto possano essere potenti le testimonianze personali. Il dialogo spesso non nasce nelle conferenze, ma nella condivisione di storie di perdita, speranze e umanità.” E chiude con una riflessione che facciamo nostra: “L’identità araba, soprattutto quella palestinese, si trova a un punto di svolta storico. Può rimanere nella logica della negazione e del vittimismo oppure reinventarsi come soggetto di pace, creatività e dialogo globale. Una tale ridefinizione non significa tradire la storia, ma trasformarla in futuro. Richiede coraggio, leadership visionaria e speranza.” Certo, anche le nostre università avrebbero questa possibilità. Non si tratta di importare modelli dalla Germania, ma di assumersi una responsabilità: quella di trasformare lo spazio accademico in luogo di elaborazione. Di riconoscere che la questione palestinese, come quella ebraica, non può essere lasciata alle semplificazioni ideologiche. Khorchide ci mostra che in Germania si può fare. Il problema, da noi, è che pare non si voglia nemmeno tentare.