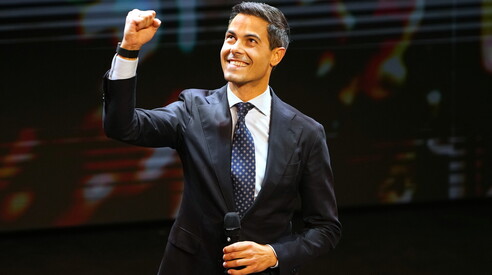foto di Gery Palazzotto)
il racconto
Con la Spagna sotto i piedi. Incubare i pensieri sulla Via de la Plata
Mille chilometri da Siviglia a Santiago in un percorso che è il meno frequentato dai pellegrini. Un viaggio lento e solitario che allena il corpo e allarga la mente, cani e chilometri che si moltiplicano
Provate a immaginarvi con uno zaino in spalla, su una striscia di terra assolata, con una temperatura di 40 gradi e nulla intorno nel raggio di dieci chilometri. Immaginate di non soffrire: il caldo è fuori, la fatica non vi interessa, la mente è impegnata a pensare senza interferenze.
Siete su un cammino come la Via de la Plata – l’itinerario che ho scelto quest’anno, mille chilometri da Siviglia a Santiago – e state sperimentando il migliore effetto collaterale di una missione in solitaria: la coltivazione intensiva dei pensieri. I cammini sono un ottimo incubatore di sensazioni. Regalano momenti in cui ne afferrate un paio, possibilmente le più piacevoli, le mettete dentro e quelle fanno il loro lavoro come raramente gli è consentito. Non devono slalomare tra incombenze concorrenti, non devono farsi spazio tra ingombri pratici. Si fanno abito e si lasciano indossare.
Ecco, per inquadrare un’esperienza come quella della Via de la Plata può essere utile considerare che molte delle nostre occasioni mancate sono figlie di pensieri che abbiamo pesato male o che non abbiamo lasciato crescere con la giusta tridimensionalità. E se ci è capitato di derubricare la speranza a illusione rimandata, è accaduto a bocce ferme, con le endorfine a picco, raggomitolati nella tana della pigrizia: difficile che succeda durante un cammino.
Fine del prologo motivazionale.
La Via de la Plata è un cammino che si dipana in gran parte sulle tracce di un’antica via romana da Siviglia a Santiago: si percorre in una quarantina di giorni. Il nome non deriva dalla presenza di miniere o dal commercio di argento (in spagnolo plata, appunto), ma dall’arabo balat, cioè pietra levigata, di cui l’antica strada era lastricata e di cui ancora oggi fa bella mostra in alcuni tratti. Secondo le stime ufficiali la Via de la Plata è la meno frequentata delle grandi rotte giacobee, con novemila pellegrini nel 2024. La parte del leone la fa il Cammino Francese con 236.380, seguito dal Portoghese con 95.453.
L’itinerario va da sud a nord, camminerete sempre col sole a destra e questo influirà sulle vostre abitudini: lato dello zaino in cui posizionare la borraccia, protezione solare rafforzata e via dicendo.
L’Andalusia segna l’inizio, l’Estremadura mantiene la promessa che sta già nel suo nome giacché è inesorabilmente estrema e dura, la regione di Castilla y Leon appare quasi come un’oasi, e l’ultimo tratto, quello della Galizia, è tutta una discesa psicologica verso la meta che in certi momenti pare un miraggio. Il caldo è il nemico da battere, non già la fatica di milioni di passi con un peso di dieci chili in spalla. Per i muscoli esiste sempre un allenamento, per la sete no. Per questo la Via de la Plata è il cammino più impegnativo. Va preparato accuratamente dal momento che molte tappe non hanno centri abitati intermedi e sono prive di fonti d’acqua, quindi si procede con scorte adeguate che hanno un difetto: costituiscono chili aggiuntivi da portare appresso.
I primi duecento chilometri sono talmente roventi da giustificare il fatto che gli spagnoli ti servono il vino rosso freddo. Poi, passo dopo passo, si concretizza una strana immersione negli opposti. Più che in altri cammini, la Via de la Plata è selvatica e disagevole, ma al tempo stesso rassicurante in modo inspiegabile. Attraversare universi rurali di venti anime (“con lei stasera siamo in ventuno, benvenuto!”), immergersi in realtà sideralmente distanti dal nostro sistema di relazione sono esercizi non semplici persino per i camminatori abituati a esperienze toste. L’idea degli opposti concilia le mosche, che in terra di allevamenti sono praticamente stipendiate dalla pro loco, con una cerveza gelata al punto giusto, i panorami brulli con l’odore dei tuoi passi: perché sì, i nostri passi hanno sempre un odore e accorgersene è una conquista del viaggiatore lento pede. C’è in queste esperienze qualcosa di magicamente antico che non ha nulla a che vedere con lo spirito di avventura, ma con un influsso più complesso e intimo. E’ la nostra capacità di sorprenderci che si risveglia, è il ridimensionamento dell’illusione di poter risolvere tutto con un clic, è il gusto per il tempo che non scorre mai inutilmente. Ogni passo, ogni goccia di sudore, ogni imprevisto (entro un range di sicurezza blindato), ogni traguardo minimo, foss’anche una cena solitaria con un libro tra le mani, è il premio migliore per chi non cerca altro che un posto in cui voler essere, in quel momento preciso. E c’è. E gli basta. Anche col caldo che ferisce la terra sotto i piedi, anche se sbagli strada e nel corso di una giornata non hai incontrato nessuno-ma-proprio-nessuno che faceva il tuo sentiero, anche se i metatarsi protestano.
C’è poi quello che potremmo chiamare il “teorema delle molliche”: se ti nutrono con minuscoli pezzetti di pane, quando avrai davanti un tozzo ti sembrerà una pagnotta. A metà tra un’abitudine che improvvisamente va a farsi benedire e un puro effetto sorpresa, può accadere di provare una sensazione di autentico sollievo con 35 gradi all’ombra. Perché se il giorno prima ce n’erano 41, la differenza è tutta gioia. Sono le molliche che ti faranno sviluppare gli anticorpi per una fatica che non ha premio immediato. E’ come una maratona senza pubblico e senza banchetti di ristoro, in cui l’unica medaglia, se mai arriverà, te la affibbierai da solo sul petto (più o meno smagrito). E per questo sarà indimenticabile.
Occhio: non c’è niente di eroico, ma molto di infinitamente egoistico. Del resto i sentimenti più puri – lo sappiamo ma non ce lo confessiamo – nascono per soddisfare un’esigenza personale: amiamo perché ci fa stare meglio, diamo aiuto perché ci sentiamo elevati dalle nostre miserie, esercitiamo il perdono perché ci alleggeriamo l’anima.
Un capitolo a parte meritano gli animali. Un giorno, a Riolobos, ho iniziato a camminare salutato dalle cicogne che da quelle parti, molto ben tollerate, quasi accudite, fanno nidi anche sulle chiese. Ho proseguito attraverso un impervio sentiero che mi serviva per scavalcare una collina. Poi ho affrontato alcuni cancelli (si aprono con facilità e ovviamente c’è l’obbligo di richiuderli). I cancelli vogliono dire una cosa sola: ci sono animali liberi in zona. Quindi bisogna fare molta attenzione. Mi è capitato spesso sulla Via de la Plata, pochissimo negli altri cammini. Arrivato a un bivio senza alcuna segnalazione ho fatto la mia scelta, influenzato dal fatto che nell’altra strada (strada…) c’erano una trentina tra mucche e vitelli che non mi ispiravano troppo. Mi sono ritrovato in una prateria con un centinaio di altri bovini, due mandriani appollaiati su una staccionata e soprattutto un cane che a distanza mi pareva grande. Il cane, appena mi ha visto, è partito di corsa verso di me. Momento cruciale: il cane che ti punta può essere un problema. Ho fatto un segnale accompagnato da un fischio ai mandriani, che mi hanno pressoché ignorato: uno ha mosso una mano, almeno così mi è sembrato, per dirmi qualcosa tipo fregatene. Il cane nel frattempo si avvicinava. Mi ero sbagliato: non era grande, era enorme. Non ho fatto in tempo a mollare lo zaino che lui era già addosso a me. Sono caduto e solo allora ho avuto la certezza che aveva sguainato la lingua e voleva giocare. Abbiamo cominciato a rotolare, io con tutto lo zaino e lui con tutta la sua foga divertita, sotto gli sguardi e le risate dei mandriani. Non mi mollava più e io ci avevo preso pure gusto: adoro gli animali (manco li mangio). Per i cani ho una vecchia passione ma coltivo sempre la giusta prudenza. Mai eccedere soprattutto quando sei nel loro territorio: comportati da ospite composto e ben educato. E io, per terra, in un campo popolato da bovini ero tutt’altro che composto. Ma lui era troppo preso dal gioco per perdersi in sottigliezze (a parte due buchi nel braccio per le sue zampate di gioco).
Tre anni fa, lungo la via Francigena, mi capitò un altro incontro ravvicinato di questo tipo. Entrato nella tenuta nella quale avevo prenotato una stanza, un branco di nove cani mi venne incontro abbaiando minacciosamente. Mi preparai ad ammaliarne uno, quello che mi pareva il capo, mettendomi a terra e mostrandomi pronto al gioco, sorridente e lento. Andò bene e anche lì ci furono abbondanti leccate con carezze per tutti e maglietta strappata per la foga. La signora che con calma mi venne ad accogliere disse una frase che lì per lì non pesai bene: “Sono dieci monelli, uno è pure sordo”. Dieci. Io ne avevo contati nove.
La notte rientrando dalla cena rifeci la stessa strada forte del fatto che col branco avevamo fatto conoscenza. Dal buio spuntò un cane ringhiante. Era quello sordo che poche ore prima non c’era. Per fortuna riuscii ad attirare l’attenzione degli altri nove per convincerlo che anche se avevamo saltato le presentazioni la colpa non era mia. La moral suasion ebbe successo e la padrona manco si accorse di nulla.
Dopo molti cammini c’è un fenomeno per il quale non sono ancora riuscito a trovare una spiegazione. Si tratta della moltiplicazione dei chilometri. Tipo, un giorno dovrebbero essere 24, almeno sulla carta, e diventano 30 per un sortilegio che fa migrare le deviazioni e gli aggrovigliamenti dei sentieri oltre i confini del ponderabile. Va tenuto conto che, per dare un’idea, sei chilometri in più sono per un camminatore medio un supplemento di un’ora e mezza di fatica, mica una passeggiatina. Le ho provate tutte per tentare di risolvere il mistero. Ho rifatto i calcoli, ho rivisto le mappe e non sono riuscito a capire dove sta l’errore. Va detto, e so che non è una rivelazione, che più si va avanti nel cammino, più gli ultimi chilometri della tappa pesano. E’ la sindrome del maratoneta, comune a tutti quelli che fanno sport di resistenza: più sei stanco più i pochi passi che mancano all’arrivo sono pesanti. Il vero problema sono le articolazioni che rispondono alle loro regole. I piedi – e non scendo in argomentazioni anatomiche – ti mandano messaggi ineludibili. Ogni giorno richiedono un po’ di più per riprendersi. All’inizio si accontentano di un’oretta di riposo, gambe all’aria. Poi, via via che i chilometri si accumulano, ti dicono: dai, stiamo a letto ancora per un po’, leggi qualche altra pagina del libro. Infine, dopo quattro settimane, vogliono almeno tre ore di inattività e comunque ti devi rialzare con cautela dato che i primi passi dopo il riposo sono da fare con la concentrazione di Giucas Casella sui carboni ardenti.
E’ così che per andare a cena impari a fare programmi improntati al risparmio ortopedico. Un giorno, ad esempio, arrivando a Granja de Moreruela, capita l’antifona del mio stato fisico, ho identificato una tienda (un negozietto ricavato nell’abitazione privata di un tale) che vendeva generi alimentari: un posto che di norma non ti ispirerebbe manco una capatina per la scorta di acqua. In serata ho chiesto al mio padrone di casa del posto più vicino in cui mangiare e, intuita la distanza impossibile causa stanchezza, sono andato a bussare a casa del cristiano della tienda. Che ha fatto il suo mestiere di spacciatore di cibo: non mi sogno di rivelare quello che mi ha propinato, diciamo che siamo appena sopra la soglia del commestibile. Alla fine il ringraziamento non è arrivato dal mio stomaco, ma dai miei piedi.
Alberi, una parvenza di ombra, un clima non proprio amichevole, ma almeno non ostile. Il passaggio da Estremadura a Castilla y León è netto. La quota conquistata – e conquistata non è una parola scelta per caso – si manifesta come una sorta di benedizione per via dell’aria meno rovente. Qui il cammino è tutto intorno ai mille metri sul livello del mare. Il che significa salite, cioè fatica, ma anche temperature più umane, cioè sollievo. Insomma è sempre il solito gioco degli opposti. Si passa dal Pico de la Dueña che coi suoi 1.170 metri è il punto più alto della Via de la Plata, e ci si cimenta in ore e ore di cammino senza tappe intermedie in cui rifocillarsi. Proprio per cercare di dissipare il senso di stanchezza e i residui di un subdolo mal di schiena, a un certo punto ho deciso di inventarmi una tappa fuori percorso e dormire a Salvatierra de Tormes, in un bel hotel rurale immerso nel verde e vicino a un immenso lago artificiale. Per concedermi questo svago sono stato costretto a ricorrere a un passaggio in taxi. Non vi dico l’emozione di trovarmi su quattro ruote per la prima volta dopo quasi un mese di scarpinata. Il tassista era di Guijuelo, una cittadina a una decina di chilometri da Salvatierra. Mi ha accompagnato il pomeriggio e mi ha ripreso la mattina dopo per rimettermi sul percorso. Inevitabile la chiacchierata. Siamo entrati talmente in sintonia che ha deciso di offrirmi un giro turistico nella sua città. E così ha pensato bene di mostrarmi non i monumenti, ma l’anima commerciale di Guijuelo: la produzione di jamon iberico. Con dovizia di dettagli e piglio da guida turistica, il gentile tassista ha spiegato che con le sue 180 aziende di lavorazione del prosciutto la cittadina, oltre 5.000 abitanti, è ai primi posti in Spagna per reddito pro capite, ha un tasso di disoccupazione pressoché nullo e attira lavoratori addirittura da Salamanca. Ha anche detto che ogni giorno a Guijuelo si matano 1.500 maiali, ma anche se fossero stati il doppio il mio sbalordimento non ne avrebbe risentito.
Un cammino è questo. Storie, incontri, convergenze impreviste, resistenza necessaria. Ogni sera in un luogo diverso, non sempre bello e suggestivo, ma che può diventarlo a seconda di come lo guardi. Ogni giorno a muoversi con uno zaino sulle spalle nel quale c’è tutto quello che ti rappresenta, tranne le mura e il letto di casa.
E ti basta.