
Foto Ansa
il giorno dell'Ashura
Così il regime iraniano definisce la formula della sua sopravvivenza
In un paese stremato dalla crisi economica e dalla retorica del martirio, i vertici del regime, da Khamenei a Bagheri, riscoprono parole come “patria” e “popolo” e le predicano nel mese di Moharram. Ma dietro alle diverse cordate che incarnano il potere del regime resta irrisolto il dilemma fondativo: essere una nazione o una causa
In Iran, la regola vuole che tutto si colori di nero e di verde durante il mese di Moharram. Sono neri i drappi che ondeggiano nel vento agganciati ai lampioni, neri gli stendardi fissati sopra alle maioliche all’ingresso delle moschee, neri i vestiti degli uomini che al calar del sole sfilano compatti e si battano il petto cantando e piangendo il martirio dell’imam Hossein. C’è un unico scostamento consentito al colore del lutto in questi giorni ed è il colore dell’islam, e dunque sono verdi le bandiere, i nastri e le cinture, verdi le fascette sulle fronti degli adolescenti, verdi e neri i veli, stretti sulle teste di bambine che avanzano, un po’ impaurite e un po’ trasognate, inseguendo il ritmo dei lamenti con le dita.
Dai giornali alla televisione di stato, dalle moschee alle rappresentazioni teatrali, tutto a Moharram evoca il dolore ancestrale della comunità sciita, il suo sacrificio, il suo anelito alla rivalsa, in un crescendo che raggiunge l’acme il decimo giorno, ossia il giorno dell’Ashura, quando, in ossequio a un antico rituale, i più devoti si cospargono il volto di fango.
Ma quest’estate il mese sacro è arrivato a ridosso della guerra con Israele e l’atmosfera si è caricata di un misto di paura e amore viscerale per la terra, cosicché le elegie degli oratori chiamati a infiammare le cerimonie in onore dell’imam Hossein hanno dovuto spaziare tra mitologia, letteratura e ritornelli di una musica pop che faceva molto ancien régime. Nel frattempo, nella città di Yazd risuonava da un altoparlante la canzone patriottica del 1941, “Ey Iran”, e nelle piazze del regime, dal Caspio al Khuzestan, in uno sventolio di bandiere nazionali, agitate accanto ai tradizionali stendardi verdi e neri, si sono sentite pronunciare a gran voce parole come vatan, (patria) e mellat (popolo).
Che gli iraniani siano esausti della retorica del martirio e della “sacra difesa” di Ali Khamenei è un fatto acclarato per buona parte della nomenklatura. Come sottolinea Vali Nasr, professore dell’università John Hopkins, nel suo ultimo libro “Iran’s grand strategy”, non è un mistero che l’impatto della cosiddetta politica della resistenza sia stato disastroso. Dal 2018 al 2022 l’economia iraniana ha subìto una contrazione del 7,3 per cento, la povertà è cresciuta dell’11 per cento, e mentre il rial si inabissava, l’inflazione falcidiava il potere d’acquisto delle famiglie e il prezzo dei prodotti alimentari aumentava del 186 per cento. In parallelo il mercato nero seguitava a espandersi e si espandeva senza ritegno anche la rete di politici, affaristi e fondazioni legate ai pasdaran e alle loro corporation con il risultato che la percezione della disuguaglianza tra il regime e gli iraniani ha raggiunto i livelli più alti di sempre.
In un discorso pronunciato il 13 marzo di quest’anno, Hassan Rohani, già presidente e deus ex machina dell’accordo nucleare con l’Amministrazione Obama, metteva in guardia dalla distanza tra la Repubblica islamica e i suoi cittadini. “La questione centrale della nostra sicurezza nazionale, prima del potere militare e dell’intelligence (…), è mantenere il favore della nostra gente: l’unità è questa la chiave”. Un’unita che secondo Rohani è sempre più labile anche a causa di posizioni che sono difficili da giustificare. “Stiamo ancora discutendo se i sabati siano o no giorni lavorativi, se siano pro o contro la sharia. Qualcuno da fuori potrebbe dire che in noi non alberga un barlume di saggezza. Cos’ha a che fare il sabato con la religione? E il giovedì? Il giovedì rispetta la religione e il sabato invece no? (…) E’ assurdo, non riusciamo neanche ad accordarci su quando sia opportuno che finisca la settimana”.
In questo clima di sfiducia, di scarsa attrattiva della Repubblica islamica, per usare un eufemismo, e di scarsa saggezza dei suoi rappresentanti, per dirla alla Rohani, non stupisce che persino l’ayatollah Khamenei abbia più volte pronunciato la parola “patria” nei suoi messaggi dal bunker, né che negli ultimi anni e in maniera più marcata negli ultimi mesi, una serie di pezzi grossi del regime abbiano fatto ricorso a dosi più o meno omeopatiche di nazionalismo per distinguersi dai rivali, annoverarsi come figure inclusive e guadagnarsi consensi.
“Auguro a tutti voi un anno di pace e prosperità”, ha detto, per esempio, il generale Mohammad Bagheri, potente capo delle Forze armate ucciso in un attacco israeliano la notte del 13 giugno. Parlava davanti alle rovine achemenidi di Persepolis e non indossava l’uniforme, portava una camicia azzurra a maniche lunghe, un paio di occhiali da sole, un cappellino con la visiera e, nel messaggio, registrato a primavera, in occasione della festività pre islamica di Nowruz, raccontava di quanto lo onorasse quella visita a Persepolis e di quanto significato avessero ai suoi occhi i valori di pace, amicizia e fratellanza che quel sito rappresentava e a cui si augurava potessero ispirarsi i rapporti tra l’Iran e i suoi vicini.
A Persepolis, negli ultimi decenni, sono già stati fotografati lo stesso Rohani e gli ex presidenti Mohammad Khatami e Ali Akbar Hashemi Rafsanjani, ma le rovine di Ciro e Dario il Grande restano un punto dolente per una nutrita schiera di ultraconservatori, basti ricordare che dopo la rivoluzione, il giudice Sadegh Khalkhali si attivò per appiattire il sito con le ruspe, e il video di Bagheri è stato prevedibilmente condannato dall’intransigente Said Jalili (anch’egli ex negoziatore nucleare) e dall’altrettanto intransigente Raja News, organo di stampa dei “super rivoluzionari” del partito Paydari.
Se il fine ultimo delle diverse cordate che incarnano il potere del regime è sempre e solo la sopravvivenza del sistema, intorno alle strategie da adottare per garantirla si combattono battaglie cruente. Per i falchi alla Jalili il modello del buon rivoluzionario khameneista resta quello che si rifa a Ruhollah Khomeini e al Pantheon dei martiri sciiti. Per un comandante come il defunto Bagheri, invece, tutto si tiene, la fedeltà a Khamenei e le milizie, Nowruz e l’esaltazione di Persepolis, il patriottismo del ministro Qajar Amir Kabir e la poesia di Ferdowsi. C’è in effetti una corrente di pensiero all’interno della composita galassia pasdaran, una corrente in cui rientra anche lo spregiudicato Mahmoud Ahmadinead, che riconosce in questo improbabile sincretismo l’unico argine all’apatia.
“Ogni giorno è Ashura e ogni terra è Karbala”, amava ripetere il padre della rivoluzione Ruhollah Khomeini e il senso era che la tragica morte dell’imam Hossein e dei suoi 72 seguaci per mano dall’armata del califfo omayyade Yazid non fosse un evento chiuso dentro un tempo (il 10 ottobre del 680 d.C) e uno spazio (Karbala) definiti, bensì un momento che poteva rinnovarsi all’infinito. Fintanto che fossero esistiti altri Yazid – lo scià, Saddam, Israele o l’America – i fedeli sarebbero stati chiamati a resistere all’ingiustizia e all’oppressione, a lottare senza risparmiarsi proprio come l’imam Hossein. Non c’era spazio per l’Iran nella visione escatologica di Khomeini, almeno non ce ne fu fino all’inizio della guerra con l’Iraq e alla stagione dei “calici amari”.
E il punto per la Repubblica islamica è sempre lo stesso, decidere, come suggerì Henry Kissinger, se essere una nazione o una causa. Per gli iraniani il problema è che gli interessi dell’Iran come stato nazionale, gli interessi del regime come infrastruttura di potere e le ambizioni fratricide dei diversi protagonisti di questo sistema, producono risposte diverse.
E nel frattempo il leader supremo, l’uomo che da 35 anni regge le sorti della Repubblica islamica e da 35 anni non ne varca i confini, resta sepolto nel suo bunker. Secondo gli analisti sarebbe un pessimo segnale se non riemergesse in occasione dell’Ashura. Se accadesse, a Teheran si aprirebbe la stagione della resa dei conti, ma se a dispetto delle bombe e dei complotti è vivo, è illusorio pensare che qualcosa possa cambiare. Come il riccio di Isaiah Berlin, Khamenei è uno di quelli che da tutta la vita coltivano una sola grande idea.
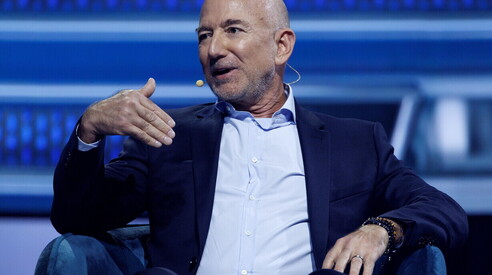

tra stati uniti e italia
J. D. Vannacci: vite politiche parallele dei vice di Trump e Salvini



