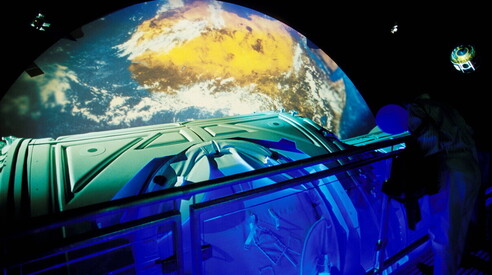Cosa vogliono dire 600 giorni in ostaggio di Hamas. Tre testimonianze
Tutti i fronti dei rapiti e delle loro famiglie, la battaglia contro i terroristi della Striscia, la freddezza della comunità internazionale, i ritardi del governo israeliano. La lotta anche contro chi non vuole ricordare
“Seicento giorni sono una data pesante, ma per noi non cambia nulla. Sono come ieri, come una settimana fa, come domani. Un altro giorno in cui ci siamo svegliati e ci siamo chiesti dov’è nostro figlio, cosa sta patendo, cosa ha patito”, dice Ayelet, madre di Jonathan Samerano, rapito dalle porte del kibbutz Be’eri il 7 ottobre. Jonathan era al Supernova festival, i terroristi gli spararono addosso e uno di loro lo portò a casa sua: era un funzionario dell’Unrwa, l’agenzia dell’Onu per il soccorso e l’occupazione dei profughi palestinesi. Per giorni Ayelet non ha saputo nulla, il telefono di Jonathan era stato localizzato in una casa di Nuseirat, presso un indirizzo corrispondente al domicilio di un lavoratore delle Nazione Unite. “Mi sono rivolta al capo dell’Unrwa Lazzarini, mi sono rivolta al segretario dell’Onu Guterres e non ho ottenuto nulla se non la risposta: cosa possiamo fare? andare a prenderlo?”. Ayelet miscela rabbia e concretezza, non ha notizie dal governo israeliano, che non parla con le famiglie degli ostaggi. Dal 7 ottobre si è trasformata, ha preso a girare il mondo, poco tempo fa ha parlato con Steve Witkoff e dice che gli Stati Uniti rimangono il paese più vicino alle famiglie dei rapiti a Gaza. In tutto sono cinquantotto gli ostaggi che vivi o morti sono ancora nelle mani dei terroristi di Hamas. “Non avrei mai pensato di arrivare a seicento giorni senza avere certezze su mio figlio”. Ayelet parla di Jonathan come se fosse vivo, ma le informazioni raccolte dall’intelligence indicano che il ragazzo di ventuno anni è stato ucciso. Per Ayelet la battaglia non cambia, non per questo ha smesso di contattare l’Onu, di pretendere informazioni dal suo governo: “Non c’è differenza tra vivi e morti. A volte sento un senso di stanchezza, ma la battaglia non cambia, i morti contano quanto i vivi”. Seicento giorni sono insopportabili, anche perché sono seicento giorni di vuoto, le famiglie di chi è stato rapito hanno informazioni concrete soltanto da chi è tornato. Il vuoto è uno dei pesi maggiori che deve sopportare anche chi è in prigionia e Keith Siegel, liberato il primo febbraio dopo il secondo accordo di cessate il fuoco raggiunto tra Israele e Hamas, con quel vuoto ha convissuto e lottato. “Sono stato rapito con mia moglie Aviva dal kibbutz Kfar Aza, mi fecero prendere la macchina e mi dissero di guidare verso Gaza. Mi hanno sparato, rotto le costole. Abbiamo patito abusi fisici e mentali, abbiamo patito la fame e la sete. Siamo stati spostati da abitazioni a tunnel, poi di nuovo abitazioni, poi ancora tunnel. Mia moglie è stata liberata durante il primo accordo nel novembre del 2023. Vennero a prenderla e dissero a tutti e due che il giorno dopo sarebbe toccato a me”. Non è toccato a lui. I terroristi gli fecero vedere il video della liberazione di sua moglie. “Guardavo quelle immagini di confusione, con la gente che saltava sopra le macchine della Croce Rossa e si stringeva attorno agli ostaggi. Non mi hanno mai fatto vedere se Aviva fosse riuscita ad andare via, non l’ho saputo fino a quando non sono tornato io. E’ difficile riassumere più di quattrocento giorni di rapimento, si sperimenta tutto. Ho visto abusi sessuali compiuti su una ragazza davanti ai miei occhi e nessuno poteva muoversi”. Keith ha sessantasei anni, sembra lontano quando parla, ci tiene a scandire bene ogni parola non soltanto per una questione linguistica ma anche per essere sicuro che il suo messaggio passi. Trasmettere l’orrore vissuto dai prigionieri a Gaza è un dovere per chi è tornato. Keith come gli altri non ha avuto il tempo di affrontare il suo rapimento, le torture, le privazioni, la paura. Dopo la liberazione si è messo a girare il mondo per gli altri ancora nella Striscia. “Quattrocentottantatré giorni sono un tempo infinito per un essere umano per subire quello che ho subìto. Seicento sono un tempo insostenibile. Ogni giorno in più dentro un tunnel o dentro una casa è insostenibile”. Keith ribadisce con la sua voce quasi meccanica che sembra frenare le emozioni che c’è soltanto una cosa che si può fare per chi è ancora a Gaza, “riportarli a casa. Israele deve fare soltanto questo perché imporre un solo giorno in più di prigionia, una sola ora in più, non è accettabile”. Gli occhi di Keith dicono che il racconto di quanto ha vissuto da prigioniero di Hamas può essere soltanto parziale e le parole non riusciranno mai a restituire l’interezza di quei giorni, le immagini, il senso di abbandono personale e per gli altri nel tunnel. “So esattamente cosa patiscono ogni secondo. So chi è malato, chi rischia di più la vita. Non posso non pensare a loro”.
Dalia Cusnir è la cognata di Iair ed Eitan Horn, due fratelli israelo-argentini rapiti da Nir Oz. Iair è stato liberato a marzo, Eitan, il più giovane, è ancora prigioniero. “Ha una malattia della pelle, negli ambienti umidi peggiora. Ma cosa cambia? A questo punto sono tutti malati”. Dalia indossa una maglietta con la faccia di Eitan. Le famiglie degli ostaggi hanno anche cambiato modo di vestire da seicento giorni, indossano magliette con frasi dedicate ai rapiti, con volti, con numeri. “Ogni volta che viene annunciato un progresso nei negoziati, come ha fatto Benjamin Netanyahu lunedì, non dormiamo. Chi fa gli annunci non si rende conto delle conseguenze. La pressione internazionale su Israele sta cancellando le responsabilità di Hamas e questo lo dico da persona convinta del fatto che i bambini di Gaza meritano di avere lo stesso futuro e gli stessi diritti dei miei figli. Però se davvero si vuole mettere fine alla guerra c’è una cosa da fare: liberare gli ostaggi. Questo deve essere chiaro ai paesi che condannano Israele. Eliminare questo punto, cancellare chi è stato rapito, non serve a far finire il conflitto. Seicento giorni per il mondo sono una cifra da sottolineare, per noi sono ormai la normalità. Non vogliamo un seicentounesimo giorno di prigionia a Gaza”. Non si sentono protetti dal governo, non si sentono protetti dalla comunità internazionale. Il rischio per gli ostaggi e le loro famiglie è di essere dimenticati. Lo sanno e combattono questo rischio. “Serve un accordo che li liberi tutti. Tutti insieme”, aggiunge Keith, che conosce il peso di un giorno in più nella prigionia di Hamas.