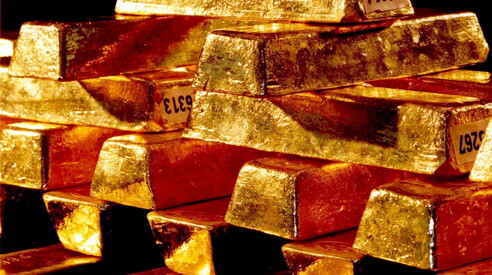
Ansa
Magazine
L'oro delle patrie. Viaggio nei Forzieri del mondo
Pepite, lingotti, monete e monili. Altro che barbarico relitto. Quando i tempi si fanno bui, tutti sognano e chiedono il metallo color del sole. I nodi politici, il ruolo delle banche centrali e il debito insostenibile
Quanto vale l’oro degli italiani? Quello della patria custodito nella Banca d’Italia, a Fort Knox, a Londra e in Svizzera, ma ancor più quello stipato nelle cassette di sicurezza, nei portagioie, nei caveau, sotto i mattoni, dovunque si possa celare per poi mostrarlo nelle grandi occasioni o estrarlo come in una magia quando nulla è più sicuro tranne quel metallo “portentoso e onnipossente”. Secondo alcuni calcoli s’avvicina a mille miliardi di euro in pepite, lingotti, monete e monili, all’incirca un terzo del debito pubblico accumulato e poco meno di metà del prodotto lordo annuo. L’Italia sembra la fucina di re Mida, non stupisce che tutti vogliano inzuppare le loro dita nel crogiolo. Chi pensa che siano iperboli retoriche, dia un’occhiata a qualche conticino, provvisorio per carità, anche perché l’oro mantiene il suo incanto millenario e il suo semprevivo mistero. Nessuno conosce esattamente quanto oro sia in mano ai privati. La Ragioneria dello stato sta facendo una stima e pare che arrivi tra le 4 mila e le 5 mila tonnellate, quindi un valore monetario che s’avvicina ai 600 miliardi di euro. Un quarto serve come investimento, o meglio come assicurazione anti-crisi. Se venisse alla luce dovrebbe pagare una tassa del 26 per cento, invece si pensa a una sorta di condono: il 12,5 per cento secco come per i Btp. Quanto se ne può ricavare? L’ipotesi è che possano emergere 1.500 tonnellate, a 117 milioni di euro a tonnellata avrebbero un valore di oltre 175 miliardi di euro. E il Tesoro potrebbe farsi un tesoretto.
C’è poi la riserva aurea della banca centrale, ma qui il gioco si fa grande, diventa europeo, anzi mondiale. Sono 2.452 tonnellate e valgono al prezzo di mercato circa 272 miliardi di euro, il 9 per cento del debito italiano. Per ora restano dove sono: 4,1 tonnellate sotto forma di moneta (si tratta di 871.713 pezzi), il resto in lingotti, 1.100 tonnellate a Roma nei sotterranei di palazzo Koch, in via Nazionale 91, altre 1.061 tonnellate negli Stati Uniti a Fort Knox nel Kentucky o alla Fed di New York in un magazzino costruito nel 1920 che ha subito miglioramenti sostanziali nel tempo e oggi è considerato uno dei depositi più impenetrabili del mondo, quote minori a Londra e in Svizzera. Alla Banca centrale europea sono state conferite 141 tonnellate nel 1999 come garanzia quando la lira ha lasciato il posto all’euro.
Un emendamento alla legge di bilancio firmato dal capogruppo di Fratelli d’Italia Lucio Malan, sancisce che le riserve auree appartengono al popolo, quindi al governo che lo rappresenta. Una tesi di stampo leghista già proclamata dai dioscuri dell’Italexit, la rumorosa coppia Claudio Borghi e Alberto Bagnai, ma condivisa da Giorgia Meloni quando era all’opposizione. Il ministro dell’economia Giancarlo Giorgetti ha messo le mani avanti e ha consultato la Bce, in ogni caso quel deposito è a salvaguardia della stabilità finanziaria. Un’idea ardita circolata anni fa aveva visto l’oro di Bankitalia come sottostante, insieme all’ingente patrimonio pubblico, di un fondo sovrano italiano nel quale far confluire in parte il debito dello stato. Nel 2005 il governo di Silvio Berlusconi aveva fatto approvare una legge per passarlo al ministero dell’economia, poi abolita nel 2013. Romano Prodi nel pieno della crisi del 2011 aveva proposto di cedere l’oro a un fondo europeo con il quale garantire l’emissione di titoli comuni. I Cinquestelle hanno pensato di usare le riserve per finanziare il reddito di cittadinanza. Ancora si ride dei pentastellati, che quando erano al governo bussarono sospettosi al portone di via Nazionale per vedere con i loro occhi e toccare con le proprie mani i lingotti rinchiusi nel caveau e increduli chiedevano se fossero veri o solo pezzi di ferro placcati. Ma ora siamo ben oltre la farsa.
L’oro della patria
In questo vecchio e sempre nuovo universo dorato l’Italia è una grande potenza, la numero tre al mondo se calcoliamo solo la quantità di riserve ufficiali, ma la prima in rapporto al prodotto lordo. Gli Stati Uniti posseggono 8.133 tonnellate d’oro, la Germania ha 3.350 tonnellate, poi arriva l’Italia con le sue 2.452 tonnellate, seguita a ruota da Francia (2.436 tonnellate), Russia (2.298), Cina (1948) e Svizzera con poco più di mille tonnellate. Anche se Londra è il più grande mercato, il Regno Unito mantiene il segreto sull’ammontare delle proprie riserve, il World gold council stima che siano appena 310 tonnellate. Il valore delle riserve auree italiane è pari al 12 per cento del pil, la Russia è all’11,7 per cento, gli Usa 11 per cento, la Francia 9 per cento, la Germania 8,5 per cento. C’è stato un tempo in cui la Federal Reserve, la banca centrale americana, struttura privata con finalità pubbliche, aveva oro di proprietà, ma non è più così: una legge approvata nel 1934 ha trasferito tutto al Tesoro che emette certificati alla Fed la quale gestisce la contabilità delle riserve.
A quel tempo, la riserva aurea italiana superava le 561 tonnellate, ma nel 1940 all’ingresso in guerra, dopo consistenti cessioni, il quantitativo complessivo era sceso a 106 tonnellate. Con l’armistizio del 1943 l’oro venne per lo più espropriato dai tedeschi; 92 tonnellate furono trasferite in Alto Adige, a Fortezza, e nel 1945 gli alleati le riportarono a Roma. Il miracolo economico ha trasformato l’Italia in un grande paese esportatore di merci e parte delle valute estere sono servite per comprare oro: dal 1951 al 1960 le riserve si sono moltiplicate. Guido Carli ha raccontato in dettaglio come e perché lui e Paolo Baffi puntarono sull’oro fino ad accumularne nel 1973, alla vigilia della grande crisi petrolifera, ben 2.565 tonnellate. Poi la lira cominciò a tremare e a crollare, nel 1976 il governo Andreotti chiese aiuto alla Germania e la Bundesbank, in garanzia del prestito, volle 543 tonnellate che furono portate a Francoforte con treni blindati. Rientrate negli anni successivi, su molti lingotti resta ancora stampata la Bundesadler, l’aquila della Repubblica federale tedesca.
Per un secolo, dal 1814 al 1913, l’oro nella maggior parte dei paesi tra i quali l’Italia, è stato il garante dei biglietti di banca in circolazione, il sistema era chiamato gold standard e collassò con la Grande Guerra. Alla fine degli anni Venti venne sperimentato il gold exchange standard (una sola valuta convertibile in oro e tutte le altre scambiate con essa a un tasso fisso) e dal 1928 la Banca d’Italia ebbe l’obbligo di tenere una riserva non inferiore al 40 per cento dei biglietti in circolazione. Dopo la seconda guerra mondiale Roma aderì agli accordi di Bretton Woods i quali stabilirono che il dollaro sarebbe stata la moneta di riferimento, l’unica cambiata in oro al prezzo fisso di 35 dollari per oncia (28,3495 grammi). Una stabilità che nascondeva un lato oscuro.
Nel 1953 Paolo Baffi allora consigliere economico del governatore Donato Menichella scrisse che si sarebbe verificata una scarsità di oro sotto la pressione della espansione economica e della liberalizzazione degli scambi, quindi meglio premunirsi. Nel 1960 quando il timone della banca centrale passò nelle mani di Guido Carli, si videro i primi scricchiolii e il prezzo dell’oro sul mercato di Londra arrivò a 40 dollari. Era solo l’inizio. Intanto a palazzo Koch avevano seguito i consigli di Baffi cominciando a comprare oro. Gli acquisti italiani preoccuparono gli Stati Uniti e un alto funzionario della Fed invitò gentilmente ad acquistare non sul mercato londinese, ma dalla banca centrale americana. “La fiducia del nostro collega presupponeva il mantenimento del precario equilibrio del sistema”, ha scritto Carli sul Corriere della Sera nel 1980, invece quell’equilibrio “restava appeso al filo sottile dell’incertezza”. Convinzione condivisa con altri banchieri centrali, olandesi e tedeschi, per non parlare dei francesi: Charles de Gaulle, eletto presidente nel 1959, voleva un ritorno all’oro, consigliato dal suo economista di fiducia Jacques Rueff. Profeti di sventura o maestri di prudenza?
Durante tutti gli anni 60 gli Stati Uniti si lanciarono in un continuo spendi e spandi per finanziare la guerra del Vietnam, ma anche per le riforme introdotte dal presidente Lyndon Johnson con la Great Society. Leggiamo ancora Carli: “Fra il 1967 e il 1968 crepe profonde si aprirono nel sistema, la svalutazione della sterlina indusse il dubbio che sarebbe seguita da quella del dollaro”. La Banca d’Italia riprese a comprare, ma dal Fondo monetario internazionale, e le riserve salirono a 2.598 tonnellate, record non più raggiunto. Una scelta prudente che rispondeva a un’analisi dei rischi provocati dall’aumento continuo di dollari liquidi stampati dagli Stati Uniti per far fronte alle loro esigenze. A Ferragosto del 1971 la diga d’oro crollò: l’allora presidente Richard Nixon decise unilateralmente che da quel momento cessava il legame con l’oro, il dollaro diventava libero di svalutarsi e ciò avvenne puntualmente. Il calo maggiore verso lo yen (circa il 17 per cento), il franco svizzero e il marco tedesco (13,9 e 13,6 per cento), la lira guadagnò il 7,5 per cento, ma perse l’un per cento sull’oro. Dal 1973 le monete ufficiali fluttuano senza vincoli sul mercato. Con gli “scambi flessibili” gli Stati Uniti hanno inondato il mondo di dollari, mentre l’oro uscito dal sistema monetario veniva ridotto a una merce come tutte le altre, senza perdere però la sua magia. Oggi, di fronte al “disordine nel tempio della finanza mondiale” spunta di nuovo l’idea di usarlo se non come bastone del comando, come stabilizzatore.
I mercanti nel tempio
Quando Carli analizzò quel disordine era il 1987, e scoppiava la più grave crisi a Wall Street dopo il 1929. Siccome al peggio non c’è mai fine, altre crisi peggiori della peggiore ne sarebbero seguite fino al grande crac del 2008. Con il crollo dei mutui subprime americani il marcio s’annidava nei prestiti bancari, mentre in quel “lunedì nero” del 19 ottobre 1987 il pesce puzzava “dalla capa”. Il dollaro si era rivalutato in modo eccessivo (fino al 50 per cento rispetto allo yen) e nel 1985 i cinque maggiori paesi industriali pianificarono di sgonfiarlo. L’accordo del Plaza ebbe successo, ma la valuta americana scese troppo e due anni dopo un nuovo accordo a Parigi decise di fermarne la caduta. A quel punto a Wall Street cominciarono a perdere la bussola già impazzita, secondo Carli, per “la vastità dei trasferimenti di capitale, l’insufficiente capacità dei governi di coordinare le politiche economiche, la dissociazione dei cambi delle valute dai poteri d’acquisto, gli squilibri delle bilance dei pagamenti, la crescita della componente finanziaria delle famiglie, l’aumento dei profitti delle imprese e della produttività, la de-industrializzazione”.
La nascita di una nuova moneta come l’euro ha stabilizzato la situazione in Europa, ma non rispetto al dollaro (quindi alle scelte politiche ed economiche degli Stati Uniti) che ha mantenuto la sua posizione dominante. Flussi imponenti di capitali sono confluiti a New York e hanno collocato il cambio fuori da qualsiasi relazione fra il potere d’acquisto del biglietto verde e quello delle monete dei maggiori paesi industriali. Nel frattempo titoli e obbligazioni hanno sostituito in modo enorme i depositi bancari. Con i sistemi elettronici la quantità di pagamenti può essere distorta in qualsiasi momento, in questo modo l’insolvenza di un solo partecipante al sistema dei pagamenti basta a inceppare il funzionamento di tutto il sistema, proprio come il 15 settembre 2008, quando fallì la Lehman Brothers. La carta ha rimpiazzato l’oro, carta garantita da altra carta, “pagherò” che non saranno mai pagati, ma venduti ricavandone un interesse come se fossero dei beni effettivi invece che promesse. Le banche ordinarie sono state surclassate dai fondi di investimento i quali a loro volta si sono diversificati, specializzati, moltiplicati.
Secondo l’Fmi, entro il 2029, il debito pubblico nel mondo intero raggiungerà il 100 per cento del prodotto annuo, poi ci sono i debiti delle famiglie e delle imprese. Quelli che stanno peggio non sono i paesi poveri, ma quelli ricchi che vivono al di sopra dei loro mezzi. Se calcoliamo anche i debiti privati, arriviamo a tre-quattro volte il pil, e non c’entra solo il modello occidentale: la Cina con il suo “socialismo di mercato” è al 375 per cento. Il futuro non è destinato a cambiare, al contrario: il boom dell’Intelligenza artificiale è fondato su un immenso indebitamento. Si dice che serviranno tremila miliardi di dollari, e chi paga? Non le imprese, molte delle quali, come OpenAI, non fanno ancora profitti, e altre come la Oracle, diventata la cocca di Trump, è già super indebitata. E allora? Le stime della Morgan Stanley calcolano che 800 miliardi saranno prestiti privati, 350 verranno dai fondi che in cambio prenderanno azioni delle compagnie, 200 da titoli emessi dalle stesse imprese e 150 da cartolarizzazioni sostenute da attività concrete. Secondo la grande banca americana, di quei tremila miliardi, meno della metà, se tutto va bene, potrà essere generata da prodotti e servizi forniti dalle imprese. Dunque, avremo 1.500 miliardi di dollari in nuova carta per comprare altra carta. Bisogna solo sperare che nessuno accenda un fiammifero nel “tempio della finanza”.
I nuovi Goldfinger
E’ possibile affidare all’oro il compito di puntellare questo castello di carta? Intanto c’è un limite fisico: non ne esiste abbastanza per pareggiare quei valori stratosferici. Hai voglia a scavare, di pepite e pagliuzze non se ne trovano a sufficienza; natura matrigna! Scegliere l’oro come àncora farebbe naufragare gran parte di questi vascelli corsari che percorrono ogni giorno i sette mari. Eppure le banche centrali stanno comprando e hanno superato per il terzo anno consecutivo le mille tonnellate. Ora in testa nella corsa agli acquisti c’è la Polonia, davanti a Turchia, India, Cina. E poi ci sono i privati, non le coppie indiane alla vigilia delle nozze (ogni primavera, la stagione dei matrimoni fan regolarmente salire la domanda e i prezzi), bensì i nuovi maghi delle valute digitali, chiamate cripto perché la chiave per decifrare i linguaggi cifrati e con essa tutti i loro segreti.
Il metallo color del sole ha poteri speciali perché agisce sulle componenti irrazionali dell’uomo. Snobba gli economisti, si affida agli alchimisti e oggi ai maghi dell’algoritmo. Colpisce che l’oro rientri con le sue metafisiche promesse anche nel cuore del mondo digitale. Le criptovalute del momento, e secondo alcuni del futuro, sono quelle che mantengono un valore stabile (si chiamano stable-coin) perché collegate a monete ufficiali forti, soprattutto al dollaro, e ancor più all’oro. I prezzi si muovono su è giù, ma la scommessa è che offrano comunque porti ragionevolmente sicuri. Per i puristi è un passo indietro rispetto al bitcoin, che non passa per le banche e nasce da contratti tra privati, insomma una specie di ritorno alle conchiglie primordiali sotto l’aspetto di funzioni matematiche. Con Tether, la loro stablecoin, Giancarlo Devasini e Paolo Ardoino hanno guadagnato 35 miliardi di dollari in tre anni (così dicono) e hanno comprato non solo titoli di stato americani, ma oro che conservano apparentemente in Svizzera o nel Salvador, unico paese ad aver dato corso legale al bitcoin. Insomma, pur svolazzando nell’universo elettronico, anche i due ricconi italiani si sono affidati al barbarico relitto.
Il vero Goldfinger, però, siede alla Casa Bianca. Gioca anche lui con le forze oscure delle valute segrete e ha trasformato l’austera villa neoclassica in Topkapi. All’idea di quel metallo Donald Trump non sa proprio resistere. Lo ha fatto una sola volta e forse se ne è pentito. Siamo al primo mandato, esattamente nel gennaio 2018, e c’è di mezzo anche Melanija Knavs in Trump. La first lady ama l’arte, non solo la moda; nata in Slovenia (nel 1970, quando c’era ancora la Jugoslavia) conosce l’Europa (parla anche tedesco e francese) e l’Italia, perché deve a Milano il tirocinio da modella quando era ancora una teen-ager. Vincent van Gogh è il suo pittore preferito, così chiede al regal consorte un quadro del grande artista olandese: “Panorama con neve” dipinto nel 1888, triste e poetico, che evidentemente le ricorda gli inverni della sua infanzia, anche se è ambientato ad Arles. L’opera appartiene al Guggenheim, ma per tradizione i presidenti possono ottenere prestiti momentanei. Trump chiama il museo, la curatrice Nancy Spector risponde che il paesaggio non è disponibile, ma può offrire un altro capolavoro: il water d’oro dell’artista italiano Maurizio Cattelan intitolato “America”, avrebbe fatto la sua bella figura in una Casa Bianca trasformata in residenza da sultano. Adesso l’artistico vaso da evacuazione è stato venduto letteralmente a peso d’oro: 12 milioni di dollari, il solo costo del metallo (l’arte evidentemente non ha valore, in senso letterale). Trump invece ha accolto con piacere gli aurei doni svizzeri (un Rolex da tavolo e un lingotto personalizzato) poi ha concesso con magnanimità di ridurre i dazi dal 39 al 15 per cento. Mandiamo in soffitta il capolavoro di Alexis de Tocqueville: se fosse vivo il visconte francese dovrebbe scrivere non La Democrazia in America, ma Il Sultanato in America.
L’aurea indipendenza
E Roma cosa può farsene di tutti quei lingotti? Sono davvero il baluardo estremo della sovranità nazionale? La Banca d’Italia è un istituto di diritto pubblico e il governatore è nominato dal presidente della Repubblica su proposta del governo. Tuttavia è indipendente, fa parte del Sistema europeo delle banche centrali e nessun governo può obbligarla a cedere le riserve. Allora, la questione dell’oro diventa politica a tutto tondo e va dritta dritta al cuore della banca centrale e della sua autonomia messa in discussione da molti, a cominciare da Donald Trump. Il Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, ribadisce che “nell’esercizio dei poteri e nell’assolvimento dei compiti e dei doveri loro attribuiti dai trattati e dallo statuto del Sebc e della Bce, né la Banca centrale europea né una banca centrale nazionale né un membro dei rispettivi organi decisionali possono sollecitare o accettare istruzioni dalle istituzioni, dagli organi o dagli organismi dell’Unione, dai governi degli Stati membri né da qualsiasi altro organismo”. L’articolo aggiunge che “le istituzioni, gli organi e gli organismi dell’Unione nonché i governi degli Stati membri si impegnano a rispettare questo principio e a non cercare di influenzare i membri degli organi decisionali della Banca centrale europea o delle banche centrali nazionali nell’assolvimento dei loro compiti”. Burocratese a parte, è chiaro che solo rinnegando l’euro si possono violare l’autonomia e l’indipendenza. Ciò riguarda anche la gestione delle riserve, le quali hanno un valore strategico.
C’è davvero bisogno di 2.400 e rotte tonnellate, non se ne può vendere almeno un po’? In fondo, questa assicurazione contro i tempi bui non è servita a tranquillizzare i mercati nel fatidico 2011, quando a novembre le banche non avevano abbastanza liquidità per rifornire i bancomat. Allora, per che cosa teniamo in via Nazionale tutti quei lingotti, magari recuperando anche quelli a Fort Knox come ha fatto la Bundesbank? Se anche la terza potenza aurea al mondo può crollare ugualmente sotto i colpi della speculazione finanziaria, dove sta la magia di quel metallo? Domande sensate, ma tassare l’oro privato e, ancor più, smobilitare quello pubblico sarebbero messaggi da ultima spiaggia, controproducenti mentre l’Italia sta per uscire dalla procedura d’infrazione per eccesso di deficit, verrebbe presa come una misura estrema, proprio ora che le agenzie di rating hanno promosso il debito italiano. L’unica cosa certa è che l’oro resta sempre centrale, nelle menti e nei portafogli.
Altro che “barbarico relitto” - così disse John Maynard Keynes quando, nel 1944, da capo negoziatore dell’Inghilterra alla conferenza di Bretton Woods, propose che, una volta vinta la Seconda guerra mondiale, una moneta artificiale chiamata “Bancor” avrebbe regolato il gioco degli scambi nel mondo libero. Fu bocciato, prevalse il dollaro, ma garantito dall’oro al quale s’affidano da millenni privati cittadini come possenti stati. “La lunga marcia verso la riforma del sistema monetario con l’obiettivo di escludere gradualmente l’oro per rimpiazzarlo con una moneta immaginaria creata da uomini saggi riuniti in consessi internazionali, si è conclusa perché i più non hanno creduto alla saggezza degli uomini, hanno preferito affidarsi al metallo, nel quale gli antecessori avevano riposto la fiducia nel corso dei secoli”: è sempre Carli che parla, indossando la tunica del profeta disarmato. Del Bancor è rimasto il suo spettro, come scrisse Tommaso Padoa Schioppa, uno degli “uomini saggi” che hanno contribuito a far nascere l’euro. E’ un fantasma shakespeariano che ricorda quello di Banco al quale, secondo alcuni, Keynes si sarebbe ispirato, lo spettro di un re buono in grado di portare pace, concordia e giustizia, cacciando dal tempio i mercanti di illusioni. Tutti lo chiedono, tutti lo vogliono quando i tempi si fanno bui, poi passata la bufera torna la malia dominatrice di Lady Macbeth.


gran milano - Tutta l'Energia che serve / 1
Nucleare per il bene di imprese e ambiente. Gli scenari del Polimi





