
Foto:ansa
L'analisi
L'Irpef dei ricchi e dei poveri
Anche Draghi favoriva i redditi medio-alti, ma non c'erano state tutte queste polemiche. Giudicare la manovra Meloni pro-redditi alti senza considerare le politiche fiscali dei precedenti anni è riduttivo. Per i salari più bassi Giorgetti ha agito, anziché sulle aliquote, prima sui contributi e poi con un “bonus”
La polemica sulla riforma dell’Irpef “a favore dei ricchi” ha dei tratti surreali. L’opposizione e la stampa sembrano aver scoperto dalle audizioni di Istat, Banca d’Italia e Upb che una riduzione dell’aliquota dell’imposta sulle persone fisiche favorisce in termini assoluti i redditi più elevati. Eppure è un dato banale. Il taglio della seconda aliquota, quella per la fascia 28-50 mila euro, dal 35 al 33 per cento, per definizione comporta un beneficio per i redditi oltre i 28 mila euro: una soglia che è superiore al reddito medio, pari a circa 25 mila euro (dichiarazioni 2024). E il beneficio è tanto maggiore, in termini assoluti, quanto più è alto il reddito. Per una banale questione aritmetica: chi ha redditi più alti paga più tasse e quindi, a parità di riduzione d’aliquota, ottiene un beneficio uguale in percentuale ma superiore in valore assoluto. Non servivano l’Istat e la Banca d’Italia per scoprirlo, politica e media dovrebbero usarle per analisi più sofisticate. D’altronde la stessa cosa era accaduta con la riforma Irpef ai tempi di Mario Draghi, seppure con minore clamore rispetto a oggi. La legge di Bilancio per il 2022, l’unica presentata dal governo Draghi, prevedeva l’eliminazione della quarta aliquota, quella al 41 per cento tra 55 e 75 mila euro. E inoltre riduceva la terza aliquota dal 38 al 35 per cento nello scaglione tra 28 e 50 mila euro (lo stesso su cui ora interviene ulteriormente il governo Meloni).
La riforma Draghi, che valeva circa 7 miliardi (più del doppio dei 3 miliardi previsti in questa legge di Bilancio), e riguardava una platea più ampia di quella attuale (circa il doppio, appunto), secondo l’analisi dell’epoca dell’Upb prevedeva una riduzione media d’imposta di 264 euro annui. Ma anche in quel caso l’impatto era tutt’altro che omogeneo: “La riduzione di imposta in valore assoluto è maggiore nelle classi di reddito medio-alte, con un beneficio medio di circa 765 euro per i contribuenti con reddito imponibile tra i 42 e i 54 mila euro”, scriveva l’Upb. Il vantaggio c’era anche per le classi di reddito ancora più elevate, quelle da 78 mila euro in su: il beneficio era di circa 270 euro per un costo di circa 220 milioni di euro. All’epoca ci fu un dibattito su un cosiddetto “contributo di solidarietà”, che avrebbe dovuto sterilizzare il taglio fiscale per i più “ricchi” (sopra i 75 mila euro), ma non se ne fece nulla: la maggioranza che sosteneva il governo Draghi decise che il taglio dell’Irpef doveva esserci per tutti. Tra l’altro questo meccanismo che blocca i benefici per i “più ricchi” è stato introdotto dal governo Meloni tagliando le detrazioni fiscali sia nella manovra dell’anno scorso (da 75 mila euro in su) sia in quella di quest’anno (oltre 200 mila euro).
Anche allora l’Upb fece una simulazione dello sgravio per tipologia di contribuente: il beneficio maggiore era per i dirigenti (368 euro), poi venivano gli impiegati (266 euro) e infine gli operai (162 euro). Di fatto, il 20 per cento delle famiglie più povere vennero sostanzialmente escluse dal taglio delle tasse per il semplice fatto che erano fiscalmente incapienti: non pagavano Irpef e, pertanto, non potevano beneficiare di alcun taglio dell’Irpef. Sarebbe scorretto, sulla base di questi dati, sostenere che la riforma Draghi era “regressiva” – all’epoca alcuni lo sostennero, ma non con lo stesso clamore di oggi – perché la politica fiscale va giudicata nel complesso. Il governo Draghi, ad esempio introdusse altre misure come l’Assegno unico per i figli che riequilibravano la distribuzione delle risorse a favore dei redditi più bassi.
Arriviamo così al governo Meloni. Non è corretto giudicare l’impatto di una manovra considerando solo il taglio dell’Irpef, perché ci sono anche altre misure (la Banca d’Italia dice che nel complesso non ci sono effetti significativi sulla disuguaglianza). Ma soprattutto è scorretto giudicare la politica fiscale del governo Meloni come “a favore dei ricchi” basandosi solo su questa manovra, senza valutare gli interventi degli anni passati. Come mostrano tutte le analisi, dalla Banca d’Italia all’Upb, gli interventi nei primi anni di questa legislatura sono stati rivolti principalmente ai redditi medio-bassi (fino a 35 mila euro), che sono stati più che compensati dal fiscal drag. Complessivamente, certifica l’Upb, dopo gli interventi del governo Meloni l’Irpef del 2026 è più progressiva e redistributiva rispetto al 2021. Per agevolare le fasce di reddito più basse, il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti ha agito, anziché sulle aliquote, prima sui contributi e poi con un “bonus” proprio perché i redditi medio-bassi pagano poche tasse. Oltre 9 milioni di soggetti hanno un’imposta netta pari a zero e, considerando chi ha un’imposta netta totalmente compensata dal trattamento integrativo (bonus), a non pagare l’Irpef sono 11,8 milioni di persone: il 28 per cento su 42,5 milioni di contribuenti.
Ciò implica due cose. Primo, che il grosso delle imposte lo paga chi finora non ha ricevuto sgravi e, anzi, ha subìto il fiscal drag: il 22 per cento dei contribuenti sopra i 35 mila euro paga il 64 per cento dell’Irpef (il 4,5 per cento sopra i 70 mila euro paga il 33 per cento dell’Irpef). Secondo, che qualsiasi decisione di riduzione dell’imposta sui redditi andrà, per forza di cose, maggiormente a favore dei redditi medio-alti dato che quelli medio-bassi di Irpef pagano poco o nulla. Accadeva con le riforme della sinistra e accade con quelle della destra: è matematica.
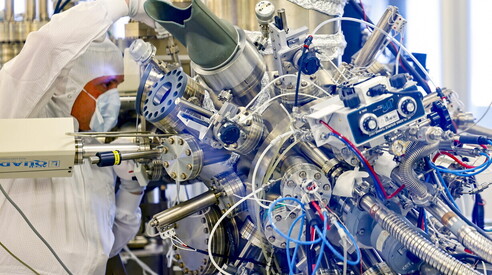


lottizzazione e lauree



