
Google creative commons
Opportunità cicliche
Il fallimento del Jiaozi cinese e il futuro delle stablecoin
Sotto la Dinastia Song, l’economia ha richiesto una liquidità e una rapidità nelle transazioni che i sistemi monetari tradizionali basati sul metallo non potevano più garantire, La storia della prima cartamoneta è una lezione sui rischi e le opportunità delle crypto
Accade talvolta che la storia, anche quella economica, ci racconti il tempo di oggi, prima ancora di quello passato. E così, vale la pena di curiosare nelle pieghe della profonda trasformazione socio-economica che ha attraversato la Cina sotto il regno della dinastia Song. In quegli anditi si nasconde, infatti, una nota promissoria che la numismatica riconosce come la prima cartamoneta della storia mondiale. Si chiama Jiaozi, ed è tutto tranne che una curiosità per collezionisti appassionati. E’, al contrario, la cartina di tornasole di una necessità strutturale che ieri, come oggi, si impone in un contesto globale attraversato da mutamenti tanto rilevanti quanto imprevedibili. Oggi, come allora, infatti, è indispensabile saper riconoscere il cambiamento e, soprattutto, governarlo. Non per una autolegittimazione delle istituzioni (che scontano una inconfutabile crisi di consenso) ma perché una corretta e sana gestione dei fenomeni in divenire è la miglior assicurazione che, in prospettiva, si può dare ai destinatari di queste trasformazioni. Ai cittadini, dunque. Ecco perché la sfortunata storia del Jiaozi torna utile in queste settimane in cui il dibattito sul futuro della politica finanziaria e monetaria è focalizzato sulle stablecoin.
Il fallimento della prima cartamoneta è – lo racconteremo tra poco – legato all’incapacità delle istituzioni di garantire a questa innovazione una sostenibilità di lungo termine. Una miopia che a sua volta discende dal timore che la coabitazione con la moneta di metallo potesse risolversi in una competizione sanguinaria e, in ultima istanza, nella cancellazione di modelli, funzioni e poteri che per decenni avevano garantito una certa stabilità a un sistema che, tuttavia, ha salutato l’avvento del Jiaozi come un veicolo di efficienza e un motore di un cambiamento culturale, ancor prima che economico. E’ un errore che non possiamo più ripetere. Eppure, il retropensiero e lo scetticismo che oggi attraversano il dibattito sullo sviluppo delle stablecoin sono segnali evidenti di un problema anzitutto culturale e di un rischio che occorre scongiurare. Riportiamo, dunque, la parola comune in questa babele. Per farlo occorre innanzitutto restituire alla coabitazione il suo vero significato. Solo così, infatti, le contrapposizioni che oggi animano le curve dei sostenitori e dei detrattori delle stablecoin potranno evolvere verso un sentire comune che non interpreta i cambiamenti come la volontà di cancellare il passato, bensì come l’opportunità di mettere in campo nuovi strumenti per rispondere a nuovi bisogni.
Il nostro viaggio inizia proprio dall’introduzione del Jiaozi. Non fu un atto arbitrario, ma una risposta diretta e necessaria a pressioni economiche strutturali divenute insostenibili. Un’innovazione che non rappresentò semplicemente un cambiamento materiale – dal rame alla carta – ma un fondamentale salto concettuale. Per secoli, infatti, il sistema monetario imperiale cinese si era basato sulla solidità delle monete di rame. Passare alla carta, un materiale privo di valore intrinseco, richiese un atto di fiducia esponenziale, spostando la fonte del valore dal metallo custodito alla promessa garantita dallo stato. A differenza delle epoche precedenti, l’economia Song richiedeva una liquidità e una rapidità nelle transazioni che i sistemi monetari tradizionali basati sul metallo non potevano più garantire. Il motore principale di questa crescente domanda monetaria fu la trasformazione della base fiscale dello stato. Sebbene questa politica fiscalmente avanzata fosse un indicatore della sofisticazione economica Song, essa mise una pressione schiacciante sull’offerta di moneta metallica. Nonostante le zecche Song raggiungessero i più alti livelli di produzione di monete di bronzo e rame (cash coins) nella storia imperiale cinese, l’offerta metallica non riusciva a tenere il passo con la domanda di mercato. Questa carenza di metalli nobili e base divenne un ostacolo strutturale alla continuazione dell’espansione commerciale e alla stabilità fiscale dello stato.
In questo senso, il Jiaozi non rappresenta un’innovazione lussuosa, quanto un surrogato monetario essenziale, introdotto per mantenere il ritmo dell’attività economica in un’epoca di scarsità metallica imposta dalla politica fiscale statale. Il fatto che il Jiaozi sia sorto nel settore privato dimostra che i mercati e la classe mercantile Song furono in grado di risolvere la crisi di liquidità e trasportabilità del Sichuan più rapidamente ed efficacemente di quanto non facesse lo stato centrale. La transizione da “denaro privato” a valuta ufficiale avvenne nel 1023 CE, quando la corte della Dinastia Song Settentrionale, riconoscendo sia l’utilità che i rischi di una moneta non regolamentata, intervenne. Lo stato introdusse una gestione estesa e politiche rigorose, trasformando il Jiaozi in una valuta cartacea ufficiale con formato e denominazione unificati, sancendo la nascita della prima cartamoneta statale della storia. Questo intervento fu cruciale, poiché rese il Jiaozi una rappresentazione da conio metallico, elevandolo al rango di valuta effettiva di circolazione di mercato.
Quando, poi, il Jiaozi fu nazionalizzato, la Dinastia Song stabilì una struttura amministrativa dedicata per garantirne l’emissione controllata e la fiducia popolare, aspetti fondamentali per la sostenibilità di qualsiasi valuta di credito. In linea di principio, il Jiaozi di stato era concepito come una valuta convertibile, una promessa di riscatto in un oggetto di valore, solitamente metallo (monete di ferro o rame). Tuttavia, l’accettazione istituzionale della carta fu facilitata dalla prospettiva monetaria cinese. Storicamente, la teoria monetaria cinese tendeva a concettualizzare la moneta non solo come un mezzo di scambio di mercato, ma anche come uno strumento con cui l’autorità imperiale poteva controllare i mercati e provvedere al benessere dei sudditi. Questa visione pareva la strada all’accettazione di una valuta fiat (valuta non sostenuta interamente dal valore intrinseco), purché lo stato mantenesse la sua legittimità.
Per regolare la circolazione e mantenere la fiducia, lo stato Song implementò diverse misure tecniche e fiscali. Dopo la standardizzazione, sebbene le banconote di taglio elevato fossero utili per i trasferimenti di capitale, l’analisi storica indica che le denominazioni più basse del Jiaozi godettero di maggiore popolarità tra la popolazione. Questo dato è significativo in quanto suggerisce che l’utilità principale della cartamoneta per il pubblico risiedeva nella facilitazione delle transazioni quotidiane e del commercio su piccola e media scala, superando l’ingombro delle monete di ferro in queste operazioni. Dove l’offerta metallica era percepita come sufficiente, o dove la fiducia nella gestione statale era carente, la popolazione respingeva la carta, dimostrando la fragilità intrinseca di questi primi sistemi monetari. Sebbene i documenti storici non sempre offrano resoconti dettagliati sulle reazioni emotive o sulle proteste iniziali contro la cartamoneta, l’adozione e la successiva regolamentazione statale indicano un successo in termini di funzionalità. Il Jiaozi risolse un problema logistico critico che nel tempo aveva limitato la crescita economica e la fluidità del commercio interprovinciale. Il successo iniziale fu, quindi, un successo di efficienza economica. Questa accettazione fu favorita dal fatto che, finché l’autorità statale manteneva la disciplina monetaria e la convertibilità, il popolo non vedeva la carta come un semplice pezzo di carta, ma come un sostituto sicuro del metallo. L’uso dei Jiaozi si diffuse a tal punto che l’innovazione cinese non passò inosservata ai viaggiatori. Marco Polo fu probabilmente uno dei primi europei a entrare in contatto con la cartamoneta (benché le sue osservazioni specifiche si riferiscano alla successiva Dinastia Yuan o Ming), testimoniando la consolidata accettazione del concetto in Estremo Oriente.
Eccoci, dunque, al vantaggio funzionale e commerciale. L’impatto più immediato del Jiaozi fu la drastica riduzione dei costi di transazione e il miglioramento della logistica commerciale. Per la prima volta, i mercanti potevano spostare grandi capitali senza l’onere del peso e dell’ingombro delle monete di metallo, facilitando il commercio interregionale. L’accettazione da parte del pubblico del Jiaozi rifletteva un’inaspettata sofisticazione finanziaria della società Song, che era disposta a superare il tradizionale attaccamento al valore intrinseco del metallo in favore dell’efficienza e della comodità della valuta di credito. L’alta monetizzazione dell’economia Song aveva già abituato la popolazione a concetti astratti di valore. L’iniziale diffusione e popolarità del Jiaozi si basarono sulla fiducia implicita nella stabilità politica e nella capacità dello stato (o, inizialmente, degli emittenti privati) di onorare quella promessa. L’iniziale propensione all’uso delle denominazioni più basse evidenzia che l’innovazione ebbe un impatto positivo e “democratico” sul popolo comune. La cartamoneta non era solo uno strumento per i grandi banchieri e commercianti (note di alto valore), ma forniva un mezzo di scambio pratico e leggero per la popolazione che doveva effettuare transazioni quotidiane in sostituzione delle scomode monete di ferro. Questo ampio consenso iniziale era la base della legittimità del Jiaozi.
E’ importante sottolineare che il Jiaozi non sostituì interamente la moneta metallica durante la Dinastia Song Settentrionale; al contrario, le due forme di valuta coesistevano e venivano utilizzate in parallelo. Questa coesistenza era fondamentale per mantenere la fiducia: fino a quando il Jiaozi poteva essere convertito o utilizzato in concomitanza con il metallo, manteneva il suo legame con il valore intrinseco percepito. Tuttavia, il successo iniziale della cartamoneta fu presto minato da un conflitto fondamentale: lo stato iniziò a vedere la cartamoneta non più come uno strumento per facilitare il commercio (come desiderava il pubblico), ma come uno strumento per finanziare le sue vaste spese, in particolare quelle militari, tipiche di una dinastia costantemente minacciata ai confini. Quando l’obiettivo fiscale prevalse sull’obiettivo di stabilità monetaria, la fiducia popolare venne inevitabilmente distrutta. Il fallimento del Jiaozi costituisce un caso di studio storico fondamentale sulla fragilità della valuta di credito non supportata dalla disciplina istituzionale. Una crisi, dunque, interamente auto-inflitta e derivante dalla tentazione del governo di sfruttare il potere di stampa per coprire i propri deficit.
La causa principale del deterioramento del Jiaozi fu la totale incapacità del governo di regolare correttamente la sua produzione, portando a un tasso di inflazione eccessivamente alto. Gli studiosi di storia monetaria evidenziano come i governi tradizionali cinesi, operando in assenza di vincoli amministrativi esterni, spesso non fossero in grado di gestire in modo competente l’emissione e la circolazione della cartamoneta. La crisi non fu primariamente un problema tecnico (la contraffazione, sebbene presente, era mitigata dai sigilli), ma un problema politico-fiscale. Quando lo stato si trovava di fronte a crescenti esigenze di spesa, spesso dovute alla necessità di mantenere ingenti eserciti per difendersi dai rivali settentrionali (come i Jin), l’emissione di cartamoneta rappresentava la soluzione più rapida per finanziare il bilancio.
La vicenda della cartamoneta cinese è dunque intrinsecamente legata a un fallimento politico istituzionale che ne impedì la sostenibilità sul lungo termine. Oggi che una stablecoin ancorata all’euro può manifestare appieno la sua affidabilità offrendo garanzie stabili e durature nel tempo, oggi che il rispetto delle regole tradizionali del sistema finanziario sgombra il campo da legittime obiezioni, oggi, proprio oggi, è il momento del coraggio. La storia del Jiaozi è lì a ricordarci che le opportunità sono sì cicliche, ma non infinite. Darle in pasto alla miopia sarebbe un errore imperdonabile.
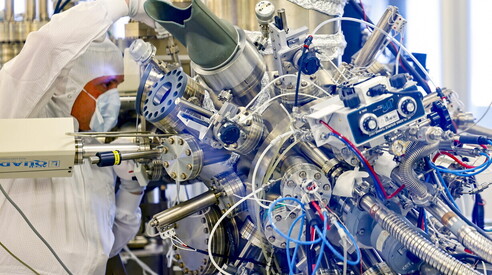


lottizzazione e lauree




