
Xi Jinping (Ansa)
Magazine
La crisi dell'economia cinese. Un dragone assediato da Trump e dai debiti
Il 2025 è l’anno del serpente che porta adattamento. Ma Pechino riuscirà a far fronte al nuovo scenario internazionale? Quant’è difficile rispondere con il regime che censura tutti i dati
Quando il duca di She gli domandò del governo, il Maestro Kong disse: la politica sta nell’attrarre i lontani e avere il consenso dei vicini”. Xi Jinping, che ha rilanciato l’insegnamento di Confucio come instrumentum regni, ha cercato di attrarre i “lontani” con la Nuova via della seta. Ora, sotto l’attacco dei dazi di Trump, vuole usare i “vicini” come scudi e come tributari nello stesso tempo. La storia per l’antica cultura cinese è ciclica e il vivido senso del passato esclude l’idea di progresso, ma quell’antico ciclo oggi non si ripeterà. Il sud-est asiatico è il centro del nuovo mondo, tuttavia la Cina non è più né il Celeste impero né il Regno di mezzo. All’alba del 1500, l’Italia, o meglio il suo centro-nord, era l’area più ricca del pianeta, con un reddito annuo per abitante equivalente a 1.100 dollari del 1990. La Cina con 600 dollari era il paese più ricco dell’Asia. Nel 1820 l’Italia era stata quasi raggiunta dalla Germania, superata dalla Francia e surclassata dalla Gran Bretagna con 2.122 dollari, il doppio degli Stati Uniti. La Cina era rimasta a 600 dollari pro capite. Una stagnazione plurisecolare che ha aperto la strada al crollo dopo le guerre dell’oppio. L’Italia si è risvegliata solo con l’Unità. In Asia è stato il Giappone a fare da lepre quando nel 1868 decise di aprirsi all’Europa e all’America: “tecnica occidentale, modello nipponico” era diventata la parola d’ordine della dinastia Meiji. In Cina invece, nella battaglia tra chi voleva imparare dai barbari, chi voleva trattare con loro e chi li voleva ricacciare al di là del mare, prevalsero questi ultimi. Gli imperatori Qing, calati dalla Manciuria nel XVII secolo, sconfitti i Ming, chiusero il paese, imposero l’umiliante codino agli Han e alle altre etnie, e nell’incontro/scontro con l’occidente prepararono il loro declino. Il pil pro capite, immutato per quasi quattro secoli, nel 1950 era sceso a 448 dollari. Il Giappone stava per toccare quota duemila.
La svolta di Deng Xiaoping ha cambiato tutto. Il reddito pro capite si è moltiplicato, alla svolta del nuovo millennio era oltre i tremila dollari del 1990, ma attenzione: il Giappone era a 20.400 dollari, Italia, Germania e Gran Bretagna attorno ai 18 mila, gli Stati Uniti a 27.300 (alla faccia del declino). Deng ha cominciato nel 1978 il cammino delle quattro modernizzazioni partendo dalla terra, che Mao aveva affidato alle comuni: trasformate in municipi e contee, hanno la possibilità di affittare e in parte cedere i diritti sul suolo, così i contadini si sono trasformati in agricoltori, gli artigiani in imprenditori. Jiang Zemin ha potenziato le aziende di stato e aperto le porte al mercato internazionale: è lui a entrare nell’Organizzazione mondiale del commercio. Sia Hu Jintao sia Wen Jiabao hanno riformato il mercato interno e introdotto la sicurezza sociale. Xi Jinping ha imboccato un’altra strada: centralizzazione, rafforzamento del potere del partito, uso delle campagne contro la corruzione per rinsaldare il suo potere, nuovo nazionalismo e un messaggio ideologico che cerca di mettere insieme Confucio e Mao Zedong, anche se il “Grande timoniere” aveva perseguitato suo padre Xi Zhongxun durante la Rivoluzione culturale. Con la pandemia la “restaurazione” è diventata un giro di vite, il “sogno cinese”, parola d’ordine lanciata da Xi, s’è trasformato in incubo, il Dragone rosso, ormai assediato, ha cominciato a sputare fumo, non più fiamme. D’accordo, siamo partiti da molto lontano, ma quando guardiamo alla Cina, alla sua ambizione di diventare la prima economia mondiale e la prima potenza in assoluto, rimpiazzando un’America sempre sull’orlo di una crisi di nervi e surclassando la sonnolenta Europa, non ci rendiamo conto che quello cinese resta un paese povero e ha un bisogno assoluto di continuare a crescere a ritmo elevato, forse non quanto negli ultimi trent’anni, ma molto più dei suoi rivali occidentali e orientali; è la condizione stessa della stabilità, e oggi è sotto aperta minaccia.
L’enigma della crescita
“La Cina può continuare la sua ascesa?”, si chiede Foreign Affairs. La divergenza tra le cifre ufficiali e altre fonti continua ad aumentare ed è diventata una questione centrale per chi vuol fare business, ha scritto Joe Leahy sul Financial Times. E’ lui che parla di enigma. Il Fondo monetario internazionale ha preso per buona la percentuale del 5 per cento. Goldman Sachs invece stima un 3,7 per cento nel 2024; Rhodium group scende a una forchetta tra il 2,4 e il 2,8 per cento. A dicembre Gao Shanwen, eminente economista della Sdic Securities, compagnia finanziaria controllata dallo stato, in una conferenza a Washington ha parlato di un ritmo del 2 per cento e ha confessato: “Noi non conosciamo i veri numeri del pil reale”. Il Wall Street Journal ha messo insieme tutti i casi di informazioni negate in merito a indicatori chiave come la compravendita di terreni, gli investimenti esteri, la produzione di soia, la disoccupazione particolarmente elevata tra i giovani, persino le cremazioni: non sappiamo ancora quanti sono stati morti per Covid-19, un numero che oscilla tra 1,3 e 2,1 milioni di persone. Sono ormai centinaia i dati che l’ufficio centrale di statistica ha smesso di pubblicare. Quando un anonimo sul sito dell’istituto ha chiesto il perché, si è sentito rispondere che lo aveva deciso il ministero. Così si è costretti a usare un ventaglio di indicatori e di segnali indiretti come i consumi elettrici, l’illuminazione notturna, gli incassi ai botteghini delle sale cinematografiche. Oxford economics mette l’accento su due grandi fattori di debolezza: la deflazione e il debito. “Quanto va davvero male la Cina?”, ha titolato il Wall Street Journal. Con una mossa molto keynesiana Pechino ha ridotto il tasso d’interesse di riferimento all’1,4 per cento appena, e il governo ha consentito alle banche di pompare più moneta anche riducendo le proprie riserve.
Il 2025 è l’anno del serpente che porta con sé trasformazione e adattabilità. Ma la Cina potrà adattarsi al nuovo scenario internazionale? E fino a che punto può davvero cambiare il suo modello trainato dalle esportazioni? Il vero pericolo non è un collasso immediato, ma una stagnazione con imprese zombie, in particolare immobiliari, e banche, soprattutto quelle locali, che tirano avanti come morti che camminano. Anni e anni di massicci investimenti hanno creato una sovrapproduzione soprattutto di veicoli elettrici, pannelli solari, acciaio, semiconduttori per i quali non c’è sufficiente domanda. Molte aziende restano aperte per non provocare un pesante impatto sociale (e alla lunga anche politico). Secondo alcune fonti sarebbero in pericolo 16 milioni di posti di lavoro. Zhang Dandan, un economista dell’Università di Pechino, ha fatto rumore sulla stampa quando ha dichiarato che la vera disoccupazione giovanile è al 46,5 per cento. Le cifre del governo parlavano del 21 per cento. Quindi il paese ha un bisogno assoluto di esportare il surplus che produce e si accumula nei magazzini e sui piazzali.
La pandemia è stata un vero spartiacque, da allora i consumi interni non si sono ripresi, la gente guadagna meno e spende meno, i cinesi sono finiti, come già i brasiliani o gli indiani, nella “trappola della classe media”, la situazione in cui il reddito pro capite ha raggiunto un livello oltre il quale è impossibile andare senza cambiare modello di sviluppo. In Cina le riforme sono fallite e ora se ne paga il prezzo, ha scritto Daniel H. Rosen, fondatore del Rhodium group, società indipendente di ricerca specializzata in particolare sull’Asia. “Pochi investitori in Cina e in giro per il mondo si sono resi conto che il sistema ha provato a riformarsi, ma non c’è riuscito. Xi può anche pensare di avere un altro decennio davanti a sé, ma in realtà c’è molto meno tempo prima di arrivare alla fine della crescita”. L’autonominatosi nuovo Mao dal 2014 in poi ha compiuto due passi avanti e due indietro, continua Rosen parafrasando il titolo di un famoso saggio di Lenin (“Un passo avanti e due indietro”).
Un mare di debiti
Secondo i dati ufficiali, il debito statale sfiora ormai il 90 per cento del prodotto lordo con un aumento di quaranta punti percentuali dal 2019. Ma se ci aggiungiamo il debito privato e quello locale, arriviamo a oltre 280 per cento, una stima per difetto se si pensa che i debiti delle imprese toccano il 172 per cento del pil. Per capire come la Cina è giunta a questo punto, bisogna guardare al suo modello economico. La terra appartiene formalmente alle comunità locali, ma in tutti questi decenni le concessioni urbane o le vendite agricole hanno via via coperto la metà dei loro bilanci. La maggior parte del denaro viene da prestiti garantiti attraverso una rete di società chiamate veicoli finanziari del governo. Grattacieli, autostrade, ponti, ferrovie ad alta velocità, tutto è stato possibile grazie a questo meccanismo che ha gonfiato una gigantesca bolla. I prezzi dei terreni sono sempre aumentati finché negli ultimi dieci anni non si sono manifestati i primi crack in campo immobiliare. Nel 2021 Evergrande, una delle maggiori società, non è stata in grado di pagare i suoi debiti: il governo cinese ha tamponato il crollo indebitandosi. Nel gennaio dello scorso anno un tribunale di Hong Kong ha ordinato la sua liquidazione, schiacciata da 300 miliardi di dollari che non potrà mai restituire. E’ vero che tutto il sistema creditizio è in mano allo stato, ma le banche locali e le quattro grandi nazionali (Agricultural Bank, Bank of China, China Construction Bank, Industrial and Commercial Bank), se valutate con i criteri occidentali, dovrebbero essere dichiarate insolventi.
L’intero scenario è peggiorato dal 2021 quando il governo è stato costretto a un giro di vite creditizio, non potendo più nemmeno contare sul continuo gonfiamento dei valori immobiliari. Le vendite delle case sono crollate del 48 per cento, sempre più immobiliaristi sono finiti in bancarotta. Beike Research, un think tank cinese, in un suo rapporto pubblicato nel 2022 stimava che il 28 per cento degli stabili erano vuoti. Molti veicoli finanziari comunali sono insolventi, se falliscono trascinano l’intero sistema bancario ed economico cinese innescando una crisi peggiore di quella del 2008; se vengono salvati il fardello del debito diventerà ancor più pesante. Parte dell’indebitamento dello stato centrale è dovuto non solo all’introduzione della sicurezza sociale, ma anche alla vera e propria corsa agli armamenti avviata nel primo decennio dell’era Xi.
Il complesso militar-industriale
La spesa per la sicurezza è stimata dal Pentagono tra i 330 e i 450 miliardi di dollari. La Cina vende armi, è al quarto posto al mondo dopo Usa, Russia e Francia. Al 19esimo congresso del Partito comunista che si è svolto nel 2017 e ha consolidato il suo potere, Xi Jinping ha promosso una élite militar-industriale la cui presenza nel governo è aumentata ancora dal 2022, spiegano Arthur Ding e Tristan Tang della Jamestown Foundation. Proprio questa rappresenta la fazione rampante del partito. Si tratta di un gruppo coeso, che condivide identità, cultura, competenza, tanto da far parlare di complesso militar-industriale modello cinese. Dal 20esimo congresso occupa posizioni chiave nella pianificazione politica, nella gestione e regolamentazione delle risorse, nella trasmissione di informazioni anche oltre la difesa in senso stretto. L’uso duale delle tecnologie informatiche ha una ricaduta anche sull’innovazione nel suo complesso, come nel modello già sperimentato dagli Stati Uniti. In questi anni il settore militar-industriale non si è solo ingrandito, ma è diventato efficiente e moderno. Se sarà sempre più determinante sulla scacchiera del potere dipende da diversi fattori, ma molti si aspettano che il congresso previsto l’anno prossimo sancirà la sua ascesa al vertice.
Quanto è forte l’esercito cinese? E’ grande, il più grande al mondo con due milioni di militari attivi, mezzo milione di riserve e altrettanti paramilitari. Secondo il China Military Report del Pentagono possiede più di 600 testate nucleari e ne avrà un migliaio nel 2030, in grado di colpire il territorio americano in vista di un conflitto armato. Il casus belli potrebbe essere Taiwan, e non solo. La minaccia atomica va presa sul serio. Ma l’escalation militare riguarda tutti i settori a cominciare dalla marina, in cui la Cina ha sempre avuto una storica debolezza e ha puntato su missili balistici anti navi. Ora l’istituto navale americano stima che Pechino possa contare su una formidabile flotta di imbarcazioni da guerra, dagli incrociatori lanciamissili alle portaerei. E’ molto ingenuo pensare che la Cina sia capace solo di copiare le innovazioni occidentali, lo ha fatto come tutti i paesi a sviluppo tardivo (si pensi al Giappone), ma un recente rapporto dell’Information and Industry Foundation sottolinea che il Dragone rosso in sei anni possa raggiungere il top dell’innovazione tecnologica e il complesso militar-industriale è la forza trainante. Considerata la “fabbrica del mondo”, la Cina ambisce a diventare il “laboratorio del mondo” sviluppando sempre più tecnologie fatte in casa, come dimostrano DeepSeek, formidabile rivale di ChatGpt nell’intelligenza artificiale dove Pechino conta di investire mille miliardi di dollari, la BYD, che sta sorpassando Tesla nell’auto elettrica, Huawei e Vivo, rivali di Apple nella telefonia. E non saranno le tariffe di Trump a fermare questa lunga marcia. Non solo: è poco noto, ma i militari sanno quante componenti cinesi ci sono nelle navi e nell’armamento americano.
Dall’oppio ai dazi
Fa parte della nuova ortodossia introdotta da Xi Jinping gettare sull’aggressione occidentale la causa del secolare declino cinese. In realtà la colpa principale ricade sulla cieca chiusura della dinastia manciù, esasperata dall’imperatrice reggente e suo nipote Guangxu, il debole imperatore che lei aveva reso suo schiavo. Così come è stata l’intransigente ideologia maoista a scatenare, in particolare con la Rivoluzione culturale, la peggiore carestia della millenaria storia cinese. L’ingresso nell’Organizzazione mondiale del commercio senza sostanziali contropartite era concepito da Pechino come una sorta di riparazione per quella che nei rapporti economici con l’occidente, dalle Guerre dell’oppio alle guerre contro la Francia prima e il Giappone poi, era stata concepita come una spoliazione, con la frantumazione del Regno di mezzo costretto a concessioni che da mercantili erano diventate chiaramente coloniali. Per gli Stati Uniti presieduti da Bill Clinton, che spinsero molto perché Pechino entrasse, l’Omc era una prosecuzione della “politica della porta aperta”. La svolta di Trump è un balzo indietro di un secolo e mezzo. Questo spiega in parte la violenta irritazione e la immediata replica “a muso duro” inusuale nella condotta diplomatica cinese. L’export viene colpito con tariffe che arrivano al 240 per cento e Pechino ha reagito subito con un prelievo del 125 per cento sulle importazioni dagli Usa. “Combatteremo fino alla fine”, ha sentenziato il presidente Xi. La Cina è il maggior partner commerciale di ben 60 paesi (il doppio rispetto agli Stati Uniti) e ha accumulato un attivo record di mille miliardi di dollari. La Banca centrale detiene titoli di stato americani per 700 miliardi, altri 200 sono a Hong Kong. Che cosa succede se vengono venduti? Xi può usare il debito a stelle strisce per placare i poco eroici furori di Trump, a costo di subire pesanti perdite e di diventare il mostro che ha scatenato una gigantesca crisi mondiale. La pistola non è scarica, ma per il momento resta nella fondina in attesa di essere gettata sul tavolo del negoziato. Pechino alla ricerca di sbocchi corteggia l’Europa, sia l’Unione sia i singoli paesi, però il fallimento della Nuova via della seta ha lasciato l’amaro in bocca. Nonostante gli schiaffoni di Trump, e al di là delle risposte diplomatiche alle avance, non è realistico pensare a un asse con l’Europa contro gli Stati Uniti, lo sostengono anche molti analisti cinesi. E per gli europei, se è vero che da oltre Atlantico arrivano minacciose ondate di incertezza, ci si chiede quanta incertezza potrebbe arrivare dalla muraglia cinese. La vera arma nelle mani di Pechino è il controllo delle materie prime strategiche, una guerra che i cinesi stanno vincendo, secondo il Wall Street Journal. La Cina conta già il 61 per cento della produzione mondiale di terre rare e il 92 per cento della loro raffinazione. Il paese ha enormi depositi di disprosio usato nelle batterie dei veicoli elettrici e nelle turbine a vento, per non parlare dell’ittrio, materiale resistentissimo al calore usato per rivestire i jet, o dell’antimonio, fondamentale nei diodi e nei rivelatori infrarossi. Pechino ha già reagito alle tariffe trumpiane restringendo l’export di sette terre rare e questo mette in serie difficoltà l’industria americana a cominciare da quella della difesa. Perché gli States non posseggono tutto quello di cui hanno bisogno.
Austerity in salsa di soia
La paura dell’impatto disgregatore che l’occidente ha avuto sulla Cina si è trasformata dopo un secolo e mezzo in competizione per il primato. Senza dimenticare l’ambizione culturale collegata al grande progetto della Belt and Road Iniziative che emerse con chiarezza fin dal 2008, l’anno delle Olimpiadi e del trionfalistico show di apertura, l’anno in cui la crisi finanziaria scoppiata negli Stati Uniti aveva fatto proclamare la fine del secolo americano e l’inizio del predominio cinese (quanti libri di successo sono stati scritti anche in Italia per annunciare l’Armageddon del turbocapitalismo). Se la Cina segue il percorso degli altri grandi paesi in via di sviluppo dovrà attraversare un periodo di austerità e bassa crescita che avrà un forte impatto negativo sull’economia mondiale, anche a prescindere dai dazi, ma attenti a sottostimare il Dragone rosso, avverte Kurt M. Campbell, presidente e cofondatore dell’Asia Group: “Anche se la crescita rallenta e il suo sistema di potere incespica, la Cina resta strategicamente formidabile”. Non c’è dubbio che stia fronteggiando un insieme di problemi molto seri: l’invecchiamento della popolazione, un ristagno della produttività, la disoccupazione giovanile, la crisi immobiliare, il debito, le aziende zombie e tutto quello che abbiamo raccontato, “ma anche le gravi sfide macroeconomiche non si traducono in uno svantaggio strategico”, aggiunge Campbell. Anzi si crea un pericoloso paradosso: una Cina che rallenta può diventare una minaccia strategica persino peggiore. Pechino potrebbe pensare di compensare le sue debolezze interne con una maggiore aggressività esterna.
L’imperialismo tributario
Quanto è solido il nuovo imperatore? Secondo Guoguang Wu, del Centro sull’economia e le istituzioni cinesi dell’Università di Stanford, “il potere di Xi ha raggiunto il picco in termini di posizione formale al vertice della gerarchia e di dominio organizzativo, sorpassando qualsiasi altro predecessore compreso Mao. Al contrario, il suo esercizio del potere è stato negativo soprattutto dal XX congresso”. Ha fatto un pessimo lavoro nel promuovere lo sviluppo, gestire le relazioni internazionali e fornire alla società cinese i benefici promessi. Ha usato la guerra alla corruzione come mezzo per consolidare la sua presa sul partito, ma la corruzione è diventata ancor più diffusa: il National disciplinary inspection and supervision system nel 2023 ha gestito 12.400 indagini e ha punito oltre duemila funzionari, più che nel 2019 e in linea con quanto avvenuto nel 2022. Una politica estera aggressiva potrebbe servire a bilanciare le modeste prove domestiche. Il mondo secondo Xi, ha scritto Kerry Brown, direttore del Lau China Institute al King’s College di Londra, è diviso in quattro zone: la prima è occupata dagli Usa, la seconda dal sud-est asiatico, la terza dall’Unione europea, la quarta da tutto il resto: medio oriente, America latina e Africa. Il confronto con gli Stati Uniti dunque è la priorità. Un’egemonia cinese sui “vicini” evocati da Confucio potrebbe essere un’arma importante se fosse possibile, ma proprio il resto dell’estremo oriente ha sorpassato la Cina come maggiore mercato di esportazione e non ha nessuna intenzione di cedere lo scettro. Il recente viaggio di Xi Jinping in Vietnam, Cambogia e Malesia non sembra aver prodotto i risultati attesi. Ad Hanoi sono stati firmati ben 45 accordi commerciali. Il Vietnam è diventato uno dei maggiori assemblatori industriali del sud-est asiatico, la Cina è il suo principale fornitore, gli Stati Uniti sono il primo mercato di sbocco, soprattutto di prodotti elettronici, scarpe, abbigliamento. Difficile allentare questa tenaglia, ma la priorità per un paese che è decollato grazie alla sua “americanizzazione” (si è scritto che gli Usa hanno perso la guerra militare e vinto quella economica) è trattare con Washington e ridurre l’assurda tariffa del 45 per cento imposta da Trump. Il Vietnam ha sempre sofferto l’opprimente vicinato cinese e non ha intenzione di diventare un tributario come lo è stato per secoli. Non solo. La Cina sembra circondata da una corona di paesi cresciuti con la globalizzazione e i cui interessi non coincidono con quelli di Pechino. Basti pensare all’Indonesia, mentre le Filippine e la Corea del sud sono nell’orbita americana. Ci sono poi le basi e le portaerei a stelle e strisce nell’area del Pacifico, mentre nell’estremo sud l’Australia fa da baluardo occidentale come il Giappone al nord. E poi Formosa, cioè Taiwan la cui capitale storica non è Taipei, ma Nanchino, la cui lingua è il mandarino.
La Cina si sente accerchiata e non ha torto. Tuttavia un colpo di mano di Xi Jinping farebbe precipitare questo precario equilibrio. Anche senza evocare l’Armageddon nucleare il Dragone rosso vedrebbe crollare l’intero suo cammino al di fuori dalla povertà. Davvero il “nuovo Mao” è disposto a rischiare? “Il modo più efficace per evitarlo è anche il più difficile: convincere Pechino che con una riunificazione armata perderebbe tutto”, sostiene Oriana Skylar Mastro, dell’Istituto studi internazionali di Stanford. Non possono farlo gli Usa da soli, hanno bisogno di creare un’ampia coalizione impegnata in una risposta coordinata a ogni aggressione cinese, come è stata la Nato verso l’Unione sovietica. Ma Trump non è certo Truman.
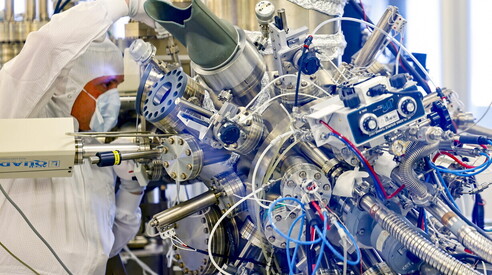


lottizzazione e lauree


