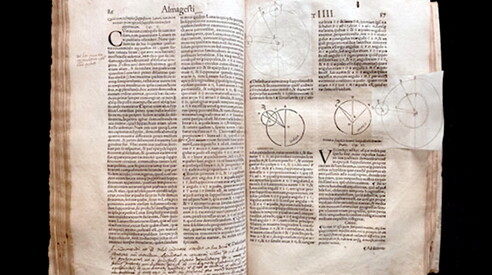Google creative commons
Il lato nascosto
La storia non detta di Garibaldi, agricoltore prima che “eroe dei due mondi”
Il pianto per la morte della sua cavallina, il disgusto per la legge Pica e la pietas verso l'ormai ex re Francesco II. I diari di Caprera, svelati nel libro di Virman Cusenza, restituiscono il lato meno frequentato del personaggio malgrado la sua monumentale presenza nella vulgata nazionale
L’oblìo, sostiene Borges, è una delle forme della memoria, “l’altra faccia segreta della moneta”. Sicché l’avere conosciuto e puntualmente trascurato che Giuseppe Garibaldi fu anche agricoltore a Caprera è stato il modo in cui l’Italia ha preferito ricordarlo. Non mostrando il rovescio della moneta ma soltanto la testa. Inconfondibile la sua, con barba, poncho e papalina. L’effigie tornò comoda di volta in volta alla retorica nazionale umbertina, all’epica risorgimentale del fascismo, alla propaganda del Fronte popolare nelle elezioni del 1948 quando i democristiani, manipolando il simbolo di quella coalizione, ricavarono dal Garibaldi capovolto il torvo faccione di Stalin (e stravinsero). Il volume di Virman Cusenza su "L’altro Garibaldi. I 'Diari' di Caprera", appena pubblicato da Mondadori nella collana “Le Scie”, rigira la moneta agiografica restituendo con affettuosa precisione, in poco più di 200 pagine, il lato meno frequentato del personaggio malgrado la prolifica attenzione degli storici e la sua monumentale presenza nella vulgata nazionale. Tra un dirne male che non si poteva e un dirne bene che non si doveva più, negli ultimi decenni, a sud del Garigliano.
I diari agricoli di Garibaldi, per la gran parte inediti, sono il documento principale cui ha attinto Cusenza e rivelano che Caprera fu molto più del buen retiro che accolse il condottiero con qualche sacco di granaglie dopo la spedizione dei Mille, come s’accontentano di riferire i manuali di Storia. Né fu soltanto il santuario laico meta di pellegrinaggi politici (da Bakunin a Craxi) e turismo celebrativo durante e dopo la vita dell’“Eroe dei due mondi”. L’isola fu piuttosto, nota Cusenza, “la comfort zone da cui spiccare il volo per fare l’Italia, un pensatoio sospeso per ritrovare i confini – anche corporei – dell’uomo Garibaldi”. Prima e dopo l’Aspromonte nel ’62, la Terza guerra d’indipendenza del ’66, la sfortunata impresa romana del ’67 e la guerra franco-prussiana del ’70-’71, il generale si faceva contadino e con lo stesso fervore adoperato sui campi di battaglia si dedicava ai campi scabri di Caprera, deviando corsi d’acqua, costruendo muri a secco, piantando ulivi e alberi da frutto, ortaggi e fiori (detestò le fanciulle che scempiavano margherite con il “m’ama non m’ama”). Se avesse saputo maneggiare la penna come la sciabola e la vanga, le sue accurate osservazioni diaristiche sulla flora avrebbero prodotto qualcosa di simile al meraviglioso 533. Il libro dei giorni di Cees Nooteboom, ma Garibaldi non brillava per talento letterario e i romanzi che scrisse sull’isola per fare qualche quattrino riscossero modesti consensi. Molta più soddisfazione gli diedero i mulini, il nuovo macchinario per la trebbiatura, gli alveari, l’allevamento di un migliaio di animali, le serate con la famiglia allargata e una cerchia di devoti con cui si divertiva anche a ballare finché l’artrite feroce che lo affliggeva non lo costrinse addirittura in carrozzella.
Ripercorrendo quei ventisei anni d’amore tra Garibaldi e l’isola, dall’acquisto del primo appezzamento il 29 dicembre 1855 alla morte nel 1882, Cusenza rilegge in filigrana anche la vicenda pubblica, le vittorie, le tante delusioni, le relazioni politiche che nell’economia biografica non schiacciano mai i rapporti intimi, la coltivazione della terra, i burrascosi legami sentimentali, le preoccupazioni famigliari, la cura per gli animali e le considerazioni spirituali (dove l’anticlericalismo del massone ottocentesco si coniuga al disprezzo per il “miserabile materialismo”). L’altro Garibaldi ci conferma l’idea che ogni moneta, anche musealizzata, debba essere studiata bene nel rovescio, perché l’artificio storiografico di separare il personaggio dall’uomo finisce per falsare l’uno e l’altro. Così sappiamo dai diari che a Mentana, mentre fronteggia i francesi armati di fucili a retrocarica, Garibaldi sta pensando ai portainnesti degli agrumi, e non appena riguadagnerà Caprera si dedicherà con solerzia alle potature in arretrato. Perciò i notissimi contrasti con Mazzini e Cavour non discendono soltanto da divergenti visioni politiche ma dall’inevitabile reciproca distanza tra chi sa timonare una nave e chi no, però è capace di tesser trame a tavolino; tra chi s’espone al tiro dei moschetti e chi dal protetto rifugio all’estero invita gli altri al sacrificio; tra chi maneggia la zappa su un terreno comprato a rate e un conte piemontese che affida ai suoi braccianti i vasti possedimenti ereditati.
Garibaldi poco somigliava al Franco Nero nel quale lo rivide Luigi Magni o a come lo ha modellato spesso la statuaria; non cavalcò un bianco destriero nell’impresa dei Mille ma una giumenta baia su cui, già artritico, dovevano aiutarlo a montare; appena arrivò a Napoli col treno, questo lo ricordiamo noi con borbonica malizia, scese dal lato opposto del vagone per una inderogabile impellenza e poi si presentò alla folla accalorata dalla camorrista De Crescenzo (ogni allusione a ricorsi storici è casuale o è puramente colpa di Giambattista Vico). Eppure, il libro di Cusenza riconcilia anche il lettore meno empatico perché informa che l’eroe si portò a Caprera quella cavallina di nome Marsala e pianse disperato quando gli morì alla veneranda età di trent’anni. Ci ricorda il suo disgusto per la legge Pica, che per reprimere l’insorgenza legittimista etichettata “brigantaggio” tout court diede licenza ai peggiori massacri di italiani (per chi comandava i bersaglieri si trattava però di piemontesi contro “affricani”). Ci racconta della pietas verso l’ormai ex re Francesco II: “‘Povero giovane! Nato ai piedi d’un trono… e forse non per colpa sua… sbalzatone lontano! Proverà anch’egli l’amaro dell’esilio… senza preparazioni’. All’obiezione che però la caduta di Francesco II era la conseguenza dello sbarco a Marsala, il generale replica serafico: ‘Era il dovere di noi tutti l’andarvi. Altrimenti come poteva essere una l’Italia?’. Spiazzati dalle evangeliche riflessioni, i suoi si rigirano la battuta, dandosi di gomito: ‘L’uomo è tale che, se perfino Pio IX, il cardinale Antonelli e Francesco II fossero poveri e senza asilo, non solo li riceverebbe a Caprera, ma cederebbe anche la sua camera e il letto!’. È fatto così, l’uomo”.
Così era fatto fuor d’iconografia. Finché le dita glielo consentirono si rammendava i pantaloni; rischiò l’osso del collo per salvare un agnellino smarrito tra i dirupi; chiese, anzi pretese di essere cremato su una pira come i guerrieri antichi, ma a lui che ebbe per motto “obbedisco” disobbedirono i parenti. “Non inganni l’aura da nonno di Che Guevara che gli è stata affibbiata nei decenni, a seconda delle convenienze. Alla fine,” avverte Cusenza, Garibaldi “è un legalitario che obbedisce al potere costituito anche quando ne dissente radicalmente, il contrario esatto del rivoluzionario tutto rum e fucili. Che strano impasto è stato Garibaldi, poco italiano nell’assenza di calcolo e di furbizia, molto italiano nella generosità dell’azione che prescinde da ritorni materiali o onorifici”. All’atto della morte, in anagrafe risultò iscritto come “agricoltore”.