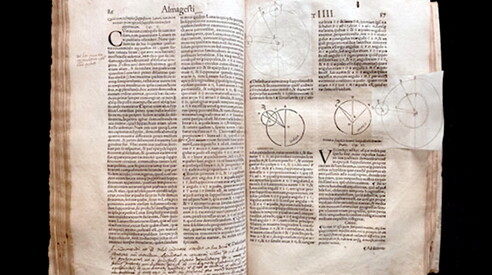Getty
la mostra
La collezione del Leone ai Musei Vaticani
Non solo critico e giornalista, Piccioni fu anche un gran cultore d’arte. Ecco la mostra con i capolavori da lui raccolti con opere di artisti come Burri, Morandi e Guttuso
Che meraviglia questa marina di Carrà: è un’opera del 1952 e ora la si può vedere dal vero e a colori. L’onda gentile della Versilia, che ora pare morta e grigia, nel dipinto evoca quella della mia infanzia, viva e selvaggia di verdi e di blu; e solcata da piccole imbarcazioni da pesca. In quest’olio su tela, ce n’è una tirata in secco su un arenile di un rosa-oro impensato. La spiaggia larga e liscia ai piedi delle Apuane, quella che oggi sembra una sequenza di finti salotti beduini accomodati sulla sabbia, in questo Carrà appare come se fosse novità assoluta. Eppure non lo è, negli anni Sessanta questa marina era notissima: dal 1963 fu l’immagine fissa nella sigla dell’antenato di tutti i programmi culturali tv, ispirato nel nome proprio da questo quadro: L’Approdo. Solo che dal teleschermo usciva in bianco e nero; e senza quei colori stupefacenti appariva quasi irriconoscibile. “La marina dell’approdo” di Carlo Carrà, realizzata dall’artista in vecchiaia – quando si godeva la fama e lunghi soggiorni al Forte dei Marmi con la moglie Ines, in quieta modestia giocando a bocce con gli amici, adesso si può vedere a Roma nelle stanze della Torre Borgia, dove fino al 18 aprile 2026 resta esposta tra le opere della Collezione di Leone Piccioni. I suoi figli – in occasione dei cent’anni della nascita del padre – hanno donato ai Musei Vaticani un nucleo di opere importanti. Nato nel 1925, italianista e critico letterario, Leone Piccioni fu allievo di Giuseppe De Robertis e poi di Ungaretti, di cui divenne un figlio elettivo. Ma è stato anche alto dirigente della Rai di Bernabei, responsabile della pagina culturale del Popolo e poi direttore del settimanale della Democrazia cristiana, La Discussione; e infine cultore d’arte e di musica jazz e grande collezionista. Lo si capisce subito passeggiando per le stanze dei Borgia, dove le opere sono esposte lasciando a ciascuna lo spazio che consente di vederla.
Ormai mostre e musei soffrono di un soffocante affollamento visivo, che acceca per bulimia ottica. Nell’allestimento de “L’irrefrenabile curiosità. Capolavori del Novecento dalla collezione di Leone Piccioni”, si possono ammirare opere non solo di Carrà ma anche di Burri, Morandi, Rosai, Schifano, Guttuso, Fautrier, Dorazio, De Pisis, Ceroli e molti altri grandi nomi del Novecento italiano. Sono opere scelte assecondando il gusto personale, Piccioni le teneva per sé e non acquistava per investire e rivendere, o per esibire ricchezza e prestigio sociale; comprava spinto dalla stessa passione con cui si acquistano libri: affascinato dai processi creativi che li avevano generati, frequentava gli atelier degli artisti e diventava loro amico. In questo era davvero “figlio” di Ungaretti, col quale si era laureato a Roma nel 1946, discutendo una tesi sulle varianti delle Canzoni di Leopardi. Il poeta aveva infatti uno spiccato interesse per l’arte contemporanea e quando viveva a Parigi, prima della Grande Guerra, aveva frequentato Picasso e Braque, Modigliani e Boccioni, Carrà e molti altri artisti. Ungaretti aveva idee e gusti molto definiti in fatto d’arte contemporanea. Negli annali dell’Approdo – il programma coordinato da Piccioni, che nel comitato direttivo ebbe anche Carlo Bo e Roberto Longhi, Emilio Cecchi e Riccardo Bacchelli – è rimasta l’intervista in cui Ungà dice energicamente che il dipinto più bello del mondo, dopo il Giudizio di Michelangelo, è Guernica di Pablo Picasso. Dopo l’andaluso geniale, tra i più grandi artisti viventi, il poeta metteva uno dei padri dell’Informale, Fautrier, e poi Fontana e Burri, che in lui aveva mosso lo stesso meraviglioso sconcerto del primo incontro con Picasso. Mentore della scuola romana, Ungaretti considerava Scipione, presente in questa mostra con un’esplosione di colori che allude al proprietario dell’opera – il fantastico trittico, “Foresta+tana+leone+leone” – come “il più grande dei surrealisti”. E qui si può vedere “Fiori” di Mario Mafai, realizzato nel 1958 su un fondo lapislazzuli che Ungà riteneva, lo scrive in margine a una lettera a Piccioni nel 1966, “una delle invenzioni pittoriche più straordinarie che si possano vedere”. Con il suo Maestro, Piccioni andava a conoscere gli artisti. Silvia Zoppi Garampi, studiosa dei carteggi tra i due e autrice di uno dei saggi del catalogo, curato da Micol Forti e pubblicato dalle Edizioni dei Musei Vaticani, spiega che il dialogo tra loro era continuo. Arrivati a casa, Leone e Ungà si scrivevano per seguitare il discorso, anche se si erano lasciati per strada mezz’ora prima. Così eccoli insieme nello studio romano di Burri, sulla Salaria, introdotti da Bona De Pisis. Piccioni ha lasciato un suggestivo ricordo di quell’incontro, avvenuto alla fine degli anni Cinquanta, nel suo ormai introvabile Maestri e amici (Rizzoli, 1969). In Burri vide “la schietta semplicità” di un uomo libero, “giunto alla pittura e alle arti senza nessuna formazione e incrostazione accademica”. Nel suo atelier sentiva di assistere a un evento drammatico, a un “transito”. Nelle superfici gibbose delle opere, oppure solcate di crateri e gonfie di bubboni, fatte di legni bruciati e sacchi tagliati e ricuciti, riconosceva il lavoro di un “pittore medico”, che analizza “fisiche piaghe radiologicamente accertate” e cura “ferite sanguinanti” suturando i sacchi “con geometrico gusto inventivo”. Davanti al lavoro di Burri, Piccioni pensa d’essere di fronte a un avvento: prima o poi queste visioni – scrive – coinvolgeranno anche “il mio modo di pensare e di intendere le cose”; e così quello di tutti noi. In cerca di un paragone letterario, lo trova ne “La Ginestra” di Giacomo Leopardi, dove vita e speranza bucano la crosta della nera terra vulcanica. Leone si innamora e traccia il ritratto di un umbro “senza sofisticherie”, legato alla terra, concreto e di poche parole, che ama la caccia. Uno partito per la guerra d’Africa e finito in un campo di prigionia nel Texas, lo stesso dove fu Giuseppe Berto. Uno che sa di aver perso la guerra ma non si vuole mettere coi vincitori. Leone lo guarda lavorare mentre ascolta la musica di Edgard Varèse con la giovane moglie americana che gli ronza intorno, sempre in calzamaglia nera: si chiama Minsa, è ballerina e coreografa.
Per Piccioni letterato e collezionista d’arte, l’opera conta non meno dell’umanità del suo autore. Da ragazzo, Leone considerava la letteratura come una “profezia” e alla fine degli anni Sessanta l’aveva vista ridimensionarsi a “cronaca letteraria” e la guardava con una certa malinconia: ognuno ha la sua soglia del disincanto (vietati i paragoni con l’oggi). Era convinto che a poeti e artisti corrispondessero tipi umani singolarissimi: e se la loro umanità dovesse apparire “trascurabile”, scriveva, allora be’ meglio diffidare e rileggere… Il suo lavoro di critico e di collezionista, dunque, non poteva che essere una trama di relazioni. Lui, artisti e letterati, li andava a incontrare e amava frequentarli e spesso si lasciava intenerire dalle loro stravaganze. Qui parliamo di artisti e abbiamo fatto cenno a Burri con il quale ebbe una certa consuetudine, ma si potrebbe dire di Giorgio Morandi o di Renato Guttuso. Ecco Piccioni in visita a Bologna, nello studio di via Fondazza, dove Morandi lavorava a fare e rifare con rigore estremo. Era un “dir la stessa cosa”, annota il collezionista, “per dirle tutte insieme, per forza di variazioni interne”. Giorgio, l’uomo capace di ricominciare sempre da capo, gli resta in mente come un individuo “popolare e aristocratico”. Un tipo “alto alto, magro ma forte, il viso segnato, pronto a divenir maschera per polemica, per ironia o anche per controllata allegria, le braccia così lunghe da non sapere dove metterle”. Un soggetto “con l’aria di non saper nulla di nulla, sapendo tutto di tutto, svagato e invece attentissimo”; “con la vocazione a raccogliere in stretti simboli tutte le cose della terra”. Piccioni conobbe Morandi nel 1952. La loro amicizia – scrive Marilena Pasquali sul catalogo della mostra – è un triangolo che include anche lo storico dell’arte Cesare Brandi. E che negli anni Sessanta si allargherà ad altri sodalizi, incluso quello con Guttuso, artista agli antipodi rispetto alla pittura fedele e “borghese” di Morandi.
Di Guttuso, chi va a vedere “L’irrefrenabile curiosità” troverà il famoso “A Majakovskij”, un ritratto che accentua l’inquieta mobilità dello sguardo e dei tratti del viso, la posa sghemba del cappello e del carattere: un olio su tela dai colori freddi accesi per magia dal nero degli occhi del poeta comunista-futurista, morto suicida sotto Stalin nel 1930. Ma come fu che si accorciò la distanza, enfatizzata dal neorealismo, tra la pittura di Morandi e quella dell’artista engagé? Forse Guttuso era cambiato, tornando sui suoi passi? In Maestri e amici Piccioni glielo chiede direttamente. E l’artista “risponde, come sa, con modestia, con riflessione profonda e sincera, e con umiltà. Mi dice in sostanza di aver sempre cercato di fare le stesse cose, e che può essersi sbagliato credendo di seguire la stessa via giusta. Non pensa di aver cambiato strada. Sa che il suo temperamento è fatto in modo da non potersi, da non volersi, in certi momenti ‘rifiutare’, se nel rifiuto ci potesse essere anche solo il sospetto di rinunciare o di attenuare una parte di responsabilità che riguardi insieme l’arte e la società, secondo le sue credenze di sempre”.
Quei due erano pienamente se stessi e si parlavano affascinati uno dall’altro senza spogliarsi delle loro identità culturali e politiche. Piccioni usciva dalla Rai e andava a trovare Guttuso; Rocco, l’assistente del pittore, lo lasciava sbirciare tra le tele in lavorazione e lui se ne tornava in ufficio emozionato, con gli occhi pieni della Roma vista dal Pincio che stava su un cavalletto. Renato era notoriamente comunista e l’altro democristiano. Anzi, qualcosa di più: Leone era il figlio di Attilio Piccioni, il delfino di De Gasperi, politicamente silurato in seguito al coinvolgimento dell’altro figlio, Piero, il fratello musicista, nel caso della morte di Wilma Montesi. La ragazza era annegata nel mare di Torvaianica nell’aprile del 1953, Piero fu pienamente assolto nel 1955, ma prima era passato – come si direbbe oggi – nella macchina del fango. Leone Piccioni si considerò sempre, primariamente, un dirigente della Rai. L’Approdo era nato alla radio, a Firenze, nell’immediato dopoguerra, in collaborazione con Adriano Seroni. Poi andò in tv su Rai 1 per un decennio; e produsse per gemmazione una rivista letteraria, dove l’arte contemporanea fu affidata – per dare un’idea di quella grande officina – a Carla Lonzi. L’allieva ribelle di Roberto Longhi che sarebbe diventata il miglior cervello del neo-femminismo italiano. Ma in televisione Piccioni produceva anche spettacoli come Studio Uno con le Kessler e, tornato alla radio con il compito di rilanciarla, inventò il mitico palinsesto che aveva dentro Bandiera Gialla di Arbore e Boncompagni, Gran Varietà, la prima Hit Parade, Per Voi Giovani, cioè i programmi più innovativi di quella stagione.
Era, insomma, un intellettuale multimediale. Un po’ come lo furono – ciascuno a modo suo – Angelo Guglielmi, critico letterario e padre di Rai Tre; oppure Umberto Eco, entrato in Rai per concorso nel 1954 insieme con Furio Colombo e Gianni Vattimo, semiologo di fama mondiale, editore e romanziere, massmediologo e cultore di nuovi linguaggi: come il fumetto, che allora nessuno metteva certo tra le arti. Piccioni però era democristiano, e questo lo ingrigiva, ne appannava la forza innovativa: c’è stato un tempo cieco in cui l’aggettivo suonava per definizione retrogrado; quel tempo non abbiamo ancora finito di scontarlo. L’Italia contemporanea è stata un paese molto più vario, ricco (e grande) di come viene raccontato. Gloria Piccioni, e suo fratello Giovanni scomparso prematuramente circa un anno fa, hanno perseguito con passione e tenacia (le donazioni sono operazioni complesse) l’idea di trasferire parte significativa della collezione del padre ai Vaticani, cioè a uno dei musei più importanti del mondo. Va ad arricchire la sezione d’Arte moderna e contemporanea voluta da Paolo VI, che era partita con mille opere e oggi ne comprende quasi diecimila. In questa galleria straordinaria adesso c’è anche il “Giovannino” di Mario Marcucci, dipinto dall’artista viareggino nel 1955. E’ il poeta Giovanni Piccioni bambino, dolcissimo e tutto occhi; un ragazzino che guarda dentro il suo inesplorabile mistero.