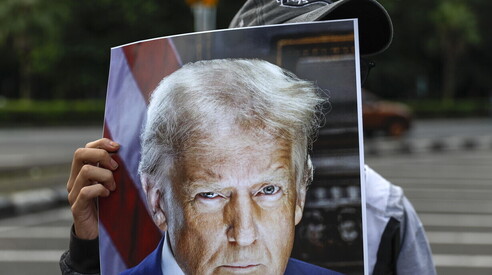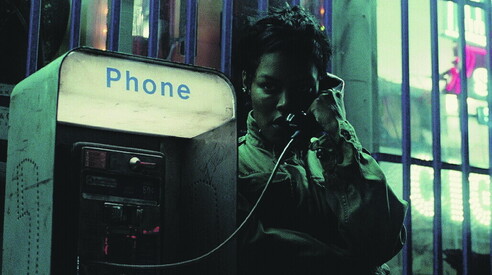LaPresse
Il romanzo
Torna “Pinkerton”, indagine metafisica sospesa fra ragione e paradosso
Nel libro di Franco Cordelli si racconta la vicenda dell'inquisitore Moroni, soprannominato Pinkerton o il Redivivo, che interroga i componenti della compagnia teatrale romana del collegio Molinelli, in seguito alla scomparsa di Mario Bastiani, uno degli attori
"Ogni esistenza ha un muro”, afferma il quasi dimenticato drammaturgo francese (di origine russo-armena) Arthur Adamov, influenzato da Kafka e dall’espressionismo tedesco, nonché dai surrealisti e dal Teatro della Crudeltà di Antonin Artaud. Del 1949 è l’“Invasione”, che offre una chiave di lettura per un romanzo di Franco Cordelli, “Pinkerton”, del 1986. Oggi, a distanza di quasi quarant’anni, questo romanzo ingannevolmente poliziesco ritorna in libreria per la Nave di Teseo, con una postfazione di Giovanni Barracco. Sospeso fra teatro e prosa, si configura – ed è a tutti gli effetti – un’indagine metafisica che si muove fra ragione e paradosso. Siamo a Roma negli anni Settanta. L’inquisitore Tommaso Moroni, soprannominato Pinkerton o il Redivivo, interroga i componenti della compagnia teatrale romana del collegio Molinelli, in seguito alla scomparsa di Mario Bastiani, uno degli attori, avvenuta mentre il gruppo si apprestava a portare in scena il testo di Adamov al Bethanien di Berlino.
Il Molinelli, istituto per orfani e disabili – qui sono cresciuti gli attori – si trova a pochi passi da via Fani. Il fantasma di Moro (Moro-ni) rapisce la narrazione. Fra depistaggi, vortici di senso e sovrapposizioni di piani di realtà, il narratore Agostino ci conduce nell’oscurità, in mezzo a lacerti e fantasmi, di alienazione in alienazione. E la quarta parete del teatro sembra il Muro di Berlino o la Fortezza Bastiani (“Il deserto dei Tartari”). Di tanto in tanto, come risputato da un mulinello/Molinelli (l’assonanza con la metafora gaddiana è segnalata da Cortellessa in un suo scritto), si riaffaccia sul piano narrativo il cappotto da carabiniere di Pinkerton. Come nel “Pasticciaccio” di Gadda, precipitiamo in un groviglio inestricabile. Che cosa accomuna rapito e alienato? Un muro separa entrambi dalla congrega sociale. Non sempre i riflettori della storia si accendono sui “suicidati della società”, così come Artaud definisce Van Gogh. L’autore del “Teatro e il suo doppio” intrattiene con il corpo una vera e propria lotta, una sorta di esorcismo contro il male: il volto, spiritato e smagrito, dalla trance testimonia la sua intima “sostanza sottile”, per richiamare un altro titolo di Cordelli, infiammata.
Maggiore è lo stato di alienazione di un corpo, più alto è il muro eretto a difesa dal corpo sociale, il cui gusto è votato al prototipo dell’homo oeconomicus. L’alienato è invaso/invasato dalla società. Sul palcoscenico, i corpi sono trasfigurati dai personaggi e velati dalla quarta parete. Il corpo del rapito, occultato, scompagina le carte della partita metafisica. Il rapito rapisce come l’attore invasato invade. Il teatro come lotta per la vita, che riscatti l’infanzia abbandonata, è la missione della direttrice del collegio, Teresa. Perché quest’idea suscita terrore in Pinkerton-Moroni? Non è forse lui uno spettatore assonnato, un poliziotto che deve, dato il ruolo, uscire dal teatro?
“L’irrevocabilità dei fatti, il tempo, è il principio stesso dell’alienità”, sostiene Franco Cordelli nel dialogo immaginario con Flaiano. La lunga fila delle attese deluse, la volontà di potenza dei desideri imbozzolati, insomma la vita mortificata, forma, con il brillio corazzato del suo sottrarsi alla scena, una sempre rinnovata consapevolezza, illuminando il palcoscenico con il clangore delle armature dentro cui si trincera; mentre fuori, le realtà scarnificate dei fatti sono purificate dalla potenza dei riti collettivi. La lotta è necessaria come l’illusione, redime un’originaria orfanezza che il bozzo del filosofo della compagnia, Oscar Cornaro, richiama con grottesca ironia.