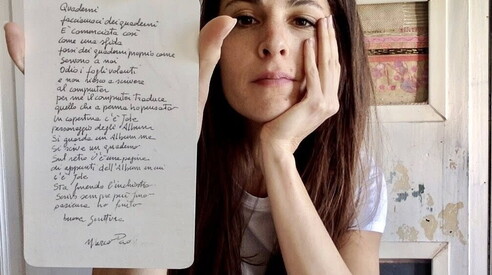Sigfrido Ranucci (Ansa)
“Non sono un martire”. Intervista a Sigfrido Ranucci
“Fazzolari? Mi critichino pure, è fisiologico. Io grillino? L’unica tessera che ho avuto era quella della Dc. Mi sento cattocomunista. Ma non entrerò mai in politica. Se resto in Rai? Finché sarò libero. Ho visto Cairo, La7 è un’ipotesi”
Sigfrido Ranucci non ha l’aria da martire. Eppure, è ciò che ha suggerito il braccio quasi destro di Giorgia Meloni, Giovambattista Fazzolari, al Corriere della Sera: dopo l’attentato davanti casa sua “Ranucci gode di totale impunità”. Un martire “de sinistra”.
Gli chiediamo: per chi hai votato? “Io ho avuto una sola tessera di partito, quella della Dc. Corrente sbardelliana”.
Bum. Ranucci sbardelliano. Proprio così. La corrente di Vittorio Sbardella: andreottiana, romana, muscolare, più nota per le ombre che per le liturgie cattolico-democristiane. E lo dice come uno che rilegge la propria biografia in diretta. Poi si scusa ridendo: “Me la fecero loro quando ero ragazzo, neanche lo sapevo”.
Parla di politica e torna su di sé, non sulle etichette. Gli domandiamo ancora: sei di sinistra? “Penso di essere un cattocomunista, se proprio vuoi saperlo. Ma sono anche figlio di un brigadiere della Finanza, e su alcune cose ho idee vicine alla destra legalitaria”.
Non ha proprio l’aria da martire, Ranucci. Quello che lo infastidisce – ci dice – non è la critica, semmai la leggenda che lo vorrebbe intoccabile dopo la bomba. “Non sono mica un’entità morale intangibile che parla da un pulpito. Ma che mi critichino pure, che mi attacchino. Non voglio immunità. E’ giusto così. E’ fisiologico. I giornali del gruppo Angelucci non perdono un giorno”. E di questi critici, nei giornali del centrodestra, c’è qualcuno che stimi? “Francesco Specchia”.
Quando glielo ricordo – “martire…” – sorride appena. E, per un istante, si tendono le spalle: “A dire il vero continuano ad arrivare pure querele e diffide. Va avanti esattamente come prima. Forse è comodo dire che sono impunito per non entrare nel merito di quello che raccontiamo a ‘Report’”.
Continuando a parlargli di politica, colpisce il modo in cui lui resta seduto: rigido, ma non sulla difensiva, nello studio che usa per andare in onda. Un ambiente pieno di fogli, un tavolo troppo grande e disordinato, proiettori spenti. E un silenzio che stride con il caos che lo circonda da mesi.
Quindi non è vero che sei un grillino e che ti candiderai con il M5s? “Non entrerò mai in politica. Non mi interessa, e non mi identifico in nessuno dei partiti che adesso mi tirano per la giacchetta”. Pausa. Sorriso a filo d’erba: “Me l’hanno già chiesto tante volte. Di recente e in passato”. Ti hanno proposto di fare il sindaco, come è capitato a Bruno Vespa? “No, mi hanno proposto cose un po’ più importanti”. Il ministro? “Non esageriamo”.
Però ti difendono Pd e 5 stelle. Ranucci, brevilineo, con le mani sottili, fa una piccola smorfia. “Il Pd mi dà solidarietà ufficiale. Ma non è che mi amino particolarmente. Anzi”. Lo dice come si constata una pressione atmosferica.
E i 5 stelle? “Nel nostro pubblico ci sono sempre stati tanti ex dipietristi. E una parte dei 5 Stelle ha sempre pensato che noi fossimo roba loro, che dovessimo trattarli con riguardo. E invece no”. Pausa breve. “Questi attestati di stima sono sempre da prendere con le pinze”.
Ricorda l’episodio di quando il Movimento propose Milena Gabanelli al Quirinale. “Io e Milena ci scherzavamo sopra: era una cosa surreale. Ma la cosa più surreale è che poi, quando si è trattato di riconoscerle un ruolo in Rai, i 5 stelle sono spariti”.
Gli dico che però su di loro inchieste non ne fa. “Non è vero. Ci occupiamo sempre di più di chi governa. E ora governa la destra. Ma in assoluto il ministro più attenzionato negli ultimi anni è stato Roberto Speranza”. Speranza non è grillino. “Ma ci siamo occupati anche di Giuseppe Conte. La storia del finto piano pandemico l’abbiamo tirata fuori noi. E’ finita al tribunale dei ministri”.
Ranucci abbassa un attimo lo sguardo sui fogli sparsi, come per chiudere il capitolo politico. Poi cita Biagi: “Io sono amico di tutti ma la trasmissione non è amica di nessuno”.
E gli “aiuti dall’alto”? Le presunte soffiate dei servizi, i dossier, i segreti di stato. Ranucci ride. “Sì, certo, gli aiuti dall’alto... Sono credente: penso che quelli che ho perso mi diano una mano. Gli unici servizi che conosco sono quelli lì”. E probabilmente sta pensando anche alla mamma, professoressa di scuola, “che quando cominciai a condurre ‘Report’ mi diceva: ‘Mi raccomando non fare i nomi delle persone coinvolte nelle inchieste di cui ti occupi. Una cosa assurda e dolce, insieme. Lo diceva perché aveva paura”.
Lo studio di Sigfrido Ranucci, nella sede Rai di via Teulada 66, è la sua stanza redazionale e insieme un piccolo set: il logo di “Report” grande e rosso sulla parete, il nome di Milena Gabanelli ancora scritto sulla porta (“lo volevano cancellare ma mi sono opposto”), il pavimento di linoleum consumato, l’arredamento spento tipico degli uffici Rai, i proiettori da studio puntati verso il tavolo, la scrivania di copioni e di querele. “Ho due o tre processi aperti, su un totale di circa duecento atti di citazione e altre azioni legali. Ma finora non ho mai perso una causa”. Indica le luci, la valigetta che serve a inviare il segnale della messa in onda, il monitor di servizio. “Da qui posso andare in onda anche senza fonici e regìa”, dice. “Faccio tutto da solo”. E’ sorridente, garbato, più magro di come appare in televisione. “Sono le ottiche che mi ingrassano. Se ci fai caso cambio stazza di settimana in settimana”, dice. “E poi sono cortisonico”. In che senso? “Produco cortisone”. Pare sia una fortuna, abbassa la soglia del dolore. “Incasso i colpi”. Si tocca il petto con due dita, attraverso la camicia sempre molto sbottonata (“odio la cravatta”) come a dire che il corpo gli è sempre stato un alleato. Poi inclina la testa: “Sono sempre stato così, anche da ragazzo”. E allora gli chiedo dove è cresciuto. “A Roma, alla Garbatella, lo stesso quartiere di Giorgia Meloni. Ho fatto il liceo scientifico, il Borromini, una scuola dove, come il quartiere, c’erano persone di varie estrazioni sociali. La Garbatella era molto popolare, per così dire”. E com’era chiamarsi Sigfrido in un quartiere di case popolari? “Già il nome mi metteva nei guai. Il primo problema è che, preceduto da questo nome, ti aspetti uno alto due metri e con gli occhi azzurri. Invece poi arrivo io”. Perché ti chiamano Sigfrido? “Per via del nonno. In famiglia c’era una passione per Wagner”. E il secondo problema? “Beh, il secondo problema è che ti devi immaginare l’Anello dei Nibelunghi alla Garbatella... Infatti, mi chiamavano tutti Lello”. Lello? “Sì. Ma il paradosso è che un Lello vero, il famoso del quartiere, abitava nel mio stesso palazzo. Uno che spacciava. Tutti sapevano chi era. A scuola, dopo una settimana, ho cominciato a notare che i compagni non mi parlavano più. Non capivo”. I genitori avevano detto ai figli: state attenti, quello è Lello lo spacciatore. “Ci è voluto un po’ per chiarire. La Garbatella era così. Quando uscivo la sera scavalcavo le persone che si erano fatte di eroina sulle scale. C’era uno che, dalla finestra, tirava giù la droga dentro una pentola legata a una corda. Secondo me è lì che ho imparato a osservare”.
E in base alla tua capacità di osservare: hai idea di chi abbia messo un ordigno davanti casa tua? Chi è stato? “Non lo so”, dice. “E non riesco a collegare quella bomba a nessuna delle inchieste che abbiamo fatto”. Prima di quella notte c’erano stati undici episodi che non aveva mai reso pubblici: proiettili davanti casa, pedinamenti, persone che lo filmavano mentre incontrava fonti. “Tutte cose che riuscivo a collegare a determinate puntate. Questa no. Non so ancora se è legata a qualcosa che abbiamo fatto o a qualcosa che deve ancora andare in onda”.
I magistrati, racconta, hanno cominciato a convocare persone che ruotano intorno a un’inchiesta recente sul traffico di armi. “Il 15 settembre abbiamo scoperto mitragliatrici nascoste in un cantiere navale. Le abbiamo collegate a dei prestanome della camorra che trafficano armi verso la Libia”. E’ prudente: non fa equivalenze automatiche, non azzarda mandanti. “Sono scenari complicati”, dice. Punto. “L’unica cosa certa è che la politica non c’entra assolutamente nulla, e non ho mai pensato né detto il contrario”. Ma l’idea che l’ordigno fosse solo un “petardo”, come qualcuno ha scritto “sui giornali della destra”, lo infastidisce. Non tanto per le due macchine distrutte, quanto per la leggerezza di quella definizione. “Hanno messo un innesco. Una miccia che, se ti fossi avvicinato nel momento sbagliato, ti sarebbe saltata in faccia uccidendoti”.
Da qui la conclusione più inquietante: “Chi ha confezionato quell’innesco ha fatto dei calcoli che solo una persona molto esperta può fare”. Criminalità organizzata? “Molto ben organizzata, quasi...” Quasi? “Quasi di competenza militare”. Ecco.
Lo dice come un dato tecnico, non come un’impennata drammatica. Ma c’è un altro dettaglio che gli pesa più di tutto: “Come facevano a sapere che io rientravo proprio a quell’ora? L’ho comunicato all’ultimo momento solo alla cerchia familiare e alla scorta”, dice. “E non era la prima volta che accadeva qualcosa del genere: quando erano comparsi i proiettili io mancavo da quattro giorni”. E’ la precisione a colpirlo: il sincronismo, non solo l’ordigno. Gli chiedo perché non avesse mai messo telecamere davanti casa, considerate le minacce. Non esiste una sola immagine di quella via, quella sera, in un mondo che è pieno di telecamere ovunque. “Non ho messo telecamere perché le telecamere ti possono proteggere, ma ti espongono anche. Abbiamo fatto a ‘Report’ un’inchiesta sulle intrusioni nei sistemi di videosorveglianza”.
Poi c’è la politica, che sull’attentato ha reagito anche in modo scomposto. Ranucci cita soprattutto il nervosismo di alcuni esponenti di Fratelli d’Italia: interrogazioni, comunicati, perfino un post del partito che sollecitava la procura a fare presto, sostenendo che l’inchiesta rischiasse di alimentare retropensieri sul coinvolgimento del governo. “Vogliono chiudere la partita in fretta, archiviandola come bassa criminalità”. E qui la sua valutazione diventa più netta: “Dicendo che è una sciocchezza e che se ne parliamo troppo sembra un attacco al governo, loro stessi fanno nascere l’idea che, se invece fosse una cosa seria, il governo potrebbe entrarci. E’ un clamoroso autogol, insomma si danno, ingenuamente, la zappa sui piedi”. Poi aggiunge soltanto: “E’ una cosa che richiederà tempo”.
C’è qualcosa di cui ti sei pentito? Qualcosa che a “Report” avete sbagliato, che avresti fatto diversamente? “A volte siamo andati un po’ sopra le righe”, dice Ranucci. “Nei toni, nella costruzione. Capita quando c’è competizione interna su chi trova lo scoop più forte. Capita che qualcuno forzi la mano. E quello può danneggiare la trasmissione. E’ accaduto”.
Gli faccio un esempio. Le musiche, le atmosfere, i testimoni girati come figuranti. “E’ una critica legittima”, ammette. “Quando arrivano pezzi all’ultimo non sempre riesci a vedere tutto insieme. Te ne accorgi solo quando sei in onda”. Poi c’è la telefonata della moglie di Gennaro Sangiuliano. Perché esporre una donna fragile, tradita, in uno stato visibilmente alterato? Sapevi che era malata? “No”, risponde. “Non sapevo nulla”. Anche se lo sapevano tutti. “Ma l’interesse giornalistico non stava nella sua fragilità o negli aspetti morbosi. Stava in quello che diceva. Era la moglie che indicava al ministro cosa fare sul contratto di un’altra persona. Quello era di interesse pubblico. Io ne ho mandato un pezzetto, ma ce ne avrei potute fare sei puntate”. L’audio però oggi su Raiplay non c’è più. E’ stato cancellato dal servizio originale. “Decisione superiore della Rai”, dice. E aggiunge soltanto: “Io non l’avrei tolto”.
Come sei entrato in Rai? “Con una raccomandazione”, ride Ranucci. “Non ho nessun problema a dirlo. Niente di eroico”. Poi abbassa appena la voce, come per mettere subito una pietra sopra ai moralismi: “Era il 1989 e la raccomandazione era di una signora, la segretaria di un alto dirigente di Viale Mazzini, che avevo conosciuto perché le davo lezioni di tennis. Mi facevo pagare in nero. E meno male che allora non c’era ‘Report’ perché mi avrebbero fatto il paiolo”. E che facevi all’inizio? “Venivo da un anno di supplenza in una scuola di Ostia dove insegnavo italiano e storia. Alla Rai mi fecero entrare come assistente ai programmi. Al Tg3”. Un ambiente in parte semideserto, in parte febbrile. “La trasmissione si chiamava ‘Domenica sul tre’ e andava in onda il lunedì dopo mezzanotte perché, diciamolo, non era proprio un capolavoro”.
Si ritrova così nella stagione che verrà ricordata come Telekabul: Sandro Curzi, Michele Santoro, Bianca Berlinguer, Corradino Mineo. “Era un’altra Rai”, dice senza nostalgia, solo per constatazione. “Io passavo le ore a guardare come si montava un pezzo”. Ricorda Franco Poggianti, caporedattore di Livorno: “Mi ha insegnato che la prima cosa è accettare che il tuo pezzo possa essere strappato senza nemmeno essere letto. Lo fece davvero”.
Il vero apprendistato non è ideologico: è tecnico. Palinsesti, montaggi, tempi televisivi. “Passavo le ore a leggere i dati d’ascolto”, dice. “Credo sia stata la mia fortuna. Li studio da allora. Sono maniacale su questo”. E qui il tono cambia appena, ma resta concreto: “E’ per questo che oggi conosco il palinsesto come una mappa interna. So esattamente da dove parto. Io parto dal 2 per cento, non ho traino ma salgo con gli ascolti. Altri partono dal 7 col traino, e perdono quasi tutto”. E qui accende il computer, mi fa federe lo share di due suoi colleghi di Raitre.
Oggi la Rai in cui Ranucci lavora non somiglia più a quella in cui è entrato, dice. Quando parla dell’azienda non alza mai la voce: la smonta. “La riforma Renzi è stata una iattura. E’ incompleta. E poi la divisione in generi ha devastato ogni cosa”. Lo dice con un tono quasi ingegneristico, come se spiegasse un guasto. “Una volta bussavi alla porta del direttore: Di Bella, Ruffini, Vianello, Di Mare. Uscivi in dieci minuti con una risposta. Ora no. Ora le decisioni passano in una catena infinita: amministratore delegato, coordinatore dei generi, capo del personale, palinsesto. Risultato: non decide più nessuno. E, lungo quella catena, ogni passaggio aggiunge un rinvio, una cautela, un rallentamento”. Che rapporto hai con la dirigenza che proviene dal centrodestra? Con Paolo Corsini, per esempio, il tuo direttore, il direttore dell’approfondimento? “Con lui parlo molto. Sa tutto giorni prima che io vada in onda. Vede le puntate, mi manda osservazioni. A volte le seguo”. Ma si ferma qui, Ranucci. C’è solo il dato che conta: “Con l’amministratore delegato Giampaolo Rossi, invece, non ho mai parlato. Oggi pomeriggio lo incontro per la prima volta”. Lo dice come chi segnala una stranezza ambientale, non un torto personale.
Poi c’è la questione che in Rai sussurra mezzo palinsesto: La7. Urbano Cairo. E’ vero che minacci di andartene a La7? Ranucci non nega, ma spiega. “Ho incontrato Cairo, e abbiamo parlato per oltre due ore. Un dialogo molto bello. Ero stato contattato per fare un libro con la sua casa editrice, ma poi abbiamo parlato anche di televisione”. Ed è chiaro che non la considera un’eresia, andarsene. “Io vorrei rimanere in Rai”, dice. “Ma dipenderà dalla Rai, non da me”. E aggiunge: “Il nome ‘Report’ non può andare su La7: è un marchio di proprietà della Rai. Ma un ‘New Report’ sì, ci può andare”. E con te viene tutta la squadra. “Se mi sposto io, qua non ci rimangono nemmeno i cassetti. Perché è un segnale. Significa che ‘Report’ non ha più la libertà di fare quello che ha fatto fino ad adesso”. Lo dice senza posa, senza finta modestia, come una possibilità concreta. Non è tanto l’ipotesi La7 che colpisce: è il modo in cui la racconta.
E a questo punto si ferma, come se rimettesse in ordine ciò che ha detto fin qua. Allora gli chiedo: una volta in Italia faceva paura “Striscia la notizia”. Oggi fa paura “Report”? Stavolta Ranucci non finge distacco. Un’ombra di sorriso gli passa negli occhi, rapida, come uno che sa esattamente l’effetto che fa. “Io penso che faccia paura l’indipendenza”, dice. “Non la trasmissione. Non il potere mediatico. Il potere dura finché qualcuno lo teme. Poi svanisce. L’indipendenza no”. E alla fine torna secco al punto di partenza: “Io faccio il giornalista”.