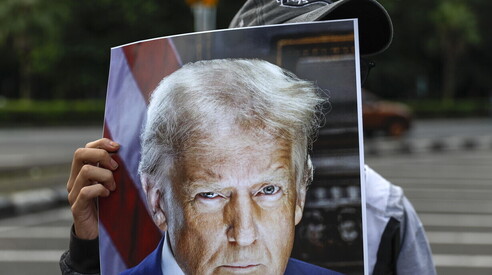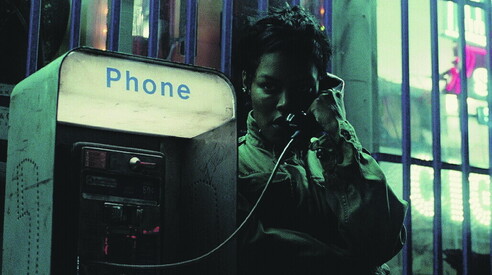Google creative commons
lo stendhal milanese
Ah, questi italiani che brillano nel parlare ma scrivono in una lingua morta
Da una polemica innescata dall'uscita di un romanzo di Vincenzo Monti, Stendhal colse l'occasione per dimostrare il suo amore per Milano pubblicando un pamphlet sui "pericoli della lingua italiana" che ha ancora una sua attualità
Nel periodo più felice della sua vita, come lui stesso definì gli anni passati a Milano dal 1810 al 1821, Stendhal volle definirsi Milanese. E lo fu entrando in una polemica tipicamente italiana, quella riguardante l’uso letterario della nostra lingua. L’occasione fu l’uscita di un lungo saggio del poeta neoclassico Vincenzo Monti, intitolato Proposta di alcune correzioni e aggiunte al Vocabolario della Crusca. Il sentirsi milanese spinse Stendhal a leggere subito e appassionatamente il discorso di Monti, nonché a scrivere un ironico pamphlet sui “pericoli della lingua italiana”. Ora, nella collana l’Airone, appena nata e diretta da Cody Franchetti per le edizioni La nave di Teseo, quelle pagine stendhaliane sono state ripubblicate a cura di Marcello Simonetta, rivelando ancora una sorprendente attualità. Giustamente e suggestivamente il curatore le definisce “monologo saggistico” e “trattato dialogico”. Lo stile di Stendhal ha infatti quella vivace e naturale eloquenza senza cui (come sottolinea lui stesso) le idee non vivono e la riflessione viene linguisticamente tramortita.
Nella sua prefazione, Marcello Simonetta descrive la nascita e la diffusione del saggio stendhaliano tra i suoi amici italiani, fra cui Silvio Pellico, che Stendhal definiva “pieno di logica e di buona educazione”, cioè il contrario del poeta intrigante e di successo Vincenzo Monti, “privo di logica” e di quella capacità filosofica necessaria a ogni discussione che voglia coinvolgere un pubblico.
L’amore di Stendhal per l’Italia e gli italiani lo rese sensibile al fatto che la nostra lingua fosse ancora infelicemente sottomessa all’Accademia della Crusca e al suo vocabolario. Perché mai la vitalità degli italiani, con la loro energica joie de vivre e la loro vivacissima comunicativa, sparivano quando si trattava di scrivere prosa e poesia? Perché il calore e la prontezza nel parlare sparivano nel momento in cui si passava dal parlato allo scritto? Il dispotismo linguistico della Toscana, con il primato della sua letteratura dal Trecento al Cinquecento, impediva e soffocava non solo la lingua letteraria, anche la prosa delle sue opere filosofiche. Senza naturalezza nel passare dal parlato alla lingua scritta, anche l’elaborazione e l’espressione delle idee veniva paralizzata.
Ma ecco una pagina essenziale del saggio di Stendhal: “Non si creda che io parlo soltanto di poesia o di opere letterarie. Questa triste verità le cui conseguenze mi fanno tremare si applica allo stesso modo e forse meglio alle opere filosofiche che a quelle poetiche. L’influenza dei segni sulla facoltà di pensare è estrema. I segni e la lingua sono un soccorso per l’attenzione, essi le impediscono di disperdersi sulle cose particolari, giungono fino ad avvertire l’uomo superiore dei suoi errori. Quale soccorso non portano dunque a noi uomini ordinari? Ciò che fa la civiltà di un paese non sono un uomo di genio o due, ma i milioni di uomini medi istruiti in maniera ragionevole. Se scrivere in una lingua morta è una cosa funesta per la poesia e i libri di divertimento, è un ostacolo quasi invincibile, se non alla scoperta della verità, almeno alla sua diffusione” (p. 61).
Secondo Stendhal, la lingua deve “afferrare” il pensiero con le proprie orecchie. Deve cioè seguire “con costanza il più naturale ordine possibile” e al presente “le opere che ciascuno di noi legge più di frequente nel 1818 sono i giornali (...) essi sono scritti più che altro come si parla” (p. 65).
A muovere e irritare Stendhal è il fatto che all’inizio dell’Ottocento si scriva in Italia “in una lingua morta”. E il rimedio a questa disgraziata abitudine di imitare ancora la prosa di Cicerone e Boccaccio sarà che “due o tre filosofi, le teste più fredde e più razionali, le meno influenzabili dallo spirito di parte, ci diano un vocabolario” che non abbia “rispetto superstizioso” per il Dizionario della Crusca (p. 67). Da tutt’altro dizionario si dovrebbe prendere esempio in Italia, da quello di Samuel Johnson, grande filosofo morale che, per la conversazione, era stato nella letteratura inglese quello che Madame De Stael è stata più tardi in Francia.
Poco affidabili, nel rapporto che stabiliscono fra lingua e idee, sono per Stendhal perfino i Greci, che con la loro “impazienza naturale” (sic!) sono stati dei “visionari”, cioè dei metafisici, somigliando così ai più moderni teologi, incapaci di discutere della loro materia, poiché “senza libera discussione non c’è verità” e il Dio dei teologi non è certo discutibile. Più diffuso e prossimo è il difetto di naturalezza e l’ostentazione ricercata che “alza un muro tra l’autore e il suo lettore”.
La polemica sollevata da Stendhal due secoli fa non ha ovviamente a che fare con la funesta autorità del Vocabolario della Crusca. L’intralcio alla prosa di conversazione e di pensiero viene oggi dal sussiego degli studiosi, dai gerghi specialistici usati male e dall’influenza di un lessico filosofico esibito come di per sé autorevole, anche se in una prosa sintatticamente e logicamente fiacca.