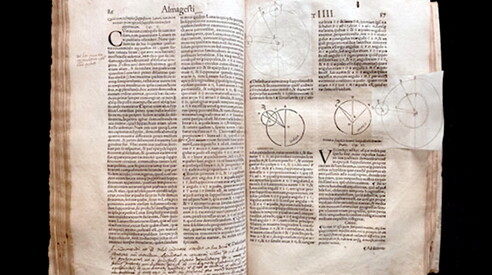Ansa
A Palazzo esposizioni
L'impresa di restituire la bellezza
Bene culturale è “testimonianza materiale avente valore di civiltà”. Nato nel 1989, il progetto Restituzioni di Intesa Sanpaolo ha restaurato 2.200 opere a beneficio di enti, territori e dell’intera comunità. Una mostra a Roma
Partirono con dieci, ed erano abbastanza. Era il 1989, ancora non era caduto il Muro di Berlino; soprattutto c’era ancora nella testa di tutti, almeno in Italia, “un maledetto muro”. Quello che divideva la politica e gli amministratori, chi gestiva sovrintendenze e musei, dai privati, banche o finanziatori. La possibilità di collaborazione anche solo per sostenere un intervento di restauro era un concetto ancora lontano, guardata a volte addirittura con sospetto. Eppure partirono, con dieci opere restaurate: era la prima edizione del progetto Restituzioni di Intesa Sanpaolo. O meglio, nemmeno Intesa Sanpaolo esisteva ancora: era appena nato il nuovo Banco Ambrosiano, affidato alla cura di Giovanni Bazoli, il banchiere “professore”. Quella prima edizione con un titolo che allora sembrava disruptive, “La Banca per l’Arte”, aveva radici in Veneto grazie alla lungimiranza del presidente della Banca cattolica del Veneto, Feliciano Benvenuti. Vent’anni dopo, in occasione dell’edizione 2011 di Restituzioni, Bazoli lo ricorderà così: “Non avrebbe forse immaginato che il fecondo rapporto instaurato con le soprintendenze del Veneto avrebbe a poco a poco varcato i confini regionali per estendersi, con il crescere della Banca, a una realtà territoriale sempre più vasta, sino a raggiungere la dimensione nazionale”.
La mostra si tenne a Palazzo Leoni Montanari a Vicenza, che poi sarebbe diventato la prima sede delle Gallerie d’Italia. La strada era lunga ma la direzione già chiara, come tiene a sottolineare Michele Coppola, direttore Arte, Cultura e Beni storici di Intesa Sanpaolo e delle Gallerie d’Italia: “In questo percorso di oltre trent’anni c’è la legacy del presidente Bazoli, la visione di cosa potesse essere il contributo di un istituto bancario, privato, insomma del mondo del ‘mercato’, alle istituzioni e alla collettività. L’idea di ‘restituire’ in cultura e bellezza qualcosa al tutto il paese, a ogni territorio, c’era già allora, e coerentemente è stata portata avanti dall’amministratore delegato Carlo Messina e dal professor Gian Maria Gros-Pietro, presidente del cda. Hanno contribuito alla consapevolezza che la banca ha ormai un ruolo, in ambito culturale, riconosciuto. E non soltanto in Italia”. L’intuizione della “restituzione” delle opere “in pristinam dignitatem, innanzitutto” c’era già. Il cambiamento della cultura pubblica e d’impresa nel nostro paese, a tutti i livelli, è stato conseguenza. In queste settimane, fino al 18 gennaio 2026, chi voglia sfruttare l’occasione di conoscere un “cantiere della bellezza” può percorrere i grandi spazi del Palazzo delle Esposizioni di Roma e ammirare le 120 opere provenienti da tutte le regioni d’Italia selezionate dall’ultima campagna Restituzioni di Intesa Sanpaolo, che è biennale, insieme a 51 istituzioni – soprintendenze, direzioni regionali dei musei e musei autonomi – e coinvolgendo 67 enti proprietari differenti.
A Palazzo delle Esposizioni, oltre al gusto della bellezza, si possono scoprire due aspetti interessanti. Il primo ovviamente riguarda la quantità, la diversità e infinita provenienza territoriale del patrimonio artistico italiano; il secondo, meno noto, è l’esistenza di una rete di restauratori, di professionisti della tutela, di storici dell’arte e del territorio, di organizzatori culturali che insieme condividono una visione interconnessa del paese. Una community che ha pochi uguali nel mondo e che in questi trent’anni è cresciuta anche, ovviamente non soltanto, grazie a una sponda ormai istituzionale come il progetto Restituzioni. Passeggiare per le sale della mostra accompagnati da Silvia Foschi, responsabile del Patrimonio storico artistico e delle Attività culturali di Intesa Sanpaolo è un piccolo privilegio. Di ogni opera racconta non solo la provenienza e la storia materiale cui appartiene, ma anche come è stato elaborato e seguito il progetto di restauro: “Non lo scegliamo noi, sono sovrintendenze o musei a selezionarlo, a predisporre il percorso scientifico, a scegliere i restauratori. Noi interveniamo solo dopo”. E siccome ovunque non si puo' arrivare, dietro ai cento restauri realizzati ci sono oltre quattrocento progetti presentati: “E’ significativo che a ogni edizione crescano le richieste, si è instaurata una collaborazione basata sulla fiducia tra chi lavora nell’ambito dei beni culturali e il nostro ruolo”.
Bellezze da tutta Italia e di ogni epoca: “Sono opere importanti non solo per la qualità – ovvio che un Bellini o un Giulio Romano siano di primaria importanza – ma per il rapporto con il territorio. Ci sono storie davvero particolari, come il restauro della Madonna con il Bambino, o Madonna del Fiore, in avorio, opera francese di fine Duecento conservata da secoli nella piccola chiesa di Santa Maria in Categne, a Lugnano in provincia di Rieti: tanta è la devozione locale che i cittadini sono venuti fino qui ad accompagnarla”. Oppure il restauro di un “abito tradizionale festivo femminile” di San Paolo Albanese, una manifattura arbëreshe della comunità albanese della Basilicata. Silvia Foschi racconta “di coincidenze fortunate, ma anche di una grande collaborazione e disponibilità con una comunità di esperti cresciuta insieme in questi anni, in un rapporto privilegiato con tutti i territori del nostro paese”.
Quest’anno gli splendori non mancano. C’è il Novecento di Mario Sironi o Pino Pascali; c’è un “arpicordo”, una spinetta pentagonale di metà Cinquecento, c’è la “draisina”, antenata ottocentesca della bicicletta che arriva da Gallarate; un arco da Samurai e un modello di barca siamese dal Castello Ducale di Agliè in Piemonte, vestigia della grande diplomazia piemontese. Il Reliquiario a tabella da Serra San Bruno in Calabria. Il restauro della splendida Cariatide di Villa Adriana, il Letto di Fossa, un triclinio in avorio di epoca romana dal Museo archeologico di Chieti; una portantina settecentesca appartenuta alla principessa Ruffo. Ultimo ma non ultimo, per il progetto “Restituzioni monumentali”, sono state restaurate le pitture murali della chiesa di Santa Maria foris portas di Castelseprio, vicino a Varese, da poco diventati sito Unesco.
Carla Di Francesco, curatrice scientifica assieme a Giorgio Bonsanti e Carlo Bertelli della mostra, ricorda la definizione di bene culturale che in Italia data addirittura dal 1967: “Testimonianza materiale avente valore di civiltà”. Fu la Commissione d’indagine per la Tutela e la valorizzazione del patrimonio storico archeologico, presieduta da Francesco Franceschini su proposta del ministero della Pubblica istruzione (il Mic non esisteva ancora) a coniare quella definizione così attuale. Ci sono voluti decenni perché si iniziasse a trarne le conseguenze e a difendere i beni culturali all’interno della loro storia e dei loro territori, non solo chiusi nei musei. Nel frattempo è cambiata anche la consapevolezza del contributo che può venire dal mondo privato. “Tra le cose che mi colpiscono all’interno del percorso di Restituzioni c’è la convinzione generale che tutti siamo davvero dentro a quello che abbiamo definito ‘il più grande cantiere della bellezza in Italia’”, commenta Coppola: “Mi colpiscono specialmente i racconti dei restauratori. Questo lavoro è tra l’altro un patrimonio di informazioni per tutti: sul nostro sito, per ogni opera restaurata, è disponibile la scheda completa scientifica dell’opera, il resoconto del lavoro svolto, delle tecniche usate. E’ una vera e propria banca dati pubblica a disposizione di professionisti che lavorano in quello che è anche un mercato, e difficile, in cui noi crediamo”.
Tra il restauro etrusco del Trono dal corredo della Tomba Barberini di Palestrina e i mosaici romani dei Delfini dalla Villa della Punta di Monfalcone – e i video che nel percorso della mostra documentano il concreto lavoro del restauro, affiorano riflessioni su un comparto, quello della conservazione del patrimonio artistico, così cruciale per l’Italia e così difficile da sostenere. Il mecenatismo privato è finalmente riconosciuto come un asset importante: può crescere ancora? chiediamo a Coppola: “Penso di sì, siamo orgogliosi di avere indicato un modello. Ma ci vuole consapevolezza: le banche sono imprese speciali, perché hanno a che fare con il reddito – immaginiamo che cosa significhi tra l’altro anche dal punto di vista dei controlli, della normativa – e devono rispondere ai loro partner. Sei un’impresa che sta sul mercato, e possiamo permetterci di essere un attore culturale e sociale perché siamo bravi a fare il nostro lavoro e poter così destinare risorse alle attività culturali e sociali. Può essere un modello per tutti, differente dalle semplici ‘sponsorizzazioni’. L’intuizione nata dal presidente Bazoli e poi cresciuta è che si può affiancare il sistema pubblico nel sostenere il valore e la centralità che la cultura ha per la crescita del nostro paese. Siamo stati la prima banca a sentire questo ‘richiamo della responsabilità’”.
Questo nel tempo ha cambiato anche la concezione che il pubblico – la politica, gli amministratori – ha della collaborazione in campo culturale. In un periodo in cui i bisogni sono altissimi e i fondi ridotti, lo vediamo anche nelle polemiche sull’ultima legge di bilancio, il percorso è chiaro. “I nostri vertici, e per fortuna non solo loro, si rendono pienamente conto che la banca in ambito culturale ha un ruolo al quale oramai si guarda non soltanto in Italia, perché la verità è che un progetto come Restituzioni non eguali quantomeno in Europa. In questi anni è cambiata l’aspettativa anche di musei e soprintendenze, che oggi ragionano anche in funzione dell’arrivo della nuova call di Restituzioni: è diventato un progetto così riconosciuto che entra nella programmazione propria di questi soggetti. Quanto alla pubblica amministrazione, ai ministri che si sono succeduti, abbiamo sempre trovato una collaborazione e una consapevolezza crescente, e non è solo fortuna, è un modello virtuoso che andrebbe sempre più esteso. Il nostro è un saper fare italiano messo a disposizione. Intesa in qualche modo è diventata un ‘partner istituzionale’ per la cultura, come per il sociale, come ha detto recentemente Messina. Il museo sa che può contare su questo. Così negli anni è stata superata una certa diffidenza del pubblico verso il privato, c’è una partnership diventata naturale, è come se ci fossimo riconosciuti reciprocamente in base alle ragioni della nostra azione cioè la tutela, la conservazione e la promozione del patrimonio italiano. In 36 anni sono oltre 2.200 le opere “restituite”, una sorta di ideale museo diffuso. Il cantiere italiano della bellezza.