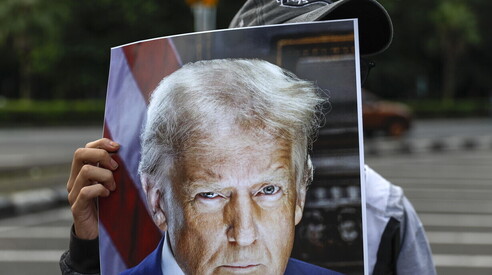Google creative commons
non ordinaria umanità
L'originalità di una variazione su “Re Lear” nella Roma contemporanea
Il romanzo di Flavia Gasperetti "La verità quando arriva è una tempesta" ha un carattere essenziale: la distanza che l’autrice mantiene verso la trama, la recita da regista che viene al proscenio e ci indica la tragicommedia a lato. I suoi personaggi vivono dietro un vetro, sono evocati e poi sciolti nell’aria
Tra le esperienze di lettura più istruttive vanno contate quelle riguardanti libri che sembrano molto simili alla media, ma che non lo sono. Si tratta di libri in apparenza facilmente riconducibili a un sottogenere, da cui invece li separa una sorta di foglio sottilissimo, quasi trasparente, che però segna una differenza radicale. E’ questo foglio a rivelarci cosa non va nei prodotti davvero medi: proprio perché nel caso, al contrario, tutto funziona in modo impeccabile. E’ un’esperienza che mi è capitata da poco leggendo “La verità quando arriva è una tempesta” (Bompiani), il primo elegante romanzo di Flavia Gasperetti. C’è qui una famiglia della Roma borghese.
C’è un patriarca, Learco, già potente e prepotente e ora consumato, sfatto, giunto alla fine della vita. Ci sono le due figlie, diversamente traumatizzate dalla sua fortissima vocazione che le ha confuse sulla loro: Renata, la manager sprezzante, e Gabriella, l’eterna insicura, che ha rifiutato in partenza la sfida performativa e si vendica sotto uno pseudonimo da scrittrice sentimentale. C’è poi Cora (nome moraviano…), una seconda moglie di Learco giovane come una figlia e simile a una fiera misteriosa. Ci sono la malattia, i rimorsi, le identità non dichiarate, i viaggi liberatori, i segreti famigliari, un po’ di giallo, testamenti e badanti, istinti distruttivi che si propongono come uniche vie d’uscita alle delusioni esistenziali, crediti e debiti d’affetto, colpe che riaffiorano piegando la linea delle generazioni in un cerchio perverso. Il tutto ci è servito con un pathos assolto dallo humour svelto di chi teme il cringe, e con uno humour che allude sempre a un fondo di pathos. Alla magra alternanza di ritratti, dialoghi brillanti e inserti onirici si sovrappone infine, ma leggera come una scultura di Calder, una parodia strutturale del “Re Lear”. Ecco dunque: chi mai, da questo riassunto, non sospetterebbe subito il trionfo della convenzione editoriale? Ma resta invece, a preservare Gasperetti, quel foglio sottilissimo che si diceva – ovvero, fuor di metafora, una sapienza che non è solo maggior misura, educazione più scaltrita, bensì il segno di una non ordinaria umanità e cultura.
“La verità quando arriva è una tempesta” comincia con “un vecchio che dorme”. Se da sveglio è ancora il fascinoso architetto internazionale e romanissimo, l’uomo agéma ben conservato, appena lo vince il sonno “è subito incendio al museo delle cere”. Infatti “La faccia dei vecchi va tenuta sempre in movimento, in un perenne stato di animazione, altrimenti si allenta, si squaglia. I vecchi questo lo sanno e (…) dormono poco. Vi siete mai chiesti perché? Perché a nessuno piace indossare da vivo la propria maschera funeraria”. Bastano queste righe per notare un carattere essenziale del romanzo: la distanza che l’autrice mantiene verso la propria trama, la sua recita da regista che viene al proscenio e ci indica la tragicommedia a lato. I suoi personaggi vivono dietro un vetro, sono evocati e poi sciolti nell’aria come spiritelli elisabettiani. Nel morente Learco, e in tutti loro, quant’è la parte di lucidità e quanto il degrado neurologico, o l’allucinazione da dormiveglia? Dove finisce la dose di realtà quotidiana e dove cominciano le voci degli spettri, delle proiezioni, delle erinni? Le stesse domande pone il paesaggio, che pur saturo di Storia torna sempre minacciosa Natura – una natura che comunque, potremmo dire parafrasando Fortini, è troppo debole per imitare le battaglie interiori e i lampi delle agnizioni.
Come nella “Grande sera” di Pontiggia, anche qui la trama si costruisce sull’assenza e sull’inseguimento di una figura scomparsa silenziosamente: nel caso una femmina, Cora. Sembra che la sua vocazione sia quella di vendicarsi facendo da testimone muto e passivo, da specchio che riflette ogni situazione con suprema ambiguità. Non sarà forse, la moglie di Learco, la Letteratura stessa, se fare letteratura significa indagare senza riguardo, spiare da intrusi in casa propria, e appunto per questo, mentre sotto le sembianze umane si scoprono i tratti delle carogne, arrivare alla fine a tutto comprendere, che è il solo modo di perdonare? Ecco la differenza di Gasperetti rispetto al romanzo-tipo di oggi. Forse è troppo suggestivo ricondurla alla formazione letteraria inglese di questa autrice bilingue. Resta il fatto che più volte, leggendo, si pensa ad Anne Fine.