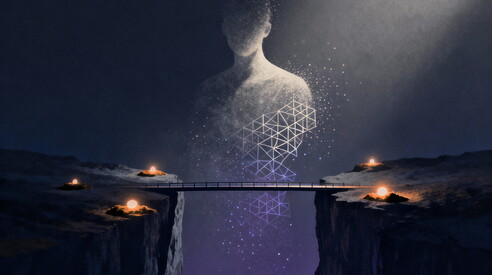
(immagine generata con Perplexity)
il libro
Il nichilismo non è un pezzo di storia del pensiero occidentale. E' il suo destino
Nel saggio di Costantino Esposito ("Il nichilismo del nostro tempo") emergono le verità concrete della nostra epoca
Se oggi ci si trovasse a dover consigliare un libro attraverso cui far capire, anche a chi non ha frequentazione con la materia, perché la filosofia non è utile ma necessaria per comprendere concettualmente il nostro posto nel mondo, si potrebbe indicare il libro di Costantino Esposito Il nichilismo del nostro tempo (Carocci). Si tratta di una discesa dentro vari rivoli critici della nostra epoca attraverso la declinazione del concetto, appunto, di nichilismo. Questo nobile e terribile termine, per un verso, è diventato inutilizzabile per eccesso di utilizzo e per una certa connotazione moralistica (dalla quale Esposito si tiene bene alla larga), tuttavia non ne possiamo fare a meno, non possiamo non confrontarci con esso. Non starò qui a cercare di spiegare sommariamente le tante e interessanti argomentazioni attraverso cui, facendosi sempre guidare dal concetto di nichilismo, Esposito passa in rassegna la nostra contemporaneità. Vi è, infatti, un altro aspetto per cui questo libro è importante: riporta con grande rigore filosofico il termine nichilismo al centro di una riflessione sofisticata, sottraendolo alle grinfie dei sociologismi e psicologismi vari che infestano tanta parte della comunicazione contemporanea.
Il nichilismo va preso con la massima serietà perché non è un giudizio morale sull’epoca, ma va considerato come il tessuto di cui la nostra epoca è fatta. Come tanta filosofia ha capito, il nichilismo non è una componente come altre della storia del pensiero occidentale (e la storia del pensiero è tutt’uno con la storia delle azioni degli uomini). Ma è il suo stesso destino. Ciò, però, cosa significa? Nulla di spaventoso, ma forse di tremendo, e quindi di difficile ed esaltante. Il nichilismo notoriamente viene considerato come niente altro che una totale mancanza di valori assoluti, una sorta di deserto etico in cui ciascuno è libero di fare ciò che vuole perché non c’è alcuna autorità che valga qualcosa al di là del nostro io e delle sue voglie. Il soddisfacimento di tali voglie è sostanzialmente l’unico senso della vita, un periodo di tempo in cui si è vivi prima di ripiombare nello stesso abisso da cui si è venuti. Sebbene questo sia l’habitus nichilista di cui siamo abituati a discutere, non è di questo nichilismo che è interessante parlare.
Allora perché il nichilismo costituisce “il” destino del pensiero occidentale? Ciò che abbiamo capito attraverso la grande tradizione filosofica dell’idealismo tedesco è che l’attività umana è ciò che dà forma al mondo. Attività che è innanzitutto del pensiero (comprendiamo attraverso l’attività di schemi che sono innati in noi), ma poi ovviamente anche della pratica quotidiana, del lavoro. Questa potenza trasformativa, che noi stessi siamo, genera in continuazione la realtà che abbiamo davanti. Tale attività è inarrestabile e vuole porre tutto sotto il proprio controllo. Il momento trasformativo, quindi, è un momento “negativo”, nel senso che piega gli oggetti che ci vengono incontro rendendoli più simili a noi così da poterli assimilare, fare nostri. In tal modo, non esistono più assoluti alle nostre spalle, non esistono più luoghi inattingibili che non dipendono da noi. Basta pensare al fatto che in Hegel l’Assoluto non è un dato, non è un fatto, ma una Storia. Un filosofo più radicale di Hegel, Fichte, pensava che l’Assoluto fosse una sorta di processo interminabile che lo sforzo costantemente rinnovato delle nostre azioni individuali tende a generare.
Tutto ciò non è niente di astratto, bensì ciò che per ciascuno di noi vi è di più concreto. Infatti, cos’è l’attività umana se non un gigantesco processo di trasformazione? In un primo senso, quindi, il nichilismo è un destino perché non vi è niente di stabile se non questa attività continua di trasformazione, non vi è niente di stabile se non l’attività stessa che trasforma. In tale prospettiva, i valori mutano insieme a tutte le altre cose del mondo. I valori diventano isole d’ordine in un mare di disordine, principi di orientamento che si spengono quando esauriscono il loro compito guida. Tale compito, in fin dei conti, non è altro che garantire, epoca dopo epoca, la forza trasformativa dell’attività umana. Il nichilismo, allora, è questa attività che “annienta” le cose come stanno per portarle a un altro livello, per renderle altro. E ciò, non è precisamente anche quanto capita ogni giorno alla nostra vita? Non è essa, infatti, un giorno dopo l’altro, un continuo morire a noi stessi, una trasformazione per divenire più propriamente noi stessi? Per appropriarci via via sempre più di noi? Poi certo, ci si può perdere lungo la via, e sicuramente la nostra vista termina prima di completare il compito.
Il motivo, però, per cui il nichilismo costituisce un destino non è etico né esistenziale, bensì ontologico, ossia ha a che fare con la struttura stessa dell’essere. E ciò non significa niente di strano, se non che non vi è un fondo definito e stabile su cui poggiarsi, da cui partire, e a cui poter ritornare. Ma che l’essere, cioè tutta la realtà, non è niente altro che attività. E l’attività è pura negatività, ossia è trasformazione: “negare” ciò che era per far venire a essere ciò che è. Se l’essere è questa negatività, non è niente di determinato e di stabile. A ben pensarci, infatti, questa attività, questa negatività è un nulla. Ciò, però, non deve spaventare. Come ben scrive Esposito guardando a tanta filosofia del Novecento, in particolare a Heidegger, questo concetto di nulla “sta a dire che gli esseri umani sono ‘aperti’, che non si possono compiere mai, perché sono capaci di libertà, o ‘condannati’ a essa. Perciò siamo esseri trascendenti sempre aperti alla possibilità”.
Ciò che vi è di straordinario è che l’uomo capisce questa realtà, comprende questo nulla, questa attività che sta al centro dell’essere stesso, e che trova in sé. Vi è, infatti, una corrispondenza tra questa struttura dell’essere e la struttura del pensiero che consente di intravederla, e di operare con essa e su di essa. Di cambiare e trasformarsi insieme ad essa. Proprio per questo il nichilismo appare come una realtà tremenda, perché difficile e priva di stabilità, ma entusiasmante perché ne siamo protagonisti, attori principali. E’ questa verità che la nostra epoca ci consegna forse per la prima volta nella storia del pensiero, è questa verità difficile ciò che più di ogni altra genera crisi, ed è con questa verità che non abbiamo forse ancora neppure iniziato a fare i conti.





