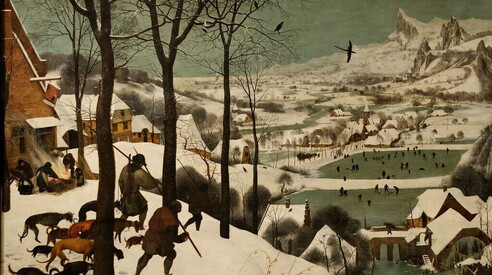Foto di Elisa Calvet B. su Unsplash
il libro
Pensiero e stile: nel '900 anche i saggi fanno letteratura. Da antologia
"Saggisti italiani del Novecento" a cura di Berardinelli e Marchesini è un libro che mancava. Si sono fatte antologie un po' di tutto, ma non della saggistica. Ci volevano due scrittori di diverse generazioni ma che hanno sempre orientato la loro attività critica verso il saggio per lanciarsi in questa impresa temeraria
Quando di un libro si dice “ecco un libro che mancava” non solo si cade in una frase fatta, ma si dice quasi sempre una bugia. Nel migliore dei casi, si esagera alquanto. Invece questa antologia Saggisti italiani del Novecento (a cura di A. Berardinelli e M. Marchesini, Quodlibet, 1.441 pp., 36 euro) mancava davvero. Perché si sono fatte antologie un po’ di tutto, decine per la poesia, qualcuna per i racconti, molte della critica letteraria, ma antologie della saggistica nessuna. E ci volevano due scrittori di generazioni diverse, ma che hanno sempre orientato la loro attività critica verso il saggio, Alfonso Berardinelli e Matteo Marchesini, per lanciarsi in questa impresa al tempo stesso urgente e temeraria, oltre che ciclopica (un volumone di quasi millecinquecento pagine). Perché nessuno ci ha provato prima? La risposta che viene subito in mente è anche quella sbagliata. Uno potrebbe pensare che la difficoltà stia nell’estrema varietà dei testi antologizzati: si va da un Frammento di etica di Croce a un pezzo sociologico di Salvemini sulla corruzione nell’Università napoletana; dal ritratto di Mussolini di Borgese a quello dei professori universitari americani scritto da Soldati; e poi articoli sul Kitsch, su Pulcinella, su Dante. Ma, nota giustamente Berardinelli, nessuno si meraviglia che in un’antologia della poesia ci siano insieme d’Annunzio e Giudici, Ungaretti e Attilio Bertolucci, che più distanti non potrebbero essere. Il punto è che fatichiamo a vedere il saggio per quello che è, cioè un genere letterario. A tenere assieme l’antologia non può essere la materia dei saggi, ma solo la loro forma (e proprio La forma del saggio si intitolava il libro di Berardinelli pubblicato più di vent’anni fa).
A identificare il genere saggio concorrono due fattori. Il saggio è sempre una scrittura seconda, cioè si applica a un oggetto, e questo lo distingue dalla letteratura che chiamiamo “creativa”. E’ costitutivamente interpretativo, è il risultato dell’incontro tra un soggetto e una materia, che può essere un’opera d’arte, ma anche qualcosa che con l’arte non ha nulla a che vedere: un tic del linguaggio, un fatto politico, una moda culturale, un personaggio dello spettacolo. La seconda caratteristica che identifica il saggio è che si tratta di un genere che pur non essendo fiction richiede doti di scrittore. Il vero saggio è sempre personale, anzi idiosincratico, autoriflessivo, parziale, decentrato, sfuggente, ibrido. E’ sempre sperimentale: “saggio” rinvia a “tentativo”. E’ diverso dalla scrittura che chiamiamo “creativa” ma creativo lo è altrettanto. Non per nulla il Novecento è stato il secolo in cui anche il romanzo si è fatto saggistico, da Musil a Mann a Kundera e, in Italia, da Arbasino a Siti. Nato sostanzialmente con il sorgere dell’opinione pubblica, nell’Inghilterra del Settecento, il saggismo è esploso nel Novecento, secolo in cui i confini tra i generi letterari si sono complicati e talora sono saltati, e questo ha portato in primo piano un genere che, come è stato detto, “consiste essenzialmente nella mediazione tra sfere diverse dell’esperienza umana”. Ma proprio la contrazione dello spazio pubblico di discussione e di confronto che stiamo vivendo sta mettendo in crisi questo genere fino a pochi decenni fa così fiorente. Scrittura saggistica ed esercizio della critica sono andati separandosi. Quando gli editori vogliono farti capire che non pubblicheranno il tuo libro dicono “è solo una raccolta di saggi”. I social possono forse riformulare altri generi letterari (Edgar Morin ha provato a trasformare i tweet in aforismi), ma la rete non ha spazio per il genere riflessivo per eccellenza. Berardinelli e Marchesini volevano fare un’antologia, ma forse la loro è un’elegia per un genere in via di sparizione.