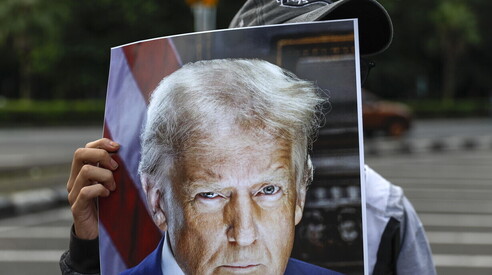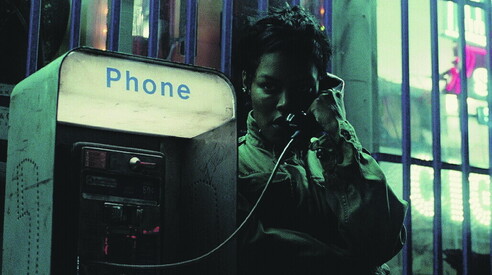Fotografia di Julius Evola (WikiCommons)
La raccolta di saggi
Chi riduce Evola al fascismo dovrebbe leggerlo meglio
Il volume appena uscito, "Dal Mediterraneo al Nord Olimpico" (Mediterranee), ne raccoglie saggi e articoli comparsi tra il 1920 e il 1945. Le invettive contro nazionalismi e populismi e una precisa idea di Europa
Interventista a fianco degli Imperi centrali nel più infranciosato e antigermanico dei paesi, aristocratico individualista sotto il fascismo, monarchico ultrareazionario nella nascente repubblica, Julius Evola ha vissuto sistematicamente contro il proprio tempo. Più che studiosi e critici, attirò entusiasmo o odio. “Il nostro Marcuse, ma più bravo”, diceva Giorgio Almirante. “Un razzista così sporco che ripugna toccarlo con le dita”, pensava Furio Jesi. Un libro appena uscito, “Dal Mediterraneo al Nord Olimpico” (Mediterranee), raccoglie saggi e articoli comparsi tra il 1920 e il 1945, con qualche incursione nei primi anni Cinquanta. Molti riguardano i rapporti tra cultura italiana e tedesca, pubblicati sulla “Europäische Revue” (organo non ufficiale della Rivoluzione conservatrice, ricorda Nuccio D’Anna nella prefazione) accanto alle firme di Hofmannsthal, Heidegger, Schmitt, Churchill, Valéry, Mann.
Gli spregiatori che lo confinano dentro il cattiverio fascista e i seguaci che frugano nei suoi libri come i ladri nelle casseforti, gli uni e gli altri dovrebbero confrontarsi con le invettive di Evola contro i nazionalismi plebei e con le dichiarazioni sulla necessità di una comunità europea, non troppo lontana da quella immaginata da Richard Coudenhove-Kalergi, il gentiluomo promotore del movimento paneuropeista. Accusato oggi dai complottari di internet di avere elaborato un piano di “sostituzione immigrazionista”, Evola lo intervistò nel 1933, raccogliendone – oltre a un panegirico di Mussolini – un programma in tre punti: unità economica, unità di politica estera, unità militare.
Scettico sulla capacità delle masse, drogate di provincialismo nazionalistico e comunismo, di avviare un’autentica integrazione europea, nel dopoguerra Evola invoca una nuova classe dirigente. A differenza di Pareto, per il quale la selezione delle élite si basa su forza, astuzia e altri tratti che permettono di cavarsela in una lotta darwiniana, Evola è convinto che il gruppo dominante non si distingua per successo mondano o abilità sociale, ma per l’attitudine interiore e la fedeltà a valori trascendenti: tradizione, onore, ascesi. I migliori non sono i più forti o scaltri ma quelli che si elevano sopra la vita biologica e utilitaria. In loro, stile, disciplina, capacità di obbedire e comandare in modo impersonale – l’ethos – prevalgono su pulsioni ed emozioni, il pathos. “Si dovrebbe pensare a una unità organica che si realizzi attraverso dei vertici, non attraverso le basi. Solo élite delle singole nazioni europee potrebbero intendersi e coordinarsi superando il particolarismo e lo spirito di scisma, facendo valere, con la loro autorità, interessi e motivi più alti”. L’ultima volta era successo a Vienna, quando si diedero convegno i sovrani della Santa Alleanza. Evola credeva che anche la nascita della nuova Europa non sarebbe dipesa dall’atteggiamento della moltitudine ma dalla determinazione di pochi. Come scrisse Spengler, da lui tradotto, alla fine è sempre un plotone di soldati a salvare la città.