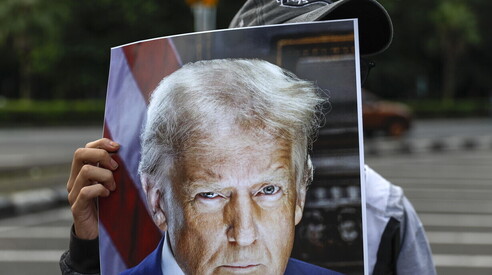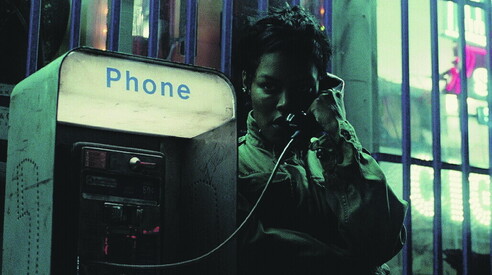Foto Ansa
il confronto
Siamo sicuri che il post liberalismo sia meglio del liberalismo? Anche no
Senza discussione critica e potere limitato, la democrazia si trasforma in una nuova forma di dominio. Il post-liberalismo promette coesione e ordine ma rimuove i fondamenti della società aperta
"Ci sarà pure un giudice a Berlino” è l’espressione attribuita al mugnaio Arnold di Potsdam, il quale si ribellò all’ingiustizia del barone. Il mugnaio troverà giustizia, nonostante i tanti giudici corrotti e, portando il suo caso fino a Berlino, al cospetto del sovrano, trovò un giudice che gli diede ragione. Da sempre questa frase è considerata la massima espressione della giustizia, contro il potere arbitrario. La giustizia è la condizione necessaria perché si possa istituire un ordine politico liberale, una società aperta, animata dalla discussione critica. Il liberalismo esprime la teoria e la prassi del potere limitato, perché, sulla scia di Lord Acton, sappiamo che “se il potere tende a corrompere, il potere assoluto corrompe in maniera assoluta”. Il liberalismo è dunque la filosofia politica della contingenza umana che pone limiti al sovrano. E’ a partire da questa considerazione che prendono forma le democrazie liberali e in questo si differenziano dai regimi illiberali, le cui istituzioni rispondono al capriccio del sovrano, sia esso un re, un Parlamento, il Popolo; si pensi, ad esempio, alle democrazie illiberali.
E’ stato Karl Popper a offrire una chiave di lettura per cogliere il senso più profondo del modello liberal-democratico, allorché mostra quanto sia insensata e pericolosa la domanda platonica su chi debba governare. Insensata perché ci conduce alla ricerca di qualcosa che semplicemente non esiste: il quid del governare, come se esistessero persone, classi o ceti dotati per natura, dunque chiamati dal destino, a governare su altre persone. Ma anche pericolosa perché instilla in coloro che si sentono investiti di tale quid, la pretesa di farlo senza alcun limite e controllo. Al contrario, afferma Popper, la domanda sensata e utile non è chiedersi chi dovrebbe governare, bensì come organizziamo il potere, affinché chi governa lo faccia bene o, quantomeno, non faccia troppi danni? Se questo è il senso più profondo della democrazia liberale: istituzioni che consentano al potere di limitare il potere, appare quanto mai problematica la posizione di coloro che intendono promuovere un ordine politico di tipo “post liberale”. E’ questa, ad esempio, la posizione espressa dal teorico della politica Patrick Deneen, docente presso la Notre Dame University dell’Indiana, negli Stati Uniti. Noto ai lettori per la sua opera Why Liberalism Failed (2018), Deneen è stato invitato di recente al Meeting di Rimini per presentare il suo nuovo volume: Regime Change. Toward a Postliberal Future (2024).
La tesi post liberale è ben nota: il liberalismo, avendo portato a compimento il suo progetto di emancipazione, è costretto ad ammettere anche il suo superamento. Di fatto, la realizzazione dell’istanza liberale progressista, mediante il riconoscimento di diritti individuali e “insaziabili”, registrerebbe anche il dissolvimento di quei legami che tenevano insieme la società. Di qui, l’esigenza di riconoscere il fallimento dell’ordine liberale, basato sui cosiddetti weak goods: società aperta, globalizzazione e discussione critica, e la necessità di individuare nuove soluzioni che, al momento, lo stesso Deneen non sembra riuscire a definire, se non rimandando a uno spirito comunitario che possa far risorgere gli strong goods: la religione, la nazione e i sentimenti familiari. A essere onesti, andrebbe riconosciuto che il post liberalismo, essendo un’espressione della cultura politica statunitense, sconta lo slittamento lessicale che il termine liberale ha subito negli ultimi decenni, facendo coincidere liberale con progressista e allontanandosi, quasi irrimediabilmente negli Stati Uniti, dal liberalismo classico.
Un tale slittamento ha condotto una buona parte del mondo conservatore statunitense a rinunciare definitivamente all’utilizzo del termine liberale, come si usa dire: gettando il bambino con tutta l’acqua sporca, e consegnandolo in toto all’avversario, così finendo per far coincidere liberale con quanto di più distante si possa immaginare dal liberalismo classico, in particolar modo, con le tante espressioni della woke culture e del progressismo. A questo punto qualche domanda e una considerazione finale. Di fronte alla denuncia di fallimento del liberalismo, sotto il profilo istituzionale, in che cosa consiste il post-liberalismo e come i suoi teorici intendono organizzare il potere affinché chi governa non faccia troppi danni? Comprendiamo che la società aperta e la discussione critica possano risultare fastidiose, ma cosa propongono i fautori del post liberalismo, forse la quiete dei cimiteri, in modo da non disturbare il sovrano? Se la discussione critica irrita perché accoglie nella public square posizioni che riteniamo inaccettabili, come reagiremo quando le nostre posizioni saranno ritenute tali? Accetteremo senza batter ciglio la soppressione di giornali il cui posizionamento sarà ritenuto dal potere egemone non conforme al regime, magari al “nuovo corso” della storia? E cosa accadrà ai docenti che nelle scuole e nelle università non saranno disposti ad allinearsi ai precetti degli strong goods che indicheranno gli obiettivi del nuovo regime? Se la democrazia liberale è una società aperta ed è sorretta dalla discussione critica, qualsiasi democrazia post liberale, rinunciando alla società aperta, non potrà che essere una “via verso la schiavitù”. Fare a meno della società aperta e della discussione significa rinunciare a quanto di più umano e vitale si possa immaginare, d’altra parte il liberale, cioè il popolare, vive di critica.