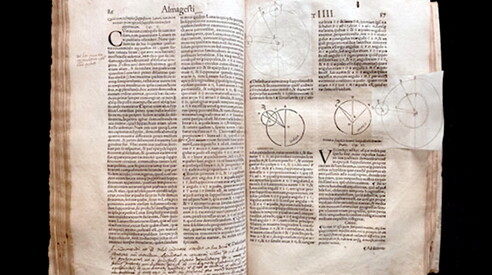Foto LaPresse
Magazine
Gli zoo sotto le bombe: quando anche gli animali subiscono la guerra
Quelli tedeschi erano il fiore all’occhiello del Terzo Reich, poi arrivò il conflitto. E molti diventarono rifugio per perseguitati in fuga. Buoni motivi per interessarsi al destino dei bioparchi, metafora di impotenza e degrado
Se vi capitasse di visitare lo zoo di Berlino, un’area di oltre due chilometri quadrati dentro il Tiergarten, il grande parco nel cuore della parte occidentale della città, non perdetevi la casa degli elefanti. Proprio di fronte, un piccolo memoriale ricorda gli animali dello zoo che furono vittime della Seconda guerra mondiale. A illustrarlo sono due foto, la prima è della famosa pagoda in stile asiatico costruita negli anni Venti per ospitarvi i pachidermi, la seconda immortala lo stesso edificio o, meglio, quanto rimase di esso, dopo un bombardamento alleato del 1943: dalla montagna di detriti, emerge la gamba insanguinata di un elefante. Era ancora giovane John M. Kinder, oggi docente di Storia alla Oklahoma State University, quando alla fine degli anni Novanta, in vacanza nella capitale tedesca, decise di dedicare un pomeriggio al celebre zoo, invece di passarlo al museo. “Mi colpì soprattutto – racconta lo studioso – che il memoriale fosse manipolativo e incompleto. C’era un’evidente reticenza a contestualizzare la morte degli animali, raffigurandoli invece in termini simbolici, come fossero vittime innocenti di una guerra in cui la Germania e i responsabili dello zoo non avessero svolto alcun ruolo. Ci ho pensato per anni”.
“World War Zoos” è il saggio di John M. Kinder che racconta dilemmi strazianti: 200 animali soppressi a Londra allo scoppio della guerra
Pubblicato dalla University of Chicago Press, “World War Zoos” è il risultato di quelle riflessioni, la cronaca puntuale e straziante ma ricca di illuminazioni sorprendenti di come giardini zoologici e bioparchi sopravvissero al decennio più mortifero della Storia umana, dalla Grande depressione alla Guerra civile spagnola, dagli orrori del conflitto scatenato da Hitler fino all’alba dell’era atomica e della Guerra fredda. La Seconda guerra mondiale rappresentò una minaccia esistenziale agli zoo del mondo intero: alcuni furono rasi al suolo. Altri subirono l’occupazione straniera e videro i loro padiglioni oggetto di saccheggio o teatro di massacri da parte delle truppe nemiche. Ma anche quelli che vennero risparmiati dovettero affrontare dilemmi laceranti e inconfessabili: che fare quando si esaurivano le scorte di cibo? Quali animali bisognava sopprimere per proteggere la vita di altri? E come giustificare il voler tenere i predatori più preziosi, ma anche più pericolosi, che potevano ritrovarsi liberi e fuggire in caso di un bombardamento aereo? La guerra ebbe effetti devastanti sui giardini zoologici di tutto il mondo in ogni modo possibile. Limitò, quando non li privò del tutto, cibo, medicine, carburante e personale, causando malattie e morti premature fra gli animali. Quelli che sopravvivevano alle penurie erano traumatizzati dai bombardamenti, finivano mangiati da soldati affamati, perfino sacrificati, cioè, uccisi dagli stessi responsabili degli zoo per evitare rischi di fuga o perché bisognava stringere la cinghia e non era più possibile accudirli tutti.
C’erano tremila bestie nel Tiergarten berlinese allo scoppio delle ostilità nel 1939. Alla fine, nel 1945, ne rimanevano appena 91
C’erano tremila bestie nel Tiergarten berlinese allo scoppio delle ostilità nel 1939. Alla fine, nel 1945, ne rimanevano appena 91. Ogni zoo ha i suoi racconti dell’orrore. A Londra, poche ore dopo che Neville Chamberlain aveva annunciato che la Gran Bretagna era in guerra con la Germania, iniziò un’ecatombe motivata da ragioni di sicurezza che in solo mese portò alla soppressione di oltre 200 animali, fra i quali sei alligatori, quattro leoni, due giaguari, sette lupi, dieci volpi, una tigre siberiana, tre bisonti americani, sedici anaconda, decine di uccelli rarissimi. La politica della terra bruciata che Hitler volle nei paesi dell’est si rispecchiò perfettamente negli zoo. Ovunque arrivassero le armate naziste in Polonia e poi in Russia, l’ordine era di sequestrare gli animali più preziosi (in base a liste precise) per trasferirli nei bioparchi tedeschi e di sterminare tutto il resto, bestie, guardiani e strutture: “Agli occhi degli occupanti nazisti, i popoli slavi impuri non avevano diritto di esistere, tantomeno di possedere degli zoo”, scrive Kinder. Tutti gli animali dello zoo di Kyiv vennero confiscati e caricati su treni con destinazione Könisberg. Quelli di Varsavia e Cracovia andarono ad arricchire le collezioni di Hannover, Monaco e Berlino.
Nella Germania hitleriana, infatti, gli animali erano tenuti in grande considerazione e il regime perseguì una politica di forte espansione degli zoo, che vennero ammodernati e godettero di generosi finanziamenti pubblici. Già nel 1933, poco dopo l’arrivo di Hitler al potere, il governo tedesco varò la Reichstierschutzgesetz, la legge per la protezione degli animali, che fra l’altro introduceva una pena minima di due anni di prigione per chiunque facesse male a una bestia, domestica o selvatica. Fu probabilmente il più completo strumento legislativo animalista dell’epoca. Hitler teneva molto alla sua reputazione di vegetariano e amico degli animali, pare che chiudesse gli occhi quando in un film c’erano scene di violenza contro di loro. Quanto al suo vice, Hermann Göring, teneva un mini-zoo, completo di cuccioli di leoni, nel suo buen retiro di Karinhall, nel Brandeburgo: un articolo del New York Times del 1933 lo definì “a great lover of animals”. Tutti i gerarchi erano in competizione nel fare donazioni di esemplari rari ai giardini zoologici del Reich. “Agli occhi degli ideologi nazisti – spiega l‘autore – gli animali erano più che una estensione della proprietà umana; erano parte di un universo morale condiviso, nel quale la loro protezione era un modo di rinvigorire la nazione, ancora traumatizzata dalla depressione economica e dal collasso spirituale”.
In questo contesto, gli zoo furono strumenti cruciali dell’auto-rappresentazione del regime, manifestazioni vive della visione del mondo nazionalsocialista, aree protette dove il forte regnava sul debole, sotto il controllo di guardiani in uniforme. Per Joseph Goebbels, il capo della propaganda, erano l’illustrazione plastica delle leggi eterne della sopravvivenza, delle virtù dell’aggressione, dell’inevitabilità del conflitto. Fu allo zoo di Berlino, alla vigilia delle Olimpiadi del 1936, che Goebbels a nome del Führer accolse oltre mille giornalisti accreditati ai Giochi in un fastoso ricevimento, rassicurandoli che il governo del Reich (sic) “non aveva alcuna intenzione di usare la manifestazione come propaganda di stato”. L’espressione più significativa e tragica della zoo-mania dei nazisti fu probabilmente la nascita di un nuovo bioparco, seminascosto in una foresta di faggio della Turingia, poco fuori Weimar, la città di Goethe. La sua costruzione iniziò nel 1937 proprio accanto a quella di una nuova colonia di lavoro penale, all’inizio chiamata “Ettersberg Konzentrationslager” e ufficialmente destinata ai prigionieri politici e ai “devianti sociali”. Sarebbe diventato famoso come Buchenwald, il più grande campo di concentramento nazista nel sistema dell’Olocausto.
La funzione dello zoo presso Buchenwald: mostrare ai deportati ebrei il loro posto nell’ordine del campo, dove gli animali stavano meglio di loro
Ma a che servivano leoni, foche, uccelli rapaci, orsi, volpi, pavoni, scimmie, cervi e quant’altro nell’area di un campo di sterminio? Gestito personalmente dal famigerato comandante del lager, Karl Otto Koch, lo zoo non solo aveva la funzione di allietare di ufficiali e soldati delle SS durante la libera uscita, ma era anche un’attrazione per le famiglie di Weimar, che le domeniche arrivavano numerose con i bus pubblici, incuranti della sofferenza e del dolore intorno. Ma c’era un altro ruolo: mostrare ai deportati ebrei, usati per la manutenzione di gabbie e strutture, il loro posto nell’ordine del campo, dove gli animali godevano di condizioni infinitamente migliori di loro, considerati non umani. “Mentre migliaia di prigionieri morivano uccisi, torturati, affamati o di fatica, le scimmie consumavano regolarmente i loro pasti a base di avena, patate e latte, mentre ancora nel 1944 gli orsi ricevevano anche la poca carne sottratta al rancio degli internati”. Quella dello zoo di Buchenwald fu forse la metafora più potente dell’universo concentrazionista.
La ricerca di Kinder svela tuttavia anche momenti di grande compassione ed eroismo nell’universo degli zoo in Europa e nel resto del mondo durante il grande massacro. Straordinaria è la storia dello zoo di Amsterdam, dove il direttore Armand Sunier riuscì a nascondere dagli occupanti nazisti centinaia di cittadini ebrei, sottraendole a una sicura deportazione verso Auschwitz. Passavano giorni e notti nelle gabbie, accanto agli animali rimasti, il cui calore li riparava dal freddo, meglio il tanfo e le pulci invece di un viaggio verso la morte. Alcuni ci dovettero rimanere mesi o anni. Celebre fu il caso di un gruppo di ragazzi ebrei in fuga da una ronda di SS: Sunier li condusse subito verso l’isola delle scimmie, li fece passare dalla vasca piena d’acqua e li nascose dietro la finta roccia della cascata. La signora Duifje van den Brink restò per quattro anni vivendo nelle gabbie ormai svuotate di animali, morti o portati via dai nazisti. A guerra finita, ormai ultrasessantenne, amava guidare dei tour raccontando la sua storia.
Durante l’assedio di Leningrado, quando le forze naziste cercarono di affamare la città sovietica, furono gli stessi cittadini a inventarsi modi per non far morire d’inedia gli animali del celebre zoo: portavano topi, carcasse di cavalli morti nei bombardamenti, raccoglievano piante commestibili nelle campagne. Una donna, Yevdokia Dashina, si prese cura dell’unico ippopotamo del bioparco: non solo lo nutrì con segatura bollita e i resti di un impianto per la raccolta della spazzatura, ma lo massaggiava ogni giorno con olio di canfora per evitargli le piaghe causate dalla poca acqua a disposizione.
La donna che si prese cura dell’ippopotamo durante l’assedio di Leningrado. L’animale sopravvisse al blocco e morì solo nel 1951
L’animale sopravvisse al blocco e visse fino al 1951. Ma lo zoo non evitò l’ecatombe: gli esemplari più preziosi – tigri, orsi polari, pantere nere, un rinoceronte – erano stati evacuati verso Kazan, sul Volga, nel 1941 a bordo di un treno del quale si persero le tracce. Quando iniziarono i bombardamenti, il direttore diede ordine di sopprimere quelli più pericolosi. Ma non fece in tempo, la maggior parte vennero uccisi dalla pioggia di fuoco che cadeva dal cielo. Ma perché, si chiede l’autore, dovremmo interessarci agli zoo durante la Seconda guerra mondiale, l’evento più distruttivo della Storia umana, in cui morirono 75 milioni di persone e si consumò l’orrore dell’Olocausto? Kinder offre varie risposte. Una è che gli zoo avevano un posto molto importante nelle società degli anni Trenta, democrazie o dittature che fossero, e ci dicono molto di queste. I governi vi investivano somme milionarie, dalla Francia all’Italia, dagli Stati Uniti all’Unione sovietica. Per i regimi totalitari erano un’ossessione: abbiamo detto della Germania, ma anche il Giappone non fu da meno, al punto da fondare uno zoo anche nella Manciuria occupata. Inoltre, gli zoo dell’epoca di guerra erano microcosmi delle città (e delle nazioni) dove sorgevano, cittadelle in miniatura, con i loro rifugi antiaerei e la propaganda di guerra con poster di animali felici di dare il loro contributo alla causa nazionale. Nei bioparchi venivano ospitati raduni patriottici, si tenevano mostre educative, venivano perfino svolte ricerche utili allo sforzo bellico. Ma soprattutto, “gli zoo ci fanno pensare”, offrendoci metafore di esperienze estreme come la prigionia, l’impotenza, il degrado. “Viste oggi, gli zoo durante la Guerra mondiale ci offrono una prospettiva diversa per esplorare la nascita del nazismo, i drammi morali del collaborazionismo e della resistenza, la necessità della ricostruzione dopo l’apocalisse”, compresa quella nucleare come racconta il capitolo sullo zoo di Nagasaki. Di più, la storia dei giardini zoologici in quegli anni, durante i quali vennero bombardati, saccheggiati, decimati, affamati, è anche un’allegoria delle crisi del nostro tempo, dove il collasso degli ecosistemi, la crescita demografica e l’aumento delle temperature minacciano la stessa esistenza di molte specie animali in tutto il pianeta.