
Georgy Lukacs (LaPresse)
Post marxisti
Le vecchie talpe francofortesi e il Grand Hotel Abisso ancora in attività
La Scuola di Francoforte ritiene che l’attività umana occidentale, al suo culmine negativo, abbia portato ad Auschwitz. Per un tale percorso non può esserci riscatto, ma solo apocalisse. Questa narrazione è facile da propalare attraverso i grandi canali di comunicazione di massa
Gyorgy Lukacs, simbolo del marxismo ortodosso nel Novecento, autore, tanto per capirci, di “Storia e coscienza di classe”, descriveva gli apostati post marxisti-freudiani della Scuola di Francoforte (Adorno, Horkheimer, Marcuse) come gli abitanti di un Grand Hotel Abisso, che è diventato poi il titolo di un libro di Stuart Jeffries. Questo hotel, dotato di tutti i comfort, affacciava appunto “sull’orlo dell’abisso, del nulla, dell’insensato”. Era un luogo da cui si poteva osservare quello che avveniva tanto in occidente quanto nel resto del mondo criticando tutto, criticando anche la critica, gettando uno sguardo di condanna senza possibilità di clemenza su tutto ciò che esisteva. E ovviamente senza proporre alcuna soluzione alternativa ai paradigmi esistenti. Ogni nuovo paradigma sarebbe stato, infatti, a sua volta repressivo proprio in quanto affermava qualcosa, “imponeva” qualcosa.
Per Lukacs, per il quale alla critica doveva sempre affiancarsi una prassi attuativa (più o meno rivoluzionaria), questa prospettiva costituiva il massimo della degenerazione post marxista: una critica sterile che non preparava alcuna società nuova ma si ritirava nelle stanze confortevoli dei propri alloggi accademici divenendo, sostanzialmente, una parte di quell’industria culturale che la Scuola di Francoforte stessa tanto criticava. Non si presentava alcun modello alternativo, né allo stalinismo né al capitalismo che era a sua volta pensato come una forma più avanzata di fascismo: forme di sfruttamento dell’uomo sull’uomo e di repressione del desiderio, prevalenza del principio di prestazione su quello di piacere, e via andando di freudismi vari imbevuti di marxismo e di messianismo.
Centrale nella critica francofortese a tutti i modelli esistenti era la critica alla concezione del “lavoro”. Su questo punto la critica a capitalismo e marxismo praticamente veniva a sovrapporsi (per poi divaricarsi totalmente altrove). La critica alla concezione del lavoro era quella più corrosiva, più penetrante a livello di comprensione divulgativa e, allo stesso tempo, più deleteria. Come scrive Max Horkheimer: “Elevare il lavoro a concetto supremo dell’attività umana significa professare un’ideologia ascetica […]. Mantenendo questo concetto generale, i socialisti si fanno portatori della propaganda capitalistica”. Si capisce benissimo la distanza siderale da Marx, secondo cui l’uomo e la donna hanno bisogno di lavorare per realizzarsi e conquistare la propria dignità. E ancora di più la distanza da Hegel, secondo cui il lavoro non era altro che l’attività umana per eccellenza, il modo in cui l’oggetto diviene soggetto, ossia in cui l’uomo assimila la realtà trasformandola in qualcosa di più propriamente suo, secondo ragione: l’uomo diviene sé stesso nella misura in cui muta la materia passiva attraverso la propria attività, e così realizza la propria essenza. Per la Scuola di Francoforte tutto ciò rappresentava uno dei massimi errori da cui allontanarsi, un errore endemico all’occidente, praticamente fin dall’inizio della sua vicenda, arrivando a postulare Ulisse come il proto-borghese che, attraverso il raziocinio, inganna e addomestica la natura. Meglio allora, per i francofortesi, starsene chiusi nell’hotel abisso a criticare tutto, piuttosto che fare il gioco di questa società basata sul principio di prestazione.
La critica di Lukacs alla Scuola di Francoforte rimane attualissima dinanzi a una intellighenzia globale che, lo sappiamo bene, non perde occasione per tentare di demolire il modello occidentale (o se vogliamo il capitalismo liberale) ancora e sempre basato su un qualche “principio di prestazione”, sulla competizione, sulla produzione, sull’innovazione, sul consumo, e su tutti quegli altri fattori considerati terrificanti malanni dell’occidente, e che ne sono invece il carburante e l’acceleratore. L’alternativa, ovviamente, oggi ancora più di sessant’anni fa, è assente. Non vi è altro modo di produrre ricchezza e benessere. Tuttavia, non c’è nulla da fare, le talpe francofortesi hanno ben scavato e l’hanno fatto in maniera letale.
La questione centrale del paradigma francofortese, e del disprezzo assoluto per tutto ciò che è attività umana fattiva, sta nel fatto che l’attività umana occidentale, capitalista/fascista in quanto tale, basata sulla ragione illuminista, che diventa pura ragione strumentale laica che non conosce limiti alla propria potenza, alla fine del suo percorso, al suo culmine negativo, ha portato ad Auschwitz. Per un tale esito, per un tale percorso, non può esserci riscatto, ma solo apocalisse. Questo pensiero tremendo, manipolatorio, eppure di grande efficacia comunicativa (in un mondo dispostissimo ad accogliere la colpa nel modo più totale) informa tutt’ora, in maniera più o meno conscia, buona parte dell’intellighenzia globale e dei suoi movimentismi antioccidentali che sono, dietro il pensoso coté iper-pietista (pietà per tutto ciò che soffre, dalla natura in giù – nessuna sofferenza è infatti più accettabile) radicalmente e inevitabilmente antiumanisti, proprio perché l’uomo non può essere altro che la sua attività: e quindi la sua ragione e la propria volontà di trasformare, dominare, assimilare. La vittima, vittima ovviamente dell’attività umana, vittima vegetale, animale o umana che sia, diviene il “surrogato del proletariato”, il nuovo “soggetto rivoluzionario” che deve ribaltare (in maniera melliflua, pietosa e sempre rivestita delle “migliori intenzioni”), l’ordine repressivo/fascista/capitalista. E questa narrazione, al di là dei bizantinismi concettuali dei libri che la contengono, è facile da propalare attraverso i grandi canali di comunicazione di massa: vende bene, è empatica, ci fa sentire buoni.
Si capisce allora che ciò che c’è in ballo qui non è semplicemente la critica a una scuola di pensiero, ma vi è in ballo l’intera prospettiva culturale, e quindi politica, su ciò che l’uomo deve essere o, addirittura, se l’uomo possa ancora essere.
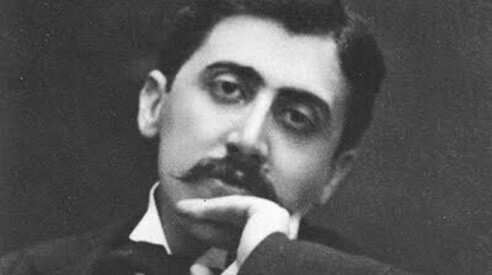

Amleto e miss Marple
Indomabile. È un romanzo sulla vita della ragazza che inventò il mistero
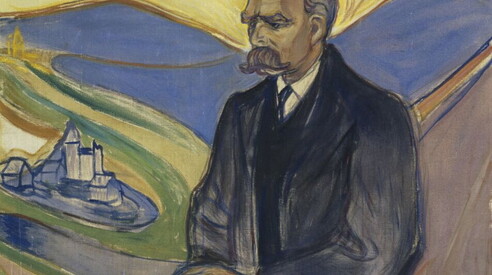
scrollarsi di dosso il passato per guardare al futuro


