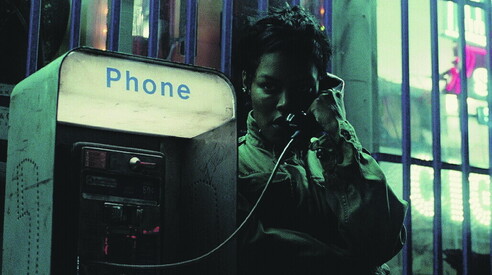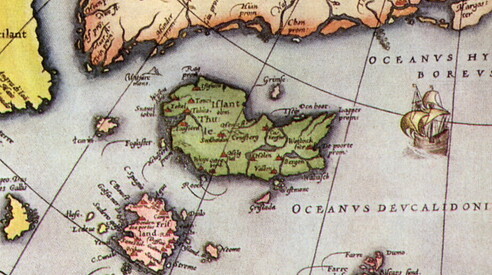Foto Getty
Quid est veritas? /7
La domanda implacabile
La verità è che l’uomo, posto di fronte alla scelta tra continuare a vivere nel mondo artificiale del “Truman Show” o, come alla fine del film, evadere da esso, deciderà per la seconda alternativa
Quid est veritas? Questa la domanda pronunciata quasi duemila anni fa dal prefetto della provincia romana di Giudea Ponzio Pilato. Affinché il suo nome non fosse dimenticato e il nucleo storico del cristianesimo non si dissolvesse in speculazioni mitologiche, i cristiani hanno incluso Pilato nella “Magna carta” della loro religione, la professione di fede del Credo. La religione cristiana ha, come nessun’altra, un fondamento storico. Al suo centro sta la ferma convinzione che, in un dato momento della storia dell’universo, il Verbo eterno di Dio “si è fatto carne” (Gv 1, 1-14) in Gesù di Nazareth, in una persona storicamente esistita. Così, Dio ha perduto ogni connotazione mitologica ed è divenuto mortale. E anche colui che pronunciò una sentenza di morte sul Dio fattosi uomo è una figura storicamente esistita. Non possiamo dire con certezza con quale intenzione questa domanda sia stata posta durante il primo interrogatorio del processo contro Gesù (Gv 18, 38), sebbene l’evangelista ne offra una descrizione storicamente accurata dal punto di vista giuridico. Era espressione di una sincera volontà di conoscere, come in un dialogo tra due intellettuali? Era indizio di una simpatia nei confronti dell’accusato, del cui conflitto con i rappresentanti di una religione che egli odiava Pilato si rammaricava? O si trattava della domanda retorica di un filosofo scettico, secondo il quale gli uomini non possono conoscere la verità, quand’anche una verità esista davvero?
Gli storici Giuseppe Flavio e Filone di Alessandria concordano su questo punto: Pilato era un governatore e un giudice inflessibile. Eppure, di fronte a Gesù, egli esitò. Ecce homo (Gv 19, 5). Quest’uomo lo aveva colpito. Alla fine, tuttavia, per la condanna a morte fu sufficiente una motivazione formale: Gesù si era proclamato re (Gv 18, 37) e ciò costituiva un crimen laesae maiestatis, un attentato contro l’imperatore Tiberio e l’ordine politico romano. Il processo di Gesù e lo svolgimento secolare della discussione intorno alla verità dimostrano che il problema ha molteplici dimensioni. Helmut Thielicke (1908-1986), membro della Chiesa evangelica tedesca che resisté ai nazionalsocialisti, ha distinto tre concetti di verità: “Una verità che noi possiamo conoscere”; “una verità che ci riguarda”; e “una verità che ci comprende piuttosto che essere compresa da noi”.
1. Possiamo conoscere la verità? Per rispondere, dobbiamo trovarne una definizione generalmente condivisa. E subito ci accorgiamo che si deve distinguere tra due concetti di verità: una verità nel senso delle evidenze della vita quotidiana e una verità filosofica. Nel quotidiano, avremo il consenso altrui se affermiamo che domani il sole sorgerà o che l’estate è più calda dell’inverno. Con altrettanta sicurezza facciamo affermazioni come: “Michele mi è amico, mentre ho intuito che ad Anna non sono simpatico”. Si tratta di affermazioni su cui si può fare affidamento, perché basate su una esperienza quotidiana. Gli empiristi parlano qui di “realismo interno”.
Ma queste certezze vacillano quando i costruttivisti affermano che noi non conosciamo gli oggetti inanimati e le altre persone in quanto tali, bensì solo l’immagine che ce ne facciamo. Se le cose stanno così, tuttavia, non potremmo né amare né odiare gli altri. Non potremmo neanche affermare che gli altri esistono indipendentemente da noi. L’intera nostra vita individuale e collettiva sarebbe messa in dubbio. Per fare un’autentica esperienza degli altri – delle loro peculiarità, del loro modo di vivere o di parlare – abbiamo bisogno di una verità più solida, di una verità nel senso del realismo metafisico, di una filosofia della “conoscenza di ciò che in verità è” (Hegel). Io non mi limito a percepire o a supporre il mondo che mi circonda, ma so che esso è realmente presente, così come lo sono io stesso.
Questo rapporto tra il soggetto che conosce e l’oggetto conosciuto è espresso nella definizione tomistica della verità come adaequatio rei et intellectus. In essa, Tommaso D’Aquino ha unito l’ontologia di Agostino all’ideale scientifico di Aristotele, la cui opera lui e il suo maestro Alberto Magno avevano riscoperto e integrato nella propria dottrina filosofico-teologica. Aristotele aveva insegnato che la distinzione tra il vero e il falso non ha luogo “nelle cose in sé”, bensì “nell’intelletto” (en dianoia). L’esserci della cosa non è in sé la verità, ma il presupposto o il contenuto della verità (ratio veritatis). La conoscenza dell’intelletto è “in una certa misura causata” (quodammodo causatur) dall’esserci della cosa, di fronte alla quale compito dell’intelletto è distinguere, con un atto del giudizio (iudicium) che congiunge e che separa, ciò che è da ciò che non è. L’esserci degli oggetti si manifesta e si compie nella conoscenza intellettuale dell’anima, la quale “è in grado di accordarsi a ogni ente” (De veritate, I, 1). Se ne deduce che “il conoscibile è la misura della conoscenza umana e il giudizio operato dall’intelletto è vero in quanto la cosa si pone in quel dato modo (quia res ita se habet), non il contrario” (Summa contra gentiles I, 61). Pertanto, vero è il giudizio dell’intelletto che si è adeguato all’oggetto ad esso esterno. Tommaso non manca poi di indicare la differenza fondamentale tra la conoscenza umana e quella divina. La conoscenza di Dio è misura di tutte le cose, così come l’arte è misura di tutte le opere d’arte. Falsità ed errore si danno solo nell’intelletto limitato degli uomini, non in Dio.
Il dibattito filosofico dei secoli successivi ha in fondo per lo più prodotto ulteriori variazioni della posizione tomistica. Lo stesso Kant, pur con la sua “rivoluzione copernicana” della filosofia trascendentale, si tiene ancora saldamente all’idea di un “accordo tra la nostra conoscenza e gli oggetti”, come scrive nella Critica della ragion pura. Il suo porre l’accento sulle condizioni soggettive della conoscenza, tuttavia, non è senza conseguenze. Infatti, se gli oggetti sono costituiti dal soggetto che conosce, quanto ancora a lungo è possibile mantenere l’idea di una loro corrispondenza con esso? Questa corrispondenza – concetto che non equivale affatto alla adaequatio di Tommaso – finisce per diventare solo “un accordo della conoscenza con se stessa”, (Walter Jaeschke). L’idealismo tedesco ha spostato nettamente il baricentro sull’organo della conoscenza, celebrandone con sempre maggiore pathos la libertà: l’Io o la “personalità” di Schelling, l’autocoscienza e la consapevolezza di Fichte, il “sentimento della convinzione” di Schleiermacher, il soggetto di Hegel, tutti elevati al rango di un principio oggettivo. Questa impostazione sbilanciata sul soggetto si è riproposta sul finire del ventesimo secolo, quando biologi e neuroscienziati hanno sostenuto che la conoscenza e la volontà basata su di essa non sarebbero altro che stati cerebrali. Ciò renderebbe superflua ogni discussione sulla ricerca della verità. Tuttavia, è una discutibile riduzione voler fare del cervello, un oggetto immanente della ricerca medica, il punto di partenza di tutta la realtà. Una riduzione, inoltre, infondata: questa teoria rivendica per sé quella verità metafisica di cui esclude la possibilità. La verità, infatti, si lascia conoscere, ma non negare. Karl Otto Apel (1922-2017) ha rilevato la “contraddizione performativa” in cui viene a cadere chi sostiene che la verità non esista, o che non sia possibile conoscerla, perché chi afferma ciò ritiene vero che la verità non esista o che non sia accessibile.
2. A nessuno la verità può essere indifferente. Essa “ci riguarda” direttamente, soprattutto quando distrugge l’immagine che ci siamo fatti di noi stessi. Questo dicono i due esametri di Goethe: “Verità che fa male, la preferisco al comodo errore / essa stessa risana il dolore che può averci procurato”. Neanche chi vive di menzogne può fare a meno della verità: essa è il presupposto per la riuscita della sua frode, nel senso che egli fa affidamento sul fatto che gli altri credano che dice e che agisce secondo verità. La verità non è solo un affare di morale individuale, ma ha un carattere etico-sociale. Una società può andare avanti sopportando mentitori e ingannatori, fin tanto che il diritto penale impedisce alle loro manipolazioni di prevalere e la menzogna non diventa sistematica. Ciononostante non si può decidere, come si vuol fare in alcuni stati dell’Unione europea, di vietare le menzogne nella fattispecie delle fake news. Il diritto penale riguarda la condotta esteriore degli uomini. Affermazioni fattualmente errate possono essere confutate, ma non altrettanto le “false” opinioni, che gli uomini si formano nel proprio intimo. La tendenza a voler bandire opinioni e orientamenti “politicamente scorretti” mina l’autorità della verità e conduce al totalitarismo.
Ma non può forse il potere politico permettersi qualunque cosa, quando ne ha la forza – quando, in una democrazia, ha la maggioranza? Torniamo così alla domanda che Pilato pone a Gesù dopo che questi ha parlato dei due regni, il regno “che è di questo mondo” e il regno “che non è di questo mondo”: “sei tu dunque un re?” (Gv 18, 37). Gesù risponde in modo indiretto, ma tocca il cuore del problema: “per questo io sono nato e per questo sono venuto al mondo: per rendere testimonianza alla verità”. La vita di Gesù ha avuto uno scopo, un telos al quale è subordinato anche il suo regno: testimonium perhibere veritati (nell’originale greco martyrein te aletheia). Tale testimonianza costituisce l’opposto della falsa testimonianza proibita dall’ottavo comandamento (Dt 5, 20): “Non renderai falsa testimonianza contro il tuo prossimo”, ovvero, letteralmente nell’originale ebraico, “testimonianza dello scevà” – di ciò che è nullo, vano, falso. Contro questa testimonianza Gesù entra in scena come testimone della verità, e fino alla morte.
3. “Chiunque è dalla verità, ascolta la mia voce” (Gv 18, 37). Ma il legame tra la verità e la persona di Gesù era al di là della capacità di comprensione di Pilato. Anche tra i dotti crebbe lo scetticismo riguardo alla capacità degli uomini di riconoscere la verità, e di riconoscerla in Cristo. Parte della responsabilità è anche di una teologia schematica e razionale sorta con la tendenza alla specializzazione delle discipline. David Hume ha condensato questo scetticismo nella frase we really never advance one step beyond ourselves. Avanzata nel quadro dell’empirismo, questa affermazione si sottrae essa stessa alla verifica empirica. Tra gli uomini non c’è nessuno che possa provare o confutare questo “mai”. E chi potrebbe garantire che “noi” siamo tutti ugualmente incapaci di fare un passo al di là di noi stessi, se siamo tutti intrappolati in noi stessi? La verità è che l’uomo, posto di fronte alla scelta tra continuare a vivere nel mondo artificiale del “Truman Show” oppure, come alla fine del film, evadere da esso, si deciderà per la seconda alternativa. Nel mondo reale, tutte le singole verità – anche quelle che ci fanno male – si integrano in un tutto. E “la verità vi farà liberi” (Gv 8, 32). Nel frattempo lo scetticismo ha lasciato il posto a un vero e proprio furore relativistico. “Tutto è relativo”, ci viene detto con il tono perentorio della verità assoluta. La corrente atea dell’Illuminismo aveva festeggiato il trionfo della verità sulle superstizioni cristiane e sui trucchetti dei preti. Ma proprio il grande pensatore del nichilismo, Nietzsche, ha visto che “la morte di Dio” è una “tragedia”. La sua “coscienza intellettuale” gli proibiva di aderire al cristianesimo, ma egli ammise che “anche noi che oggi vediamo chiaro, noi senza dio e noi antimetafisici, prendiamo il nostro fuoco dal grande incendio appiccato da una fede millenaria, quella fede dei cristiani, che era anche la fede di Platone, secondo cui Dio è la verità e la verità è divina”.
Se Dio non esiste, non esiste neanche la ragione né la possibilità per l’uomo di conoscere la verità e di giudicare il vero e il falso. L’uomo può fare affidamento sulla ragione solo se questa partecipa della ragione di Dio. Certamente nessuno detiene il monopolio della verità. La verità non è qualcosa che si possa possedere, semmai al contrario essa possiede noi. In suo nome, faremmo bene ad ampliare e a perfezionare le nostre teorie della conoscenza, anche con l’aiuto di tradizioni esterne all’Europa, come ha fatto ad esempio il sinologo Jean François Billeter.
Alla fine è così: è la verità a comprendere noi piuttosto che il contrario. Per i cristiani non può essere altrimenti. Perché per loro la verità è innanzitutto una persona divina, Gesù Cristo, che al suo scettico discepolo Tommaso disse: “Io sono la via e la verità e la vita” (Gv 14, 6). Non potremo mai compiutamente comprendere questa verità personale. Ma possiamo “operare” secondo verità, compiendo atti personali di giustizia e di carità. Chi “opera la verità viene alla luce” e appare chiaramente “che le sue opere sono state fatte in Dio” (Gv 3, 21). Così la domanda di Pilato riceve risposta.
(Il testo è stato tradotto da Giuseppe Perconte Licatese)
Wolfgang Hariolf Spindler OP insegna Teoria del diritto all’università di Innsbruck ed è caporedattore del periodico Die Neue Ordnung. Con il suo articolo si conclude la serie estiva del Foglio dedicata alla verità. Ogni settimana un autore diverso si è occupato di osservare questo concetto fondamentale dal punto di vista di una specifica disciplina: giurisprudenza, matematica, astrofisica, economia, politica, informazione, teologia. “La verità, in pratica” di Michele Silenzi è uscito il 15 luglio, “La verità alla sbarra” di Giovanni Fiandaca il 22, “Quale verità per la polis” di Flavio Felice il 29, “Ci vuole una fisica bestiale” di Marco Bersanelli il 5 agosto, “Chi è custode della verità” di Marco Li Calzi il 12, “Al mercato delle idee” di Antonio Nicita il 19.