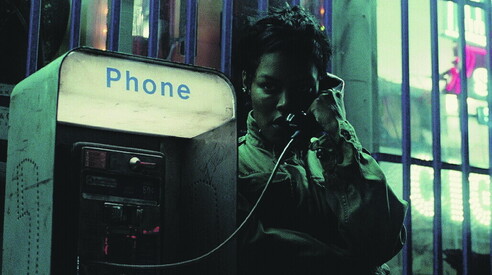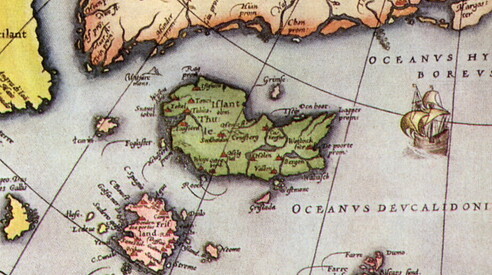Foto di Roman Kraft su Unsplash
Quid est veritas? / 6
Al mercato delle idee. L'informazione tra verità e caos
Per John Stuart Mill, la verità emerge dalla libera circolazione delle informazioni. Oggi questa libertà produce il caos. Fatti “alternativi”, infodemia e la necessità del potere politico di riposizionarsi nell’equazione
C’è qualcosa di antico, anzi di nuovo. Così potremmo iniziare un discorso su verità e politica, nei primi vent’anni di questo nuovo secolo. E’ un dibattito che è esploso dieci anni fa, suggellato dalla scelta di “post-truth” come parola dell’anno dagli Oxford Dictionaries. C’entrava molto quella che Ruth Marcus, sul Washington Post, definiva la “Post-Truth Presidency” di Donald Trump e c’entrava la propaganda populista per la Brexit. Due fenomeni che hanno picconato il rapporto tra verità e libertà nelle due patrie del pensiero liberale. Ma mentre allora molti si erano illusi che il fenomeno fosse indotto, appunto, dai campioni della propaganda populista della nuova destra nazionalista, identitaria, oggi vi è ormai la consapevolezza che quei leader e le loro parole d’ordine fossero l’epifenomeno di un mutamento più profondo, stabilizzato, prevalente, forse irreversibile. Il sintomo, più che la causa, della nuova costruzione, in questo inizio secolo, del dibattito politico in una sfera pubblica digitale globale senza moderazione e senza moderatori. La pandemia – con l’infodemia e i complottismi che l’hanno caratterizzata – ha rivelato, ancor di più, la pervasività della guerra alla verità (scientifica) nel contrasto non solo con la politica (politics) dei governi ma anche con le politiche (policy) disegnate dalle élite dei competenti, come ha ben fotografato Tom Nichols, cioè con il rifiuto dell’analisi della relazione, “evidence-based”, tra strumenti e obiettivi di policy.
E poi c’è la guerra vera, quella che, come pare abbia detto il senatore americano Hiram Johnson nel 1917, tra le prime vittime ha appunto la verità. L’episodio simbolo di questi anni è il video di Bucha: un finto fact-checking, creato dalla propaganda russa, manipola il video ucraino che mostrava i cadaveri ai bordi della strada, generando la suggestione che i cadaveri siano in realtà attori che si muovono dopo il passaggio della vettura dell’operatore video. La bugia di un fact-checker è l’inversione simbolica del nuovo relativismo. L’invenzione dei “fatti alternativi” – termine coniato da Kellyanne Conway, allora portavoce di Trump – come strumento della propaganda politica è ormai pervasiva. E certo, non è un fatto nuovo. Il saggio di Walter Lippmann, Liberty and News, di un secolo fa, sembra scritto oggi. Le pagine che Hannah Arendt dedica a “Menzogna e politica” e a “Verità e politica” sono attualissime. Come sono sorprendentemente attuali le lezioni californiane di Michel Foucault sulla “parresìa” degli antichi greci, messa a dura prova dai “kolakes”, quelli che oggi potremmo definire i neopopulisti.
Ma in questo antico, c’è qualcosa di nuovo. Ed è la compromissione, nell’ecosistema digitale, del rapporto tra libertà (d’espressione) e verità (dei fatti) sui cui abbiamo preteso di fondare le democrazie liberali. Siamo entrati in questo nuovo secolo con un vasto e antico repertorio “conclusus” in merito alla riflessione sul rapporto, da un lato, tra potere e verità, e dall’altro tra potere e libertà. Sapendo, come ci ha a lungo suggerito la Arendt, che è tipico del potere politico logorare sia la libertà che la verità e l’una in funzione dell’altra, vicendevolmente. Il punto che oggi ci impone una riflessione nuova è quello di indagare dove stia e che natura abbia il “potere politico” nel rapporto tra libertà e verità forgiato dalla sfera pubblica digitale. Detta in altri termini, nel nostro repertorio “conclusus” la libertà (d’espressione) è rappresentata da un lato come antidoto o limite al potere politico e dall’altro come strumento di selezione di quella che la Arendt chiama la “verità dei fatti”. Dunque, libertà d’espressione ed emersione della verità dei fatti agirebbero da meccanismo di disciplina del potere politico nelle democrazie liberali e non certo come strumento della sua affermazione e mantenimento fuori dal libero, e perciò mutevole, consenso democratico. Ma nella sfera pubblica digitale è ancora così? L’espansione del free speech online, con la diffusione di strategie di disinformazione e di hate speech, ha sublimato la relazione tra libertà (d’espressione) e verità (dei fatti) rafforzando le nostre democrazie liberali? Insomma, i “fatti alternativi”, le campagne d’odio social verso target di popolazione, sono – come ha sostenuto il vicepresidente Usa J. D. Vance a Monaco – il miglior esempio del buon funzionamento delle democrazie liberali o ne costituiscono, piuttosto, un’inedita minaccia?
Per rispondere a questa domanda dobbiamo tornare al saggio On Liberty dell’economista John Stuart Mill – uno dei padri del pensiero liberale – che ha forgiato, con la famosa dottrina del Giudice Oliver W. Holmes, un secolo di decisioni della Corte suprema americana sul free speech. La tesi di Mill è che verità e falsità debbono liberamente diffondersi e confrontarsi, senza limiti, se non quello di non generare un danno (sociale). Anzi, la falsità è necessaria affinché la verità possa affermarsi nel libero confronto tra opinioni e possa essere sostenuta dal consenso sociale. Dunque, se per l’apostolo Giovanni, “la verità vi farà liberi”, per John Stuart Mill è la libertà (d’espressione) a generare la verità (dei fatti). La libertà come strumento per conseguire il fine sociale della verità. Nella versione del giudice della Corte suprema Oliver W. Holmes, il primo emendamento della Costituzione americana si fonda sulla tutela del libero “mercato delle idee” per il conseguimento del bene superiore della verità, con la conseguenza che la libertà (negativa) va difesa da leggi che ne compromettano lo spazio. Questa tesi neo socratica si fonda tuttavia su alcune ipotesi che difficilmente sono verificate nell’ecosistema digitale: perfetta razionalità di chi parla e di chi ascolta nel libero mercato delle idee; assenza di distorsioni cognitive; assenza di potere di mercato nell’accesso e diffusione di informazioni; neutralità politica; disponibilità a cambiare idea. Se anche solo una di queste ipotesi non è verificata, la naturale “tendenza” del mercato delle idee verso la verità viene compromessa.
Per anni le regole sul pluralismo radio-tv si sono basate sul principio che la concorrenza dal lato dell’offerta d’informazione fosse una condizione sufficiente per tutelare il mercato delle idee. Più concorrenza, più idee in circolo, più libertà, maggiore convergenza verso la verità. Ciò che ha insegnato l’avvento del web, e soprattutto dei social, è che l’esasperazione della concorrenza dal lato dell’informazione ha generato caos informativo e la necessità, da parte degli utenti, di selezionare le informazioni. E come avviene questa selezione? Utilizzando la piena razionalità, il principio di falsificazione di Popper, o piuttosto scorciatoie mentali e distorsioni cognitive (come inerzia mentale, status quo bias, anchoring, e così via)? Selezionare le informazioni costa. E in un mondo pieno d’incertezza sulla qualità e veridicità delle informazioni, troviamo conveniente risparmiare tempo e fatica. Seguire gli altri che interagiscono con noi. Fermarci ai primi suggerimenti dei browser dei motori di ricerca. Accettare le risposte degli Llm dell’AI come ChatGPT o Perplexity. Nel caos informativo poi, ci pensa l’algoritmo a semplificarci l’accesso alle informazioni: selezionando quelle che più somigliano alle nostre preferenze rivelate dalle scelte pregresse. L’algoritmo è ruffiano e conformista. Deve stimolare la nostra attenzione verso le cose che ci interessano. Deve tenerci “ingaggiati” senza farci perdere tempo. Così nel caos informativo finiamo per ricevere passivamente informazioni che confermano la nostra pregressa visione del mondo, di come vanno le cose e di come dovrebbero andare. La selezione algoritmica digitale è il contrario dell’esercizio del dubbio: è la fabbrica delle conferme. La risposta a ogni domanda è la risposta più adatta “per noi”. E nella maggior parte dei social è predeterminata la scelta di far selezionare le “tendenze per te”: il mondo che ti interessa, raccontato per come ti interessa.
Che ne è in questo ecosistema digitale del “mercato delle idee” di John Stuart Mill se l’agorà cui partecipiamo non è quella collettiva del dibattito pubblico, ma quella ritagliata su misura per noi? Il “mercato delle idee” si trasforma così nel “mercato delle verità”, senza che vi sia alcuna naturale tendenza o convergenza verso la verità. Anzi, con strumenti di selezione che sembrano fatti apposta per far sopravvivere i fatti alternativi, isolarli da contro-argomenti, sostenerli dal conformismo di gruppo e dalle echo chamber. Verità che non riguardano solo fatti alternativi sugli eventi, ma anche fatti immaginari che riguardano persone, gruppi etnici, religiosi, identità di genere e così via. Un terreno fertilissimo per l’isolamento, le espressioni d’odio, il pregiudizio, la polarizzazione. Con un paradosso: al contrario di quanto immaginava John Stuart Mill è proprio il trionfo del free speech online, mediato dall’algoritmo dei social, ad allontanarci dalla verità dei fatti, e persino dalla curiosità verso la veridicità degli stessi. Ci sentiamo informati. Ci sentiamo confermati nelle nostre idee. Pensiamo all’ecosistema digitale come a una finestra sul mondo, quando quello che pensiamo sia il mondo è uno specchio che ci restituisce la nostra pregressa visione del mondo e la conferma. Ne consegue che proprio nel momento in cui più grande è la disinformazione che riceviamo, maggiore è la nostra sicurezza di avere finalmente ottenuto le informazioni giuste, di aver svelato complotti, di essere immersi, finalmente, nella verità. E anche nella conoscenza: si chiama effetto Dunning-Kruger il bias cognitivo per cui individui con scarsa competenza in un determinato campo tendono, grazie all’acquisizione di informazioni sul web, a sovrastimare le proprie capacità di conoscenza. Chi sa poco pensa di sapere molto.
L’equivoco tra libertà e verità nell’ecosistema digitale non è dunque semplicemente effetto del caos informativo e della selezione algoritmica. E’ il risultato del paradosso per il quale crediamo sia ampliata la nostra libertà e fortificata la nostra libertà quando ciò che avviene è esattamente il contrario. Insomma, non è solo l’errore che deve preoccupare, ma l’assenza di umiltà per riconoscerlo, di volontà per correggerlo e di strumenti per superarlo. In questa nuova sfera pubblica digitale si forma (e si conforma) l’opinione pubblica oggi. Ma dove sta il rapporto tra potere pubblico, libertà e verità? O meglio: quale tipo di potere è più congeniale a questa agorà digitale? Sia Lippmann che Arendt pongono il tema dei rischi del controllo delle tecnologie di informazione da parte del potere pubblico ovvero del monopolio dell’informazione (potere di mercato). E quindi, in quella visione, la manipolazione della verità va di pari passo con la limitazione della libertà d’espressione da parte di chi detenga il potere (politico e/o di mercato). Nell’ecosistema digitale accade il contrario: è la dinamica della libertà d’espressione, nell’intermediazione algoritmica, a realizzare la manipolazione della verità attraverso le strategie di disinformazione. Il che porta a interrogarsi sul rapporto tra potere e verità nella società digitale. Dove sta questo potere? Chi lo detiene? Quale messaggio favorisce? Come incide sulla formazione dell’opinione pubblica e sulle scelte politiche?
Per Hanna Arendt, “la libertà d’espressione diventa una farsa se l’informazione sui fatti non è garantita e se i fatti stessi vengono messi in discussione”. Non basta dunque evocare, come in Mill, il mercato delle idee affinché la libertà porti alla verità. Quella libertà, per essere autentica, deve esprimersi a partire da fatti condivisi e non “alternativi”. E’ quindi la verità dei fatti a rendere autentica la libertà d’espressione e non quest’ultima a condurre, nel libero mercato delle idee, alla verità. In questa inversione paradigmatica del rapporto tra libertà (d’espressione) e verità (dei fatti) c’è la risposta a quanti, come il vicepresidente americano Vance, criticano l’approccio Ue sulla regolazione, difficilissima, delle piattaforme online nel contrasto alle strategie di disinformazione e di hate speech a fini politici. Il diritto a informare e a informarsi non basta. Occorre difendere la libertà d’espressione anche attraverso il diritto a non essere disinformati. Che significa, ad esempio, controllo dell’uso dei propri dati ai fini della profilazione algoritmica, controllo del proprio spazio digitale algoritmico, trasparenza sulle fonti, etichettatura dei contenuti generati da IA e così via. Ma significa anche trasparenza sulla raccolta pubblicitaria e sulla promozione pubblicitaria che avviene nelle piattaforme digitali, le quali vendono spazi e misurano la propria audience, senza audit pubblici esterni. Tutelare così la libertà d’espressione dalla disinformazione non è censura, come oggi sostengono proprio quelle piattaforme che espulsero Trump dopo il 6 gennaio 2021. Al contrario, oggi la censura sta nell’inganno di un free speech online del quale non sappiamo scorgere la manipolazione solo perché ci restituisce quelle informazioni e quella visione del mondo che desideriamo siano vere. Come diceva Demostene, “nulla è più facile che illudersi. Perché ciò che un uomo desidera, crede anche che sia vero”. Ma in questa ricerca di verità desiderata, in questa illusione di libertà, rischiano di perire anche le nostre democrazie.
Antonio Nicita è economista e senatore per il Partito democratico. Con il suo articolo prosegue la serie estiva del Foglio dedicata alla verità. Ogni settimana un autore diverso si occuperà di osservare questo concetto fondamentale dal punto di vista di una specifica disciplina: giurisprudenza, matematica, astrofisica, economia, politica, informazione, teologia. “La verità, in pratica” di Michele Silenzi è uscito il 15 luglio, “La verità alla sbarra” di Giovanni Fiandaca il 22, “Quale verità per la polis” di Flavio Felice il 29, “Ci vuole una fisica bestiale” di Marco Bersanelli il 5 agosto, “Chi è custode della verità” di Marco Li Calzi il 12.