
Dentro le mura della Russia
Pietroburgo, simbolo della volontà occidentale degli zar, e Mosca, culla spirituale dell’autocrazia russa da Ivan il “Minaccioso” a Stalin. Il libro di un giovane studioso spiegava già quarant’anni fa il futuro putiniano
Il testo che segue è tratto dal capitolo, “Apofasi di due capitali” del primo libro di Mauro Martini, “Le mura del Cremlino - Radici e continuità dell’imperialismo russo-sovietico da Dostoevskij a Gorbacev. l’Europa sopravviverà?” Pubblicato nel 1987 da Reverdito editore e ora ripubblicato in formato pdf a cura del professore e collega Fernando Orlandi.
“Tutti dicono: il Cremlino, il Cremlino. Da tutti ne ho sentito parlare, ma non l’ho visto neppure una volta”. Anche il cinico e dolce ubriacone di Mosca sulla vodka (Moskva-Petuski) di Venedikt Erofeev lascia la capitale sovietica, affrontando un viaggio senza ritorno per il villaggio periferico di PetuSki, con un incubo e un rimpianto. Entrambi i sentimenti sono espressi in una lingua nuova, con un uso irriverente e radicalmente sconvolgente del russo, ma al fondo vi è una vecchia immagine. Dal 1156, da quella primitiva palizzata in legno costruita dal principe Jurij Dolgorukij per fronteggiare le incursioni tatare, il Cremlino ha rappresentato il centro di Mosca, il vero centro della vita politica e spirituale della Russia intera. Sul filo dei secoli quella cittadella (kreml’), dapprima inconsistente e poi sempre più agguerrita fino ad assumere l’aspetto minaccioso che oggi si conosce, ha seguito, adeguandovisi e condizionandolo, lo sviluppo di uno staterello, la Moscovia, da trascurabile e selvaggia entità del panorama politico europeo alla superpotenza del mondo contemporaneo. Ogni discorso, ogni esame degli elementi di un’eventuale continuità tra mondo russo e mondo sovietico deve necessariamente partire da questo territorio fortificato di sessantasei acri e dalla città che vi è stata costruita intorno.
Frequentatori della letteratura ottocentesca e dei miti rivoluzionari, gli europei di oggi hanno maggior dimestichezza con Pietroburgo-Pietrogrado-Leningrado. Si conosce questa città nei suoi più sorprendenti e multiformi aspetti. Dostoevskij l’ha raccontata come un inferno di morti viventi, dotata di una propria autonomia, capace di rovinare con il suo soffio mortifero e putrescente. Raskol’nikov vive il suo delirio lungo ponti e prospettive che gli sono ostili, in casamenti sudici e in un certo senso pre-kafkiani, in mezzo a una umanità che, se non parla, sembra quasi fare un tutt’uno con l’ammorbante cappa d’afa. Si tratta di una estremizzazione del quadro cittadino che già Gogol’ aveva offerto in una carrellata di vite sprecate, di “povera gente” più condannata che compatita, di folli megalomani capa ci di dialogare soltanto con tacite e smorfiose cagnette.
(…) Pietroburgo è una condizione in cui il tempo è sospeso: non esiste tempo storico e non esiste contemporaneità, le due dimensioni che invece assillano tragicamente la coscienza dell’intelligent russo. Può sembrare una strana coincidenza, ma Leningrado, pallida trasposizione della Pietroburgo ottocentesca, rivive un grande momento come città proprio durante il secondo conflitto mondiale, in condizione di guerra, quindi, vale a dire quando le circostanze impongono una ennesima sospensione del tempo. Pietroburgo è infine il necessario terreno di confronto per l’intelligencija del XIX secolo: proprio laddove sembrano sospesi i grandi temi che lacerano l’anima dell’intellettuale russo, lo scrittore, il poeta e il musicista possono con rinnovato vigore e con drammatica tensione porsi, da Puskin in poi, i più radicali interrogativi sul proprio rapporto con il tempo storico (la memoria) e la contemporaneità, offrendo tutte quelle soluzioni religiose o innovative (dal messianismo di Dostoevskij all’ecumenismo di Solov’èv alla musica di Stravinskij), che tanto scandalo hanno suscitato in Occidente con la prima grande emigrazione post-rivoluzionaria.
Di Pietroburgo esiste nella letteratura russa un mito, ma si tratta di un mito essenzialmente negativo con preoccupanti connotazioni di morbosità. Non vi è soltanto il fascino del mistero, che Ripellino ha descritto per la capitale boema in Praga magica: i misteri di Praga, come quelli di Parigi secondo Sue, sono in fin dei conti misteri di cui è possibile trovare una soluzione. Pietroburgo nella sua alterità non offre simili eventualità di coinvolgimento: come la Venezia di Schiller, di Cazotte e di Baron Corvo, essa permette di essere amata, ma non di essere compresa. La città di Pietro il Grande trova paradossalmente un suo ruolo nella storia russa proprio nell’esserne culturalmente esclusa, nell’esserne in qualche modo estranea. Ma è con la sua funzione di osservatorio proteso verso Occidente che essa ha permesso ai suoi intellettuali di pensare e di immaginare con maggior impegno e maggiore coerenza le sorti della Russia. Se è vero che le vicende del mondo russo, e oggi di quello sovietico, seguono un curioso procedimento dicotomico, questa schizofrenia pietroburghese ne è il primo e illuminante elemento.
In questo senso Jurij Lotman ha sottolineato in un suo saggio la condizione spaziale eccentrica di Pietroburgo da un punto di vista geografico, che trova sul piano semiotico un parallelo nel fatto che la capitale imperiale non ha un punto di vista su sé stessa e ha sempre bisogno di costituirsi uno spettatore.
(…) Non si può certo dire che Mosca abbia goduto di una analoga fortuna nel mondo dell’immaginario russo e sovietico. Nella letteratura dell’Ottocento la vecchia capitale è spesso de scritta come una città essenzialmente dedita al commercio e quindi contrapposta ad una Pietroburgo nobiliare ed impiegatizia. Il Novecento letterario si è poi dedicato ad una minuziosa e spesso compiaciuta analisi delle grandi trasformazioni subite da Mosca con l’avvento del potere sovietico e con il suo ritorno alla dignità di capitale. Ovviamente il segno è diverso: il regno, di cui la città abbandonava la guida tra il 1714 e il 1718 in favore della appena costruita Pietroburgo, era ben altra cosa rispetto all’Unione Sovietica e al suo ruolo nel mondo. Molte sono le spiegazioni che si possono dare della scelta bolscevica di riportare nel 1918 la capitale a Mosca. Vi si può certo vedere un segno della volontà di rottura con il mondo zarista, ma è difficile non cedere ad alcune suggestioni.
In fin dei conti San Pietroburgo era nata e si era sviluppata sul progetto di rappresentare una finestra sull’Occidente. Un luogo comune, certo, ma, per dimostrare la forza di questo luogo comune nella coscienza politica del XVIII secolo, Pietro il Grande non esitò a intraprendere una guerra costosa e defatigante, la “grande guerra del Nord” contro gli svedesi, durata ventuno anni. Fu la battaglia di Pollava del 1709 a garantire la stessa sopravvivenza statale della Russia; non solo: tale battaglia impose, come è noto, la presenza russa sullo scacchiere diplomatico europeo in maniera stabile, coronando così il sogno che era stato di Ivan IV il Terribile. Pietroburgo quindi rappresentò per quasi due secoli il simbolo della volontà occidentale della Russia zarista. Dopo la caduta dei Romanov, l’effimera Pietrogrado fu protagonista del tentativo politico di dare al paese un ordinamento democratico-occidentale. Si trattava alla fin fine di un’eredità pesante per i bolscevichi: il partito comunista non poteva per mettersi di restare condizionato, sia pur solo simbolicamente, da una simile scelta per l’Occidente. Si preferì quindi optare per Mosca come luogo del nuovo internazionalismo di classe; il progetto dichiarato era di farne una città radicalmente nuova alla guida di un enorme sforzo politico di tipo nuovo.
Val la pena di osservare come, col passare dei decenni, il valore simbolico del Cremlino sia stato a conti fatti molto più condizionante del rifuggito pericolo pietroburghese. D’altro canto lo stesso internazionalismo, che alla lettera dei documenti risulta essere una efficace ed affascinante utopia, non a caso trascinata lessicalmente fino ad oggi, si incrociava per molti versi con la tradizione imperiale russa e con le grandi direttive dello spirito politico, che alla Russia stessa avevano dato vita. Furono certo le contingenze storiche che determinarono il centrale interesse dell’Internazionale Comunista nel suo breve periodo di vita verso le questioni asiatiche ed europee. Il sovvertimento dei regimi borghesi in Europa era visto come un problema da risolvere al più presto per garantire la sopravvivenza dell’Unione Sovietica stessa. L’Asia nel suo complesso dimostrava una maggior dinamicità e quindi si rivelava come il punto più debole dell’imperialismo. Ma come non notare le coincidenze di queste tendenze con quegli stessi temi che avevano fatto della Russia un impero eurasiatico, conflittualmente rivolto verso il suo occidente, ma sempre attento ad accrescere la penetrazione in Oriente alla ricerca di quello spazio che culturalmente e strategicamente è il suo fondamento? D’altronde i nuovi leaders bolscevichi e i primi delegati ai congressi dell’Internazionale Comunista non avrebbero dovuto fare molta strada per intuire questo dato. Subito fuori dal Cremlino ad una estremità della sua appendice epifanica, la Piazza Rossa, sorgeva, e tuttora sorge, la cattedrale di San Basilio, che architettonicamente ha l’arduo ma esaltante compito di spezza re l’orizzonte della piazza medesima, che altrimenti abbaglierebbe per la sua estensione. La Piazza Rossa infatti ha il curioso ruolo di unire visivamente la grandezza quasi sterminata con il senso di raccoglimento: un’altra costante dello spirito russo, che si è trasferita pari pari in quello sovietico. La cattedrale di San Basilio è una costruzione enigmatica ed affascinante: sovrappone infatti le caratteristiche cupole della tradizione ortodossa a mura che ricordano nell’uso del colore e nel provocatorio succedersi delle decorazioni la tradizione orientale e musulmana in particolare. Tale cattedrale è il segno tangibile della vocazione eurasiatica della Russia e non a caso è stata costruita e voluta dallo zar Ivan IV, un personaggio cui conviene tornare per capire alcuni elementi da tenere ben presenti.
Si è celebrato nel 1984 il quattrocentesimo anniversario del la morte di questo zar detto Groznyj, aggettivo russo che nel mondo occidentale sarebbe stato ben presto tradotto con “Terribile”. Molti in Unione Sovietica e fuori si sono impegnati a spiegare l’importanza dell’opera storica di un personaggio che da secoli popola più i mondi dell’immaginario che quelli del politico. E ovviamente le prospettive sono state ben diverse, a seconda che se ne sia parlato in Urss o in Occidente. Non sono mancate per l’occasione le rievocazioni tra lo sbigottito ed il compiaciuto delle ormai celebri nefandezze di uno zar, che esordì in gioventù con sevizie agli animali e proseguì poi nel coerente segno di uno scarso rispetto per la vita umana, impegnandosi in sostanziosi massacri fino ad arrivare all’uccisione del suo stesso figlio. (…)
Con tutti i rischi che tali operazioni comportano, è il caso di leggere Ivan IV con gli occhi dell’attualità, del vissuto contemporaneo, al semplice scopo di capire come in realtà il problema Russia nasca proprio nel lontano XVI secolo e come i termini di tale problema si siano da allora complicati, ma non modificati. Infatti è proprio a partire dal Terribile che la Russia, rafforzatasi intorno alla città di Mosca, acquista il suo carattere di impero eurasiatico con la disfatta dei principati tatari di Kazan’ e di Astrachan e con la spinta impressa alla colonizzazione della Siberia, che rimarrà una del le direttive della politica russa prima e dopo il 1917. Con Ivan il Terribile la Russia acquista una sua fisionomia politico-territoriale anomala rispetto all’Europa e su cui l’Europa non mancherà di riflettere. (…) Ivan il Terribile spiega molto anche dell’atteggiamento generalmente politico dell’Unione sovietica di oggi. L’aggettivo groznyj, che gli fu attribuito suscitando controversie nella traduzione in altre lingue, deriva dalla parola russa groza, ossia minaccia. (…) La groza è attributo essenziale del regno, in caso contrario questo si riduce ad essere un “cavallo senza briglie”. Fin qui nulla di nuovo: l’originalità sta nel fatto che (…) non si riferisce a un regno qualsiasi, ma a quella particolare variante nota come autocrazia (samoderzavie), che viene presentata come la forma ottimale. Proprio in quegli anni Ivan IV veniva realizzando in concreto l’autocrazia, eliminando fisicamente gli antichi principi di corte, i boiari, e autofondando il proprio potere sulla legittimità divina. In tal modo egli spezzò definitivamente la diarchia che stava alla base delle nascenti monarchie in Europa, e delineò il modello russo, che da allora rappresentò la pietra di scandalo della coscienza europea. L’idea che sosteneva tale modello consisteva nel considerare le eresie e le deviazioni, religiose o politiche che fossero, come colpe senz’altro più gravi dei massacri e delle torture compiute per combatterle. Ognuno può valutare quanto di tale idea sia filtrato attraverso l’ideologia del marxismo-leninismo nell’attuale sistema sovietico. Resta il fatto che ancora oggi l’Urss si propone come un rigoroso connubio tra “autocrazia” e “minaccia”. (…) In fin dei conti anche il sistema della dissuasione reciproca tra le superpotenze in materia di armamenti nucleari non è che una esasperazione della groza originaria: moltiplicare la minaccia serve anche a non svuotarla di ogni potenzialità, costringe a pensarvi continuamente. (…) Ivan il Terribile, come si è visto per la cattedrale di San Basilio, ebbe la straordinaria fortuna o capacità di rendere chiara anche visualmente la fondazione da lui data alla politica russa. Durante il suo regno il Cremlino dovette essere integralmente ricostruito. I palazzi, che nel 1472 avevano visto l’arrivo della principessa di Bisanzio Zoe (Sofia) Paleologa per il suo matrimonio con il granduca Ivan III, furono distrutti da uno spaventoso incendio che nel 1547 costò a Mosca la distruzione di venticinquemila case e la morte di almeno diciassettemila perso ne. L’avvenimento costrinse Ivan IV ad un precipitoso ritorno da Pskov, dove stava sedando con metodi di una ferocia inusitata una rivolta della popolazione, e pose in crisi lo stesso gover no dello zar, minacciato da una sollevazione dei moscoviti alla ricerca di un capro espiatorio. La situazione venne in qualche modo tenuta sotto controllo e la crisi fu superata, ma interessante è il modo con cui Ivan riuscì a recuperare un prestigio minato. Per far fronte alla rabbia popolare il Terribile inventò l’uso strumentalmente epifanico della Piazza Bella (l’aggettivo krasnaja significa al tempo stesso “bella” e “rossa”, il che ha permesso una certa ambivalenza nelle traduzioni): tale piazza era stata nei secoli precedenti il terreno privilegiato degli scontri con i tatari, che minacciavano la cittadella; una volta finito l’incubo della dominazione straniera, essa si era trasformata con l’inizio del XVI secolo in un luogo di mercato, centro di raccolta di tutti gli sfaccendati della città e, di tanto in tanto, sede di lettura dei proclami ufficiali. Ivan IV ne rivoluzionò l’utilizzazione: vi convocò infatti a distanza di qualche anno due grandi assemblee popolari, una prima, subito dopo l’incendio, e una seconda, nel 1549, allo scopo di esporre pubblica mente il suo programma di regno. Ovviamente non si rivolse ai moscoviti nei crudi termini con cui Peresvetov ha tramandato tale programma, ma tentò con discreto successo di dar corpo all’immagine dello zar come protettore del popolo in nome dell’amore cristiano e contro lo sfruttamento da parte dei boiari. Il successo lo si può misurare, ricordando come la figura dello zar “piccolo padre” ingannato dai nobili si sia proiettata e rafforzata nei secoli fino alla domenica “di sangue” del 1905. L’analogia è facile, ma è impossibile non andare con il pensiero alle rituali parate celebrative dell’Urss di oggi. Il potere sovietico ha sviluppato al massimo questo uso epifanico della Piazza Rossa: la tribuna sul mausoleo è stata spesso in passato una delle rare occasioni per vedere il segretario generale del Pcus in carne e ossa. Si pensi poi all’ostensione esasperata del proprio breve passato con la salma di Lenin nel mausoleo e le tombe dei dirigenti e delle personalità lungo le mura del Cremlino. (…) Dal XVI secolo, quindi, il Cremlino moscovita e la Piazza Rossa rappresentano un indissolubile binomio nella storia della Russia. Non si deve pensare che il periodo di Pietroburgo capi tale abbia in qualche modo snaturato il ruolo della cittadella di Mosca. Il trasferimento del potere politico e dell’amministrazione sulle rive del Baltico denotò piuttosto il centro moscovita in senso ancor più religioso, il che in condizione di autocrazia significava pur sempre riconoscere che la fonte originaria del potere in Russia risiedeva tra le mura del Cremlino. Molti zar continuarono a farvisi incoronare, tra essi anche l’ultimo, Nicola II, e altrettanti vi si fecero seppellire. (…) E’ difficile quindi capire come il potere bolscevico abbia potuto nel turbine del 1918 immaginare di riuscire facilmente ad evitare il forte condizionamento simbolico del complesso architettonico scelto come sede del nuovo governo. Tanto più che nel giro di pochi anni prevalse la tendenza a dare un’immagine del partito comunista come legittimo erede dei sovrani del Cremlino. Speciali commissioni miste furono incaricate di re staurare le chiese, danneggiate nel corso della rivoluzione, e durante i lavori molte delle sovrapposizioni stilistiche del seco lo precedente vennero eliminate nel tentativo di riavvicinare quanto più possibile gli edifici al loro primitivo aspetto medie vale. E fu con Stalin che i vecchi palazzi riassunsero appieno il ruolo di “segreto” che era stato loro proprio nei secoli prece denti, soprattutto durante i “tempi torbidi” del XVII secolo. Il supremo vertice politico della Russia, che ancora una volta si identificava con una singola persona dotata di potere pressoché illimitato, torna a nascondersi dietro le “porte regali” del Cremlino. … È sorprendente come da questo punto di vista del rito il politico e il religioso coincidano nella tradizione russa. Questo dato potrebbe sembrare ovvio in quanto riferito ad un sistema in cui le due autorità coincidono ed una è soltanto formalmente l’origine dell’altra: l’autocrazia, come si è visto, in ultima analisi autofonda sé stessa sul principio divino.
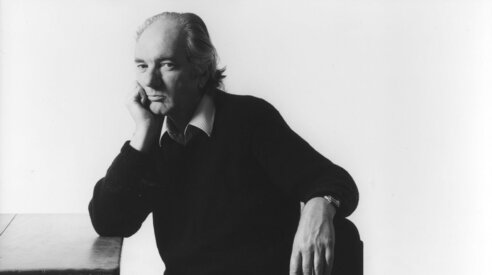
Racconto profetico
Thomas Bernhard, il nostro presente e il suicidio come una delle belle arti


Comici di lotta e di governo


