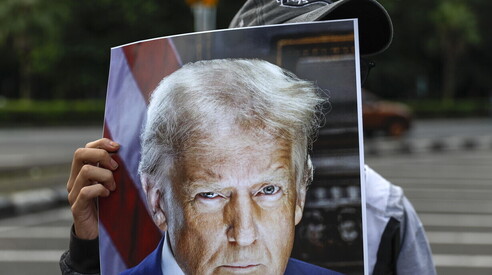Ernst Jünger (foto Getty)
In libreria
L'ultimo poeta-soldato, che voleva trasferire in politica lo spirito della guerra
Dalla questione della tecnica all’idea dell’unità. Gabriele Guerra scrive un saggio ben documentato su Jünger, chiedendosi che tipo di lezione trarre da un’esperienza bellica “indicibile e irrappresentabile”
Un’inondazione, una slavina, un’epidemia: quando iniziano, è difficile fermarle. Lo stesso vale per la guerra. Lo spirito della mobilitazione tende a sopravvivere alla pace. E’ quanto accadde in Europa nel 1918, soprattutto in Germania: che fare, dopo l’armistizio, degli ordini, l’ubbidienza, il coraggio, il sangue versato? I movimenti nazionalrivoluzionari, che nella Repubblica di Weimar spuntavano come funghi, volevano trasferire nella vita politica lo spirito del conflitto. Tra gli scrittori impegnati in questa direzione c’era Ernst Jünger, eroe delle trincee (con Rommel e von Richthofen, uno degli ufficiali insigniti della croce Pour le mérite, una sorta di supermedaglia d’oro), autore di Nelle tempeste d’acciaio, diario che riflette sulla mutazione antropologica innescata dalla nuova “battaglia dei materiali”. La guerra aveva frustrato le aspirazioni romantiche dei volontari partiti tra fanfare e fiori, rivelandosi una macchina colossale la cui organizzazione e funzionamento sfuggivano ai combattenti. Il valore e l’audacia degli individui non contavano più nulla davanti alla potenza della tecnica. La democrazia delle mitragliatrici inglesi non fece differenza tra gli zulu del Sudafrica e i soldati tedeschi che a Langemark partivano all’assalto con nel tascapane lo Zarathustra di Nietzsche. Fu un’epifania orribile.
Come chiede Gabriele Guerra nel documentatissimo Ernst Jünger. Una biografia letteraria e politica (Carocci, 2025): che lezione trarre da un’esperienza bellica “indicibile e irrappresentabile”? Nella sua opera teorica maggiore, L’operaio pubblicato nel 1932, Jünger immagina una forma d’esistenza che fonde insieme soldato e lavoratore. Il frangente imponeva l’invenzione di un tipo umano che, andando oltre la pianificazione leniniana, dà senso all’insensato meccanismo della modernità avanzata. La questione della tecnica è troppo importante per essere abbandonata ai tecnici. Devono appropriarsene gli outsider, letterati e filosofi, “uomini che siedono solitari in notturne camere, immobili come rocce dalle cui cavità erompe in scintille la corrente che, fuori, mantiene in moto l’esercizio delle macchine”.
Dopo il 1945, Jünger, che morirà quasi centrotreenne nel 1998, cercò rifugio dentro una dimensione mitologica ed esoterizzante. In questo modo, nota Guerra, l’angoscia storica trovava una prevedibile consolazione metafisica. Ma almeno fino all’ascesa del nazionalsocialismo, non fu così accomodante, né con se stesso né con gli altri. L’ultimo poeta-soldato di Germania e Europa attraversò di slancio un paesaggio di ferro e fuoco, non per lasciarsi frastornare dal disordine apparente, ma “per avere un’idea dell’unità: il negativo segreto e immobile del mondo che gira senza requie”. Con risultati alterni, Jünger fu per tutta la vita alla ricerca di uno spazio e un tempo non tecnici nel cuore stesso della tecnica e delle sue manifestazioni più annichilenti. La strada che ha inaugurato è ancora aperta, una delle poche all’altezza del nostro tempo.