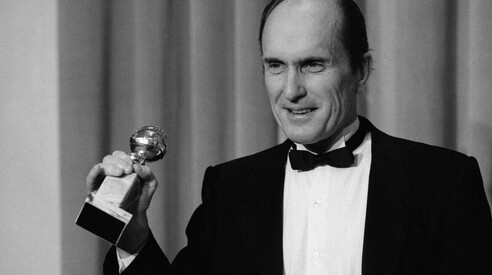l'editoriale dell'elefantino
“No Other Land”: un film che addolora, senza separare fino in fondo torti e ragioni
Pathos contro logos. Il sentimentalismo malinconico di “No Other Land” spazza via l’indignazione ideologica e le menzogne post 7 ottobre, ma cancella pure la potenziale barbarica violenza da parte palestinese che si è manifestata nel terrorismo e nei pogrom antigiudaici
Il sentimentalismo malinconico del film di Basel Adra e Yuval Abraham, i due ventenni, un palestinese e un israeliano, all’origine del film documentario “No Other Land”, premio Oscar andato in onda su Raitre sabato sera, spazza via l’indignazione ideologica e la menzogna delle campagne propagandistiche messe in piedi dopo il pogrom del 7 ottobre e nei due anni della guerra di Gaza. Si capisce che i gruppi di boicottaggio antisraeliani abbiano avuto in uggia quel racconto lancinante della distruzione militare lunga, graduale, programmata delle comunità palestinesi in Cisgiordania, il suo tono elegiaco, il suo tessuto morale di lamentazioni, di amicizia, di speranza e di avvilito dolore. Il pathos è quello dell’occupazione di terre che non ti appartengono, ma sulle quali hai il comando dopo una guerra vinta, il dominio della forza, l’ingiustizia delle ruspe che radono al suolo case, pollai, cessi, scuole, pozzi, ovili, vita economica e civile di un popolo di pastori, di piccoli benzinai, con le donne, i bambini, i vecchi, gli ammalati, tutti messi con la violenza legalizzata e le molestie popolari dei coloni in condizioni di vita insostenibili, tutti colpiti da discriminazione e indifferenza, tutti infine costretti a smantellare la loro origine, il loro attaccamento al suolo, e a emigrare altrove.
La campagna su Gaza ha cercato di convertire la tragedia comune di popoli in guerra in giudizio morale assoluto, in condanna etica di Israele e degli ebrei, tutti gli ebrei, e in un discorso o logos resistenziale che assolveva e promuoveva i valori dell’aggressione omicida e del programma sterminazionista di Hamas e di quella parte del popolo che l’ha seguita e applaudita. I due ventenni che, telefonini e videocamere alla mano, hanno filmato, montato e sceneggiato con cura, amore e sapienza, il disastro del conflitto originario, del piano di deportazione e annichilimento della comunità di Masafer Yatta, hanno fatto un’altra operazione: vedere, testimoniare, offrire le lacrime delle cose risparmiandoci le loro, e dunque duramene protestare, opporsi, ma senza abbracciare le retoriche dell’odio mascherate da umanitarismo. Yuval Abraham, l’ebreo israeliano che non tollera le conseguenze dell’occupazione, l’amico di Basel e della sua famiglia pacifica e sorniona, allegra nella tristezza infinita malgrado tutto, potrebbe con lo stesso grado di sincero patetismo infiltrare il buono e il bello della sua amicizia in una colonia di settlers, in un battaglione dell’esercito chiamato alla distruzione e all’autodifesa spietata, dando conto delle ragioni degli oppressori nella forma malinconica e sentimentale del suo racconto dalla parte dei vinti. Ne sono persuaso. Non lo farebbe mai, perché la sua è una milizia per la convivenza e contro la discriminazione degli occupanti e le molestie violente dei coloni, ma il suo linguaggio, e quello di Basel, il suo amico palestinese vittima dello sradicamento, si presterebbe alla perfezione, malinconica disperazione e tutto, forse con gli stessi risultati letterari hollywoodiani, alla narrazione del tremore e terrore dei vincitori provvisori, di coloro che nella società israeliana sono o si ritengono costretti a difendersi con l’attacco più spietato ai vicini di casa o di baracca, ai poveri e derelitti dietro l’angolo dei wadi e del deserto.
Il sentimentalismo che denuncia e si batte contro l’ingiustizia che si vede non esclude l’indagine pietosa sulle origini apparentemente invisibili dell’ingiustizia, sul sionismo e la religiosità biblica nel rapporto patologico con Giudea e Samaria, dopo che la guerra d’aggressione dei sei giorni consegnò quelle regioni allo stato degli ebrei assediato, come una benedizione e come una maledizione. I palestinesi che rappresenta liricamente il film “No Other Land” sono quelli che non hanno mai avuto una classe dirigente pacifica e negoziale, capace di contrattare un piano regolatore al posto delle ruspe, capace di dare esito all’ansia di stabilità e di pace di due popoli, forse in due stati confinanti; sono le vittime della discriminazione tra targhe verdi e targhe gialle, quelli che non possono muoversi, che studiano giurisprudenza ma possono al massimo emigrare in un paese ostile per fare i muratori, sono i compagni di giochi e di affetti di bambini e donne e vecchi consegnati alla paura, al pianto, alla derelizione dell’occupazione militare di decenni e decenni. La potenziale barbarica violenza della loro parte, che si è manifestata con gli effetti disastrosi che si conoscono, nelle Intifada e nel terrorismo e nei pogrom antigiudaici, è cancellata dal sentimentalismo malinconico, che li riscatta, li porta per mano alla fonte della bontà e della collaborazione con gli israeliani pacifisti e fautori della convivenza. Il racconto in questa chiave è irreprensibile, fa pensare e addolora, ma non spiega, pathos contro logos, non spartisce come succede lungo un confine e un muro torti e ragioni.