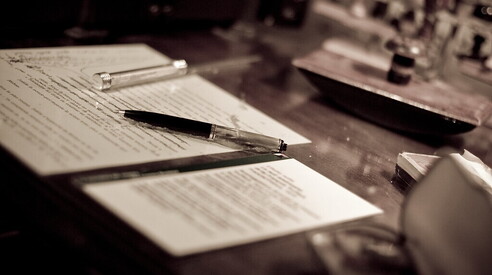dal film "Porzus" (1997)
Uffa!
Raccontare Porzûs, dopo un lunghissimo silenzio
L'episodio prende il nome dalla località friulana dove un gruzzolo di partigiani italiani filojugoslavi, guidati dal comunista Mario Toffanin, massacrarono 17 partigiani italiani di area liberale. Leggere il libro di Gabriele Ranzato per far cadere ogni illusione sull'"unanimità" del movimento partigiano
Ci sono documenti nudi e crudi nell’attestare che tra il 1944 e il 1945 il Pci togliattiano fosse più che propenso ad accettare che Trieste e dintorni, una volta cacciati i tedeschi occupanti e i loro compari fascisti, finissero sotto il dominio dei comunisti jugoslavi guidati dal maresciallo Tito, i quali sarebbero stati “i creatori della nuova democrazia”. Da queste sciagurate valutazioni delle forze in campo venne la tragedia di Porzûs del 7/18 febbraio 1945, dal nome della località friulana dove un gruzzolo di partigiani italiani filojugoslavi capeggiati dall’ipercomunista Mario Toffanin detto “Giacca” massacrarono 17 partigiani italiani di ceppo liberale fra cui una donna e il capitano Francesco De Gregori (zio del cantautore). E’ un episodio su cui in Italia è durato a lungo il silenzio, almeno fino al film di Renzo Martinelli del 1997 che ha per titolo “Porzûs". Quell’avvenimento funge da cuore di un libro uscito un anno fa (Gabriele Ranzato, Eroi pericolosi, Laterza) di cui ha scritto benissimo Ernesto Galli della Loggia in un recente articolo apparso sul Corriere della Sera.
Un materiale talmente incandescente che vale la pena riprendere in mano e soppesarlo. I termini Resistenza, Liberazione e simili sono difatti usati e strausati, a costo di risultare piatti se non opachi. Nel libro di Ranzato quegli anni sono invece pettinati con cura, scavati alle radici, messe in risalto tutte le sfumature delle idee e dei personaggi in campo e sono tantissime. Ci sono le formazioni partigiane ciascuna con un suo colore e identità politica, ci sono gli Alleati che avanzano seppure lentamente, ci sono i furibondi rastrellamenti tedeschi, ci sono le domande su quel che ne sarà politicamente dell’Italia una volta che i tedeschi cederanno il campo. Ranzato ti spiega e ti racconta come andarono esattamente le cose, la ferocia e la follia di quel tempo in cui gli italiani si scannarono tra loro, quanto siano stati complessi i rapporti politici tra i partiti nell’Italia che non era più fascista ma di cui non si sapeva che cosa sarebbe diventata. Ivi compresa la possibilità che una parte del suo territorio venisse assorbita dal comunismo titino. Ed era un tempo in cui l’essere comunisti implicava l’adorazione di Stalin, anche se il maresciallo Tito sarebbe stato tra i primissimi comunisti di rilievo a sottrarsi a quell’adorazione.
Il libro di Ranzato va ben oltre il racconto di quell’episodio da cui sono partito. Accuratissimo è il suo resoconto dei contrasti all’interno dello schieramento partigiano, a cominciare dal fatto di dire sì o no agli attentati a uomo, in cui uccidevi un fascista in cui ti eri imbattuto per caso per poi sopportare una rappresaglia in cui partigiani e civili italiani venivano trucidati a centinaia. Era stato il caso dell’agguato a Roma di via Rasella, l’uccisione di 33 uomini che indossavano la divisa tedesca e che costò una rappresaglia nazi in cui alle cave Ardeatine vennero uccisi uno dopo l’altro 335 italiani. E questo è solo un caso fra i tanti.
A dettare il massacro di Porzûs fu il Comando sloveno del IX Corpus. Toffanin lo mise in atto. Dietro specifica indicazione dell’allora commissario politico della formazione comunista “Garibaldi Natisone”, ossia Giovanni Padoan, che un tribunale italiano condannerà a trent’anni di reclusione. Padoan ne addossò più tardi la colpa ai dirigenti della federazione del Pci di Udine e lui stesso lo definirà “un crimine di guerra che esclude ogni giustificazione” nel momento in cui riconoscerà in pieno le sue responsabilità politiche e morali. Lo stesso “Giacca” venne condannato pesantemente salvo poi essere graziato dopo alcuni anni dal presidente Sandro Pertini.
Non è vero niente che il movimento partigiano fu unanime nelle sue azioni e nei suoi convincimenti. Il dissidio fra le varie formazioni politiche fu continuo e insistente. C’erano i più settari fra i partigiani e c’era uno come il comandante “Ciro” Moscatelli il quale si vantava di non aver mai salutato nessuno con il pugno chiuso e che era rimasto sbalordito quando un sacerdote lo salutò col pugno chiuso. Serrato fu il contrasto fra quelli che propugnavano comunque l’agguato al singolo milite fascista o tedesco e quelli invece che volevano evitare le micidiali rappresaglie che non risparmiavano nessuno. A chiedere la qualifica di “partigiano combattente” alla fine della guerra furono circa in 600 mila. Per averla bisognava avere partecipato ad almeno tre azioni di fuoco. La ottennero in 254 mila oltre che 62 mila caduti e 33 mila mutilati.