
Terrazzo
Ai Parioli con Goliarda Sapienza
Gita estiva sui luoghi e le architetture di "Fuori" insieme al regista Mario Martone (in Smart)
"Fuori”, l’ultimo film di Mario Martone, è la storia di Goliarda Sapienza, interpretata da Valeria Golino, delle sue scorribande dentro e fuori il carcere di Rebibbia, ma è anche una grande ricognizione della Roma estiva “che si dilata, che diventa un’altra città”, dice il regista al Foglio. Lo incontro all’arena di Piazza Vittorio, in questa strana estate romana piena di gente in città (la città che diventa uno stabilimento balneare) e dunque solo posti in piedi per la proiezione del suo bel film.
Anche Martone abita qui, ma du côté del Colle Oppio, “quelli che un altro amato residente, Goffredo Fofi, chiamava ‘i Parioli dell’Esquilino’. E prima ancora a Monti. La mia prima casa me la dettero in affitto solo per un anno. Non aveva riscaldamenti ma era stupenda. Passavano Paolo Virzì appena arrivato da Livorno, Iaia Forte, la mia fidanzata di allora Anna Bonaiuto. Quando me ne dovetti andare ero talmente disperato che mi attaccai a una bottiglia di whisky, mi ubriacai così tanto il giorno dello sfratto che i traslocatori mi passavano davanti, guardandomi e scuotendo la testa, tipo ‘anvedi questo’. Una parentesi fuori città, a Campagnano di Roma, poi di nuovo in centro”. Reincontro Martone il giorno dopo, e mi parla appunto dei Parioli, che compaiono molto nel film, e mi dice: ma perché non li andiamo a vedere, scusi? Partiamo dunque per un imprevisto viaggio tra palazzine e strade lì deserte, solo qualche badante solitaria tra gli oleandri, di una città che d’estate cambia faccia.
La Roma che sta in “Fuori” è una Roma quasi filologica, “non abbiamo cambiato quasi niente, del resto cerco sempre di non modificare i luoghi, se possibile. Perché basta guardare meglio e si trovano posti impensati”, dice il regista. Come una stazione Termini che tutti pensano ricostruita in digitale, invece vera, verissima, con degli arredi in legno originali, ed è “una parte dell’edificio che dà su via Marsala” dice Martone, coadiuvato nel film dallo scenografo Carmine Guarino. Passiamo davanti alle ricostruzioni giubilari, coi banchi dei bouquiniste di piazza dei Cinquecento rifatti. La stazione immaginaria ma vera si vede anche nel bar-caffetteria Dagnino, storico bar surreale dalle parti di piazza della Repubblica, dove pare che il tempo si sia fermato, in una galleria che potresti essere a Torino o a Napoli ma non certo a Roma. Lì, Golino e Matilda De Angelis, che interpreta la sua amica Roberta, fanno una litigata che si conclude con un bacio. Fendiamo il traffico slabbrato di Ferragosto con la Smart di Martone – ma non avrei mai pensato che lei Martone avesse una Smart. “E come si fa senza?”.
Diamo la caccia alle palazzine e ai villini che cominciano a spuntare da via Piemonte e dal Pinciano, raggiungiamo via Aldrovandi. Al leggendario omonimo residence, dove visse gli ultimi anni Dino Risi, “abbiamo abitato durante le riprese, perché in casa nostra c’erano lavori in corso. E dal tetto del residence c’è anche una lunga panoramica all’alba sulle protagoniste che girano con una macchina rubata. Non facile, alla ricerca del momento perfetto, alle quattro e mezza del mattino”. Dino Risi porta naturalmente al “Sorpasso”, il più grande film che sia stato fatto sulla Roma estiva, “e anche ‘Fuori’ vuole essere un piccolo road movie sulla Roma del 1980”. Girato l’estate scorsa, perché “a girare d’estate c’è questa rarefazione”, dice Martone, e “girare” sembra valere sia per un film che per una gita come quella che stiamo facendo adesso. Giriamo ancora, dunque, per i Parioli, “un quartiere che non conoscevo per niente prima del film”, eppure ne realizza quasi un monumento e pellegrinaggio, c’è pure il “buco di San Filippo”, cioè il pertugio segreto che porta dentro Villa Ada, rito misterico del più puro pariolismo.
Passiamo davanti a qualche abitante dall’aria sospettosa e non cinéphile, chi saranno mai questi due tizi in Smart che si sbracciano indicando palazzine e villini? Gli mostro quella che secondo me è la palazzina più bella di Roma, sede dell’ambasciata di Monaco presso la Santa Sede, opera di Ugo Luccichenti. “E’ vero, guardi le finestre, è una questione di ritmo, di musica, nell’alternarsi degli infissi”. Passiamo davanti al Cannocchiale, villino costruito nel ’36 da Giovan Battista Bianchini in via Barnaba Oriani 103, con la caratteristica facciata a due cilindri, che compare come una fortezza nella fotografia polverosa-vintage del film (per chi disponesse di un milione e seicentomila euro c’è lì in vendita un bellissimo appartamento). E poi ci fermiamo a piazza Euclide, dove si svolgono molte scene. Nella fermata del treno metropolitano Roma-Viterbo, “anche lì, ci hanno chiesto come abbiamo ricostruito, ma non abbiamo ricostruito nulla”, e infatti, posteggiata la Smart in doppia fila, scendiamo nella stazioncina (curiosa, perché forse l’unica a Roma non monumentale-moderna ma nascosta in un palazzo, tipo quella della linea verde Lanza a Milano). E lì, cartelli puri anni Sessanta, ma bisogna far presto, perché c’è un cantiere del Giubileo e stanno per scassare, cioè rimodernare, tutto. Perché fino a qualche tempo fa soprattutto le metropolitane a Roma erano una pacchia per chi voleva girare un “period”, un film in costume, non essendo mai state cambiate da cinquant’anni, probabilmente neanche fatta la manutenzione, anche con macchie originali d’umidità. Sotto un portico, accanto al cantiere, sono stati, questi sì, ricostruiti, i due bar, l’Euclide (“che esiste veramente, ma quando dovevamo girare noi era chiuso”); e quello della metropolitana dove Valeria-Goliarda dà appuntamento all’amica Matilda-Roberta.
Talvolta indicando la chiesa davanti, “va che brutta”. La chiesa del Sacro Cuore Immacolato di Maria lì, senza cupola, è uno dei tanti incompiuti di Armando Brasini, l’Albert Speer italiano, l’architetto barocchetto che voleva essere il preferito del Duce ma non ci riuscì mai (la chiesa non si finì perché erano finiti invece i soldi, e la madre superiora si suicidò). Di Brasini anche il ponte Flaminio che compare nel film. Martone, lei ha sempre avuto la passione per l’architettura? “Sempre, anche se non l’ho mai davvero studiata. Ma il cinema è stato un modo per farlo. Già dai miei primi film e lavori teatrali e lirici lo spazio è stato fondamentale. ‘Morte di un matematico napoletano’, il mio primo lungometraggio, era anche quella una ricognizione estiva di una città, però Napoli”. Martone accosta la macchina, fa foto, ci fermiamo a guardare palazzine di Bauhaus marinaro, che sembrano Tel Aviv. E scale. “Ci sono molte scale ai Parioli”.
Raggiungiamo finalmente la casa dove viveva davvero Goliarda Sapienza, in via Denza, sopra un concessionario di macchine. “Arredata da lei, piccola, piena di libri, e con una balconata che si slancia sui pini di Villa Glori”, dice Martone. “Volevo girare qui perché questa casa era molto importante per lei. La prima volta che si vede, all’inizio del film, quando prende il caffè e guarda la pineta davanti, c’è il rumore del mare, come nel suo romanzo. Questa pineta per lei era come il mare”. Entriamo nel palazzo-nave anni Cinquanta, con l’androne di mattoni bicolori. Progetto di un altro Luccichenti, Amedeo, 1957. C’è il portiere: “Come state dottò?”, ma il marito di Goliarda, l’attore Angelo Pellegrino, è via, e noi visitatori agostani ce ne andiamo. La casa si vede anche in “Lettera aperta a un giornale della sera”, il film di Citto Maselli che qui stava con Goliarda, ricorda Martone. Sempre a questa casa ha dedicato il suo spettacolo teatrale “Il filo di mezzogiorno” basato sull’omonimo libro della Sapienza e adattato da Ippolita Di Majo, che è anche sceneggiatrice di “Fuori” e moglie del regista. “Il titolo si riferisce alle sedute di psicanalisi che Goliarda riceveva, ogni giorno, a domicilio”. Grande privilegio, in un quartiere tra l’altro di studi di strizzacervelli. “La terapia andò in modo rocambolesco, alla maniera di Goliarda”.
“Nello spettacolo teatrale la casa non era fissa, si muoveva, per rappresentare la scrittura di Goliarda, che è magmatica, procede per spostamenti anche bruschi”, dice Martone. Nel film si muove anche un altro ambiente non pariolino, la profumeria di Elodie-Barbara, compagna di carcere di Goliarda, che apre un negozio in via dell’Acqua Bullicante, simmetrico geografico e antropologico dei Parioli. Anche in periferia siete stati filologici? “Be’, nel libro sono indicati una via e un civico, mi è sembrato logico cominciare da lì per gli esterni. Poi però il civico non esisteva, e allora abbiamo guardato lì vicino. Gli interni invece li abbiamo girati in studio, e anche quelli si muovono”. Anche noi però adesso ci dobbiamo muovere, è ora di tornare; passiamo davanti al tristo teatro dell’Opera piacentiniano: che differenza c’è tra cinema e teatro per quanto riguarda l’architettura? “E’ un po’ lo stesso. Io sono attratto dalle geometrie, e dai dettagli. Parto sempre dallo spazio. A volte firmo anche le scenografie, altre no. Però l’idea dello spazio devo averla io, altrimenti la regia no, non riesco proprio a farla”. Intanto con la Smart continuiamo la navigazione nella Roma estiva, tra i bagnanti-abitanti rimasti.


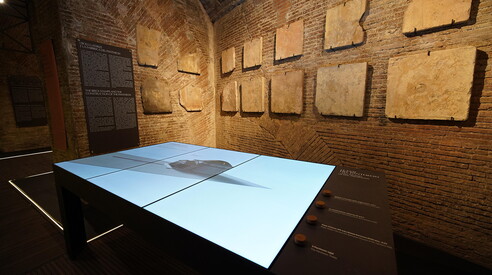
Terrazzo



