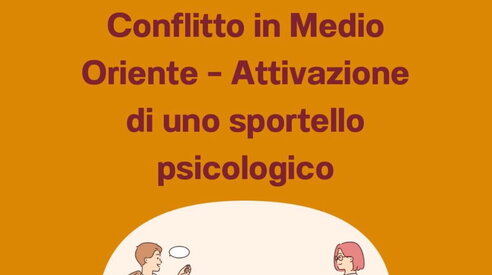Foto Ansa
in classe
La separazione delle carriere tra scuola e famiglia incagliata pure sulla sessualità
Il disegno di legge Valditara sul consenso informato per attività scolastiche legate alla sessualità riaccende il conflitto tra autonomia della scuola e diritti educativi delle famiglie. Ma dietro lo scontro politico c'è l’irrisolto equivoco tra istruire ed educare, senza mai coinvolgere davvero gli studenti
Dialogo sui massimi sistemi nella commissione Cultura della Camera, dove è arrivato il ddl Valditara relativo al consenso informato in materia di “ampliamenti dell’offerta formativa, che riguardano tematiche dell’ambito sessuale”. Il ragionamento del ministro dell’Istruzione è chiaro. Ogni scuola presenta un Piano triennale dell’offerta formativa, che riguarda le attività extracurricolari d’istituto e di cui le famiglie vengono informate, fatte salve le successive integrazioni secondo specifiche esigenze. Fra queste ultime possono esserci quelle che il ddl definisce “tematiche inerenti alla sessualità”; viene pertanto proposta l’istituzione di un consenso informato da parte dei parenti, così da evitare che l’educazione sessuale degli alunni minorenni venga intrapresa tramite attività non previamente concordate con le famiglie. Va detto che il ministero non dispone di dati relativi a tali progettazioni, proprio in quanto lasciate all’autonomia dei singoli istituti, e che pertinenza del governo è anche applicare una Costituzione il cui articolo 30 sancisce come sia “dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli”.
Tolto il mantenimento, è proprio sull’equivoco fra “istruire” ed “educare” che si è consumato l’appassionato dibattito in commissione Cultura. A rigore di logica, alla scuola dovrebbe spettare il compito di istruire (lo studente) e alla famiglia quello di educare (la persona); la nostra Carta fondamentale, così come il comune sentire, rende invece porosi i confini, causando dispute territoriali talora irrisolvibili, quando non surreali. La discussione si è infatti sviluppata subito su un doppio piano: da un lato il consenso informato in sé, dall’altro il macrotema del rapporto fra diritto delle famiglie all’educazione e autonomia scolastica. Il Pd, pur dicendosi “non contrario” al confronto scuola/famiglia, sottolinea il rischio che venga minata l’autorevolezza dei docenti, cui lo stesso ministro tiene particolarmente; in sostanza, il Pd critica il ddl Valditara perché non è abbastanza di destra. Per contrappeso, gli esponenti della maggioranza rivendicano l’equiparazione del consenso informato alla facoltà di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica, tradizionale baluardo di sinistra. Rilancia l’esponente di Avs, che denuncia la discriminazione cui saranno sottoposti gli alunni provenienti da famiglie di fondamentalisti religiosi (magari islamici?), vedendosi impedita la partecipazione ad attività scolastiche. Per fortuna arriva il M5s a mettere ordine: prima ventila l’ipotesi che il consenso informato porti a un’ulteriore disumanizzazione della donna, citando al riguardo la pornografia online, un caso di femminicidio, quello di una studentessa tacciata di “assassina” per aver abortito, la pagina social “Mia moglie” e un florilegio di espressioni volgari pronunciate da ragazzini al parco; poi paventa un futuro in cui i genitori dovranno fornire il consenso informato su qualsiasi argomento di studio, citando a titolo di esempio la sfericità della Terra, di cui evidentemente nel partito si dibatte tuttora con animosità.
Mentre la discussione si sposta sul Concordato stato-Chiesa del 1985, sulle malattie sessualmente trasmissibili e sull’incidenza della violenza di genere nei paesi scandinavi, è bene chiarire perché si è aggrovigliata in modo così barocco: è un vano tentativo di districare due opposti intersecati. Vanno tutelate, infatti, da un lato la libertà delle famiglie di non scadere nello stato etico, dall’altro la libertà dei docenti di non subire condizionamenti esterni. Ciò traspare da due dichiarazioni incidentali scaturite in commissione. Irene Manzi (Pd) sottolinea che non tutte le famiglie sono in possesso degli strumenti per valutare l’attività scolastica; Marco Perissa (FdI) ravvisa che le famiglie sono gerarchicamente superiori alla scuola per quanto concerne l’insegnamento non curricolare. Hanno ragione entrambi. L’equivoco trae origine dalla pretesa che scuola e famiglia debbano cooperare tanto all’istruzione quanto all’educazione, quando sarebbe molto più salutare una separazione delle carriere, così che ogni giorno la scuola liberi lo studente dalla famiglia e la famiglia liberi il figlio dalla scuola. Invece sono lì che litigano all’infinito, auspici il ministero e la commissione Cultura, mentre a nessuno salta in mente di domandare ai ragazzi cosa ritengano più opportuno fare, tanto più su un argomento così delicato e personale. Non accade mai.