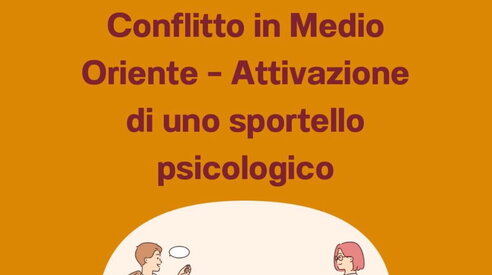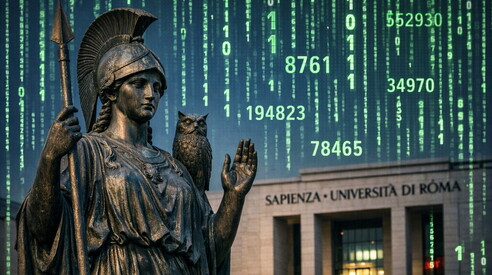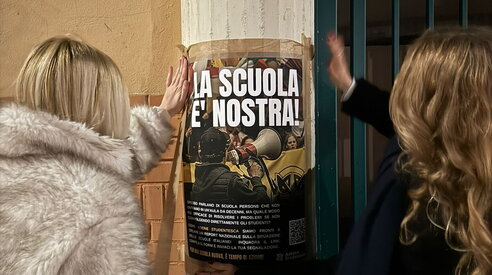(foto Ansa)
come dare spazio al merito
Quali docenti universitari per il futuro
Verso un nuovo sistema di reclutamento, dopo quindici anni dal varo dell’ultimo sistema di selezione. Il problema delle carriere tutte all’interno dello stesso ateneo. Il disegno di legge Bernini e i suoi rischi
Nel settembre 2024 la ministra dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini ha creato un gruppo di lavoro composto da una serie di personalità del mondo accademico incaricando loro di proporre ipotesi di riforma intorno a una serie di questioni, prima tra tutte il sistema di reclutamento universitario. A distanza di otto mesi questo gruppo di lavoro ha formulato alcune proposte confluite ora in un progetto di legge presentato da Bernini in Consiglio dei ministri lo scorso 19 maggio. Il procedimento di selezione dei professori universitari è attualmente regolato dalla cosiddetta legge Gelmini (L. 240/2010) e incentrato sulle Abilitazioni scientifiche nazionali (Asn), sorta di patenti che abilitano chi la riceve a partecipare ai concorsi banditi localmente dalla singole università; vengono rilasciate da un ampio numero di commissioni, una per ogni settore scientifico disciplinare, ciascuna in carica per circa due anni, composte da professori ordinari sorteggiati all’interno di una lista di docenti che, disponendo di una serie di requisiti scientifici e accademici, manifestano preventivamente la loro disponibilità.
Questo sistema di selezione è stato varato poco meno di quindici anni fa per iniziativa – va detto – di diversi dei componenti del medesimo gruppo che ora propone di sostituirlo. Perché dunque proporre di abolirlo? Il motivo che giustificherebbe l’introduzione di un nuovo meccanismo di selezione consiste, a detta di Bernini, nella crescita esponenziale del numero di docenti ‘abilitati’, numero che avrebbe provocato aspettative e pressioni di carattere assunzionale sui singoli Dipartimenti universitari nei quali tali ‘abilitati’ sono incardinati, ingolfando il sistema universitario. Questo è solo parzialmente vero. La legge Gelmini è chiara su questo punto: l’abilitazione in sé non da diritto ad alcun titolo né alcuna posizione, si tratta dunque di una pressione solo teorica, relativamente blanda. Una buona metà delle abilitazioni poi sono conferite a studiosi e studiose ‘precari/e’, ovvero non ancora nei ruoli universitari. Per i ricercatori già incardinati l’abilitazione è solo un titolo necessario per ottenere una conferma in ruolo che viene peraltro concessa nel 99,9 per cewnto dei casi. E per i professori associati, l’abilitazione è condizione necessaria per partecipare ai concorsi da professore ordinario.
Vero è che le commissioni non hanno un limite definito di possibili vincitori per ciascuna tornata delle Asn e, specie in alcuni settori, negli ultimi anni hanno largheggiato nel concedere queste ‘patenti’: se nelle prime tornate i criteri formali (e informali) avevano tenuto alta l’asticella della qualità scientifica dei candidati ‘abilitati’, nelle ultime tornate Asn alcuni settori scientifico-disciplinari hanno allargato oltremodo le maglie della selezione. La qual cosa potrebbe sicuramente giustificare una revisione del sistema ma non giustifica di per sé la sua sostituzione con un altro meccanismo altrettanto, se non più problematico del precedente.
Le Asn, infatti, pur con le loro numerose falle, hanno garantito, questo va riconosciuto, una soglia minima di decenza, un minimo comune denominatore delle qualità scientifiche necessarie per diventare professori di ruolo (associati o ordinari). Si propone ora di sostituire queste ‘patenti’ rilasciate da commissioni composte da docenti universitari con non meglio dettagliati “specifici requisiti di produttività e di qualificazione scientifica” individuati dall’Anvur, l’Agenzia nazionale della Ricerca, il rispetto dei quali garantirebbe la possibilità di partecipare ai singoli concorsi banditi localmente dagli Atenei senza passare dunque per il filtro delle Asn.
Senza quel filtro, magari troppo largo ma pur sempre selettivo, l’intera responsabilità della scelta del corpo docente rimane dunque in capo ai singoli Atenei che bandiscono i concorsi. Con tutto ciò che ne consegue. Non è un mistero che il nostro sistema universitario è uno dei meno mobili e dinamici del panorama europeo e internazionale. Le carriere iniziano e finiscono nella grande maggioranza dei casi all’interno dello stesso ateneo, spesso e volentieri chi ha fatto il dottorato in una certa università ha molte più possibilità di vincere un concorso bandito da quell’ateneo rispetto a qualcuno che ha ottenuto il titolo di dottore di ricerca in altri atenei. E via progredendo nella carriera. Tutto in virtù di logiche corporative e localistiche che hanno svuotato di valore persino i vincoli di legge stabiliti dalla legge Gelmini. Come ha ricordato Marco Mancini, membro del gruppo di lavoro Bernini, sul “Sole 24 ore” (27 maggio 2025), a dispetto della legge che impone di riservare il 20% dei concorsi a candidati che non provengono in termini di carriera dall’ateneo che bandisce, di fatto solo il 7 per cento dei concorsi ha avuto l’esito richiesto dalla normativa vigente.
La ragione è molto semplice e risiede in un meccanismo di natura finanziaria che non viene minimamente intaccato dal disegno di legge Bernini. Facciamo un esempio concreto per rendere la materia meno astrusa ai non addetti ai lavori. Se un concorso da professore ordinario bandito da una università XY fosse vinto da un docente esterno, l’Ateneo, più specificamente il Dipartimento in causa, dovrebbe stanziare per la sua assunzione una stipendialità intera (1 punto organico, in gergo universitario). Se invece il concorso fosse vinto, come accade attualmente nel 93 per cento dei casi, da un docente già in servizio come professore associato presso quell’università, l’Ateneo dovrebbe stanziare per il vincitore o la vincitrice solamente una percentuale pari allo 0,3 punti organico, ovvero la differenza tra il suo stipendio da professore associato e quello che riceverà come professore ordinario: in altre parole la sua progressione di carriera. Ne discende che con quel punto organico l’Ateneo può procedere all’assunzione di un docente esterno oppure alla progressione di carriera di tre docenti già di ruolo presso quell’università. Quale collegio di Dipartimento opterà per la prima soluzione sapendo che la sua applicazione implicherebbe l’indefinito slittamento nel tempo delle progressioni di carriera di ben tre colleghi, docenti interni a quel Dipartimento? Finché non si scardinerà questo sistema intervenendo sulla rigidità finanziaria che esso comporta per i singoli atenei, il sistema universitario italiano rimarrà saldamente centrato su base locale, localistica direi. Le carriere resteranno tutte (o quasi) svolte in gran parte all’interno dello stesso ateneo. E la possibilità per qualcuno in possesso di alte qualità scientifiche di ‘rompere il sistema’ continuerà a essere molto bassa.
Se questo disegno di legge diventasse legge, senza il filtro qualitativo delle Asn, il sistema rischia di diventare ancora più localistico. I pochi incentivi alla mobilità previsti, per il momento in modo piuttosto confuso, dal dl Bernini non saranno sufficienti a controbilanciare questo meccanismo. E a poco varranno gli incentivi economici previsti per premiare le scelte virtuose dei singoli atenei. La proposta è quella di assegnare una piccola percentuale della quota premiale (equivalente di per sé al 30 per cento del totale) del Fondo di finanziamento ordinario del Mur (Ffo) in base alla valutazione delle scelte compiute in sede concorsuale: si prevede cioè che i candidati vincitori dei concorsi banditi localmente siano sottoposti a una costante (biennale) verifica della loro produzione scientifica attraverso la Vqr (Valutazione qualitativa della ricerca) gestita dall’Agenzia Nazionale della Ricerca (Anvur). La Vqr, utilizzata fino a questo momento per valutare la qualità della ricerca dei Dipartimenti universitari attraverso il contributo di esperti anonimi, sarebbe dunque in questo caso usata per giudicare la produzione scientifica dei singoli. Si tratta di un’estensione giurisdizionale, se così possiamo definirla, che ignora le ragioni di cautela che hanno sinora limitato la sfera di competenza di questo strumento. La Vqr è infatti affidata ai cosiddetti peers, i pari, esperti anonimi, singoli docenti colleghi dei professori sottoposti a valutazione. Non potrebbe essere diversamente: chi potrebbe giudicare dei docenti universitari se non altri docenti universitari? Si tratta del resto di un sistema utilizzato dappertutto nel mondo accademico per la valutazione degli articoli da pubblicare nelle riviste scientifiche o per le monografie in via di pubblicazione. Tale meccanismo di valutazione, però, contiene, in modo direi fisiologico, una dose significativa di arbitrarietà legata alla sensibilità dei singoli valutatori, viziata in alcuni casi da inimicizie personali, piccole trasversali vendette accademiche, o viceversa da pregiudizi favorevoli legati ad amicizie, reti accademiche e via dicendo, sempre nascosti dietro l’anonimato. E’ per questo insieme di motivi che sinora si è deciso di utilizzare tale valutazione solo a livello dipartimentale, un livello collettivo che consente di attenuare l’incidenza di tali storture, spalmandone gli effetti, per così dire, sull’intero Dipartimento. Cosa che invece non accadrebbe nel caso della Vqr biennale prevista dal progetto di legge per i singoli docenti vincitori di concorsi locali.
E’ per tutto questo insieme di considerazioni che lascia piuttosto allibiti l’editoriale di Ernesto Galli della Loggia, egli stesso membro del gruppo di lavoro nominato dalla ministra Bernini, pubblicato sul Corriere della Sera e intitolato “Atenei, la legge e il sollievo” (20 maggio 2025). Un editoriale che saluta questo disegno di legge come una riforma che pone finalmente fine al “flagello del localismo” e impone un “drastico ridimensionamento” dei poteri dell’Anvur, nientedimeno che la fine del “ruolo di Gran Maestro della regolazione degli accessi” svolto da questa Agenzia della ricerca. E’ vero piuttosto il contrario, come si è visto, e in entrambi i casi: il ruolo dell’Anvur viene oltremodo aumentato, non certo diminuito, e il “flagello” del localismo semmai esasperato, non certo sconfitto. Un doppio grande abbaglio.
L’università italiana è rimasta da anni in mezzo a un guado, a metà strada tra il progetto dell’autonomia universitaria che punta ad applicare alla realtà italiana un modello universitario di tipo anglosassone, da una parte, e il modello di università statale, pubblica e centralizzata, quale è sempre stata e quale continua in gran parte a essere. Un esempio lampante delle contraddizioni nelle quali è intrappolata l’università italiana viene offerto proprio dalla proposta, formulata nel disegno di legge Bernini, di comporre le commissioni di concorso relative ai bandi per posti di professore ordinario per 4/5 da docenti esterni all’ateneo che bandisce il concorso (2/3 nel caso di bandi di concorso per professore associato), sorteggiati a livello nazionale tra i docenti disponibili. Al di là dell’ambiguità della formulazione dell’articolo di legge, la composizione casuale (tramite sorteggio) svolta a livello nazionale dovrebbe, nelle intenzioni dei proponenti, ridurre la possibilità che la commissione selezioni il candidato ‘interno’, ovvero il candidato locale che ha svolto la sua carriera interamente (o in gran parte) all’interno dell’ateneo che bandisce il concorso e che dunque è fisiologicamente favorito dalla rete di relazioni costruite all’interno dell’ateneo stesso nel corso degli anni. Il sistema del sorteggio, in altre parole, dovrebbe ridurre le storture di quel “localismo” sfrenato denunciato da Galli della Loggia. Si dà il caso però che, sempre seguendo la logica proposta dal disegno di legge Bernini, l’Ateneo in questione si troverebbe poi a essere valutato, giudicato e premiato (o penalizzato) finanziariamente dall’Anvur (tramite la Vqr), proprio in ragione delle scelte compiute da una commissione sorteggiata a livello nazionale, non dipendente dunque dall’Ateneo stesso: si troverebbe in altre parole a rispondere di scelte compiute da docenti che nulla hanno a che fare con esso.
La proposta di legge, infine, ha due effetti negativi sui quali la stessa si guarda bene dal pronunciarsi. Il primo è una indiretta ma palese delegittimazione del lavoro effettuato dalle tante commissioni di Asn attualmente in carica, nonché da quelle che le hanno precedute nell’ultimo decennio. Che senso ha (avrà) il lavoro da loro sin qui svolto? In che modo saranno valutate le ‘abilitazioni’ rilasciate negli ultimi anni (ancora in corso di validità, estesa nel tempo fino a 12 anni) e quelle che saranno rilasciate nei prossimi mesi? La proposta di legge non si esprime in alcun modo. Non dice se chi si è sottoposto in questi ultimi dieci anni a un lungo e defatigante processo di valutazione avrà un titolo in più da far valere in sede concorsuale oppure se invece il titolo dell’abilitazione semplicemente non varrà più nulla, equiparato di fatto alla nuova ‘patente’ rilasciata sulla base dei criteri presuntamente oggettivi stabiliti dall’Anvur. Il rischio concreto, in questo vuoto di pronunciamenti, sarebbe quello di creare un doppio canale o doppio regime di accesso ai concorsi, lasciando poi nelle mani delle singole commissioni di concorso la responsabilità di decidere se e come valutare il titolo dell’Asn eventualmente ottenuto in passato dai candidati, con il pericolo, quasi una certezza direi, di creare discrepanze di valutazione a seconda dei casi e delle convenienze. Alimentando così proprio quella macchina di ricorsi giudiziari che i proponenti si propongono invece di debellare attraverso questo nuovo disegno di legge.