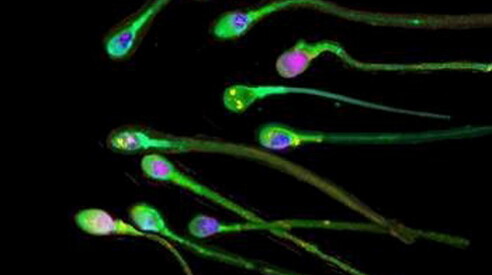FOTO Ansa
cattivi scienziati
La parola migrante evoca paura, ma la nostra esistenza è il risultato di un'antica catena di spostamenti
Una scoperta legata al dna estratto da un reperto osseo in Crimea ci ricorda che gli stessi processi che hanno plasmato le popolazioni neanderthaliane non sono diversi da quelli che ci hanno generato
Viviamo in un tempo in cui il movimento è diventato sospetto. La parola “migrante” evoca immediatamente emergenza, paura, confine. Ogni giorno, nei telegiornali e nei discorsi dei politici, la mobilità umana viene descritta come una deviazione da un presunto stato naturale di stabilità. Eppure, è precisamente l’opposto: il movimento è la condizione primaria dell’esistenza, non la sua eccezione. Tutta la storia biologica dell’uomo — e prima ancora quella delle specie che lo hanno preceduto — è una storia di spostamenti, di incroci, di flussi. La nostra paura del migrante è, in realtà, la paura di guardare la nostra origine.
Un piccolo frammento d’osso, lungo poco più di cinque centimetri, ritrovato nella grotta di Starosele in Crimea, ha rimesso in discussione tutto ciò che credevamo di sapere sulla mobilità in tempi antichissimi, quelli degli ultimi Neanderthal europei. Non è un reperto appariscente: un frammento senza forma, privo di qualsiasi indizio visivo utile per riconoscerne la specie. Ma è proprio per questo che è stato selezionato per un’analisi sistematica condotta con la tecnica ZooMS (Zooarchaeology by Mass Spectrometry), che consente di identificare il tipo di animale di appartenenza attraverso la composizione in peptidi del collagene osseo. Su centinaia di frammenti raccolti, uno soltanto ha mostrato un profilo umano, e precisamente Neanderthal. Da lì è iniziata un’indagine di precisione.
Il reperto osseo, denominato Star 1, è stato sottoposto a datazione mediante radiocarbonio. Il risultato, collocandolo fra 46.000 e 44.000 anni fa, lo inserisce nella fase finale dell’esistenza dei Neanderthal in Europa, pochi millenni prima della loro scomparsa definitiva. Il Dna antico estratto dal frammento era estremamente degradato, ma sufficiente a ricostruire la sequenza mitocondriale completa, il piccolo genoma che si trasmette solo per linea materna. L’analisi ha dato un esito del tutto inatteso: il DNA mitocondriale di Star 1 è strettamente imparentato non con quello dei Neanderthal europei — come ci si sarebbe aspettato in Crimea — ma con quello dei Neanderthal dell’Altai, in Siberia, a tremila chilometri di distanza.
Questo dato è un indizio di connessione su scala continentale fra gruppi di Neanderthal che sappiamo essere in genere chiusi. Il DNA mitocondriale è particolarmente indicativo per studiare i movimenti femminili, perché viene ereditato solo dalle madri; se dovesse essere il solo DNA conservato (per ora non lo sappiamo), la sua condivisione fra Crimea e Siberia è compatibile con una struttura sociale patrilocale, ove le donne erano quelle che si spostavano maggiormente tra clan per formare nuove alleanze o unioni. Un legame mitocondriale che in ogni caso implica che almeno le linee materne di certi gruppi di Neanderthal si siano propagate attraverso l’Eurasia, portando con sé geni precisi, ma non solo.
Gli archeologi hanno infatti confrontato gli strumenti in pietra trovati nella stessa grotta della Crimea con quelli di altri siti. Le affinità con le industrie micocquiane delle grotte di Chagyrskaya e Okladnikov, in Siberia, sono impressionanti: stesse forme di raschiatoi, stesse tecniche di scheggiatura, stessi tipi di materie prime. Le prove materiali e quelle genetiche si rafforzano a vicenda: popolazioni diverse di Neanderthal, separate da migliaia di chilometri, condividevano tecnologie e antenati. Le somiglianze non possono essere spiegate solo da convergenza casuale: esistono tutte le condizioni per ritenere che ci fossero veri e propri contatti, mediati da spostamenti attraverso le steppe eurasiatiche.
Il quadro che emerge è quello di una rete preistorica estesa, alimentata da fasi climatiche che periodicamente aprivano corridoi di habitat favorevoli tra l’Asia centrale e l’Europa orientale. Durante questi intervalli interglaciali, mandrie di erbivori, predatori e cacciatori si spostavano seguendo le stesse rotte. La Crimea, con il suo clima relativamente temperato e le grotte che offrivano riparo, rappresentava un punto nodale di questo sistema. Star 1 ne è la testimonianza diretta: un individuo che conserva, nel proprio DNA, l’impronta di una discendenza proveniente da est, forse giunta dopo molte generazioni di migrazioni lente ma continue.
Il valore di questa scoperta non sta solo nella biologia, ma nella prospettiva che impone. I Neanderthal non erano creature ferme, incapaci di comunicare con i loro simili lontani: erano parte di un mondo in movimento, attraversato da scambi di geni e di cultura. La loro storia non è quella di un popolo “bloccato” che attende di estinguersi, ma quella di una specie capace di connettere continenti.
E così, da un frammento d’osso quasi anonimo, emerge una verità che riguarda anche noi. Gli stessi processi che hanno plasmato le popolazioni neanderthaliane — la necessità di muoversi, di adattarsi, di mescolarsi — non sono diversi da quelli che ci hanno generato. Ogni volta che discutiamo di migrazioni come di una minaccia, dimentichiamo che la nostra stessa esistenza è il risultato di un’antica catena di spostamenti.
L’antenato materno di Star 1, vissuto a migliaia di chilometri di distanza, ci ricorda che le frontiere sono invenzioni recenti e che la mobilità, non la chiusura, è la nostra radice identitaria più profonda.