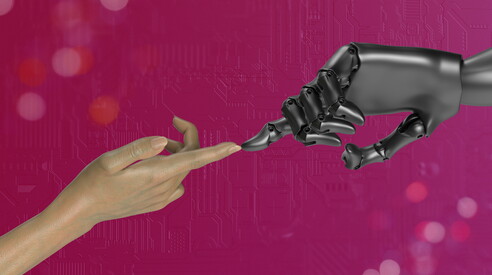
Foto di Igor Omilaev su Unsplash
Cattivi scienziati
Simbiosi digitale: l'evoluzione che ci unisce all'intelligenza artificiale
Due esperti di biologia evoluzionistica, Rainey e Hochberg, propongono di leggere la crescente simbiosi tra esseri umani e intelligenze artificiali come una nuova transizione evolutiva. Se la coevoluzione continua potremmo non essere più individui isolati, ma parti di un nuovo organismo collettivo
Un nuovo articolo degli esperti di biologia evoluzionistica Paul Rainey e Michael Hochberg su Pnas propone di leggere l’integrazione crescente fra esseri umani e tecnologie digitali, in particolare sistemi di intelligenza artificiale, come un passo in una lunga storia evolutiva che ha più volte trasformato entità autonome in individui collettivi. Si tratta di un’ipotesi radicata in un corpus teorico robusto. Le grandi transizioni di individualità, dalle prime molecole autoreplicanti alle cellule eucariotiche, dalle cellule agli organismi multicellulari, fino alle società eusociali, seguono infatti tutte lo stesso schema: cooperazione stabile, comunicazione interna, divisione del lavoro, dipendenza reciproca, e soppressione del conflitto tra le parti. Quando queste condizioni si realizzano, la selezione naturale smette di agire sul singolo componente e privilegia le combinazioni integrate che massimizzano la fitness complessiva.
Molti segnali indicano che qualcosa di analogo sta avvenendo oggi. La nostra vita quotidiana è filtrata da piattaforme digitali che modellano in modo sistematico l’accesso a informazione, relazioni, opportunità di lavoro e perfino partner riproduttivi: si formano così gradienti di selezione culturale e sociale che modificano i nostri comportamenti in maniera cumulativa. Dati recenti mostrano che nel 2025 il 78 % delle imprese a livello globale utilizza già sistemi di intelligenza artificiale in almeno una funzione aziendale, rispetto al 55 % dell’anno precedente, e che negli Stati Uniti quasi un terzo degli utenti che usano regolarmente strumenti di IA generativa lo fa per oltre un’ora al giorno lavorativo. Questo spostamento dall’adozione sperimentale all’uso quotidiano rende l’IA un fattore determinante per la competitività professionale e per l’accesso alle opportunità sociali.
I modelli di IA, a loro volta, si addestrano su questo mondo già alterato dai cicli precedenti, chiudendo un anello di retroazione che accelera l’adattamento reciproco. Qui si trova la differenza sostanziale con l’uso di strumenti tradizionali: un martello, per quanto utile, non modifica sé stesso in risposta al nostro modo di usarlo, né influenza il nostro comportamento se non nel momento dell’impiego. Persino nel caso di tecnologie che hanno accompagnato la nostra evoluzione biologica, come il fuoco, il processo non è mai stato simmetrico: l’uomo si è evoluto attorno al fuoco, sviluppando nuove diete, anatomie e comportamenti, ma il fuoco non è cambiato per adattarsi a noi. L’intelligenza artificiale introduce invece una novità radicale: si trasforma in base ai dati che le forniamo, e i nostri comportamenti cambiano a loro volta sotto l’influenza dei suoi output. È questa simmetria di influenza, e la dipendenza che ne deriva, a generare una vera dinamica di coevoluzione: l’evoluzione dell’utente e quella dello strumento diventano dipendenti dalla loro interazione reciproca, fino al punto in cui la possibilità stessa di evoluzione del sistema richiede questa interazione continua.
È un fatto osservabile: le nuove generazioni di modelli linguistici riflettono lo stile e le norme di interazione che i loro predecessori hanno contribuito a diffondere, e lo stesso vale per le piattaforme che regolano traffico, consumo culturale e scelte economiche. L’uso massiccio di questi sistemi non solo produce un effetto culturale, ma plasma i dati che alimentano la generazione successiva, rendendo il ciclo sempre più rapido. A questo si aggiunge una dipendenza crescente, documentata da metriche di utilizzo e da indagini demografiche: memoria, navigazione, calcolo, decisione collettiva sono sempre più delegate a sistemi digitali, al punto che il loro venir meno comporta una perdita tangibile di capacità individuale e di competitività sociale. Studi longitudinali hanno dimostrato che l’uso continuativo di GPS riduce la capacità di costruire mappe mentali e di ricordare percorsi in autonomia, mentre ricerche sull’uso di app di navigazione come Waze mostrano pattern comportamentali simili alla dipendenza, con bisogno, persistenza e conflitto. Queste evidenze confermano che non si tratta solo di comodità, ma di una ristrutturazione profonda delle nostre funzioni cognitive attorno alla tecnologia.
Se queste tendenze si consolidano, la selezione comincerà a favorire non l’individuo isolato, ma il composto umano-IA che sa coordinarsi meglio, comunicare con più efficienza e sfruttare al massimo le risorse digitali. È una dinamica che conosciamo bene in biologia: quando la dipendenza diventa obbligata, i partner della simbiosi smettono di essere semplici alleati e diventano parti dello stesso individuo. Qui entra in gioco un punto ancora più delicato. Finora l’evoluzione dell’IA è stata lamarckiana, guidata da miglioramenti deliberati; ma i sistemi complessi tendono a generare varianti che persistono e competono, e quando ciò avverrà – in architetture, agenti o configurazioni – la dinamica diventerà darwiniana, con traiettorie che non possiamo più correggere dall’alto in modo lineare. I sistemi di raccomandazione e i modelli di ottimizzazione già mostrano comportamenti emergenti difficili da prevedere e da controllare, segno che la competizione fra soluzioni sta diventando un motore di evoluzione indipendente.
Per quanto possa apparire distopico, questo scenario è una proiezione coerente e possibile di fenomeni già documentati. Ignorarlo significherebbe perdere l’occasione di orientare l’evoluzione del sistema. Rainey e Hochberg invitano a studiare per tempo le soglie a cui la dipendenza diventa irreversibile, a comprendere i feedback che accelerano l’appaiamento uomo-macchina e a intervenire sulle condizioni ecologiche dell’interazione, progettando regole, interfacce e incentivi che favoriscano un esito cooperativo. L’alternativa, secondo i due studiosi, è lasciare che la transizione si completi per inerzia, con il rischio di frammentazione in popolazioni umano-IA incompatibili, di perdita di agency collettiva e di obiettivi algoritmici non allineati ai nostri. Potrebbe benissimo darsi che Rainey e Hochberg si siano spinti troppo oltre con la fantasia, ma è certo che, per le simbiosi biologiche, la differenza fra mutualismo e parassitismo la fa l’ambiente, che nel caso specifico è plasmato da noi stessi: riflettere sulla possibilità almeno teorica che stiamo creando un nuovo individuo composito per effetto di una selezione coevolutiva (a molti livelli, culturale, sociale e naturale) potrebbe essere il solo modo che abbiamo se vogliamo che i nostri interessi siano ancora al centro.

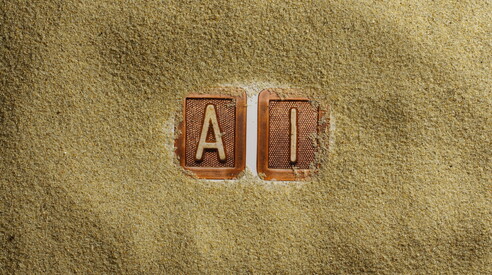
cattivi scienziati
L'AI è destinata a restare. Ma il nodo dei costi può incidere sui rendimenti

In principio, il pollice


