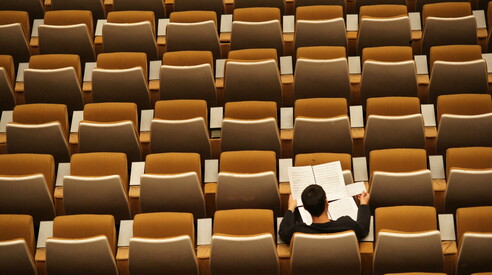Ansa
Cattivi scienziati
Cosa è la vita: perché ce lo chiediamo?
Il bisogno di distinguere fin dai primordi evolutivi chi fosse simile a noi ha spinto la nostra specie a elaborare criteri sempre più raffinati per riconoscere l’altro come agente vivente
Perché continuiamo a chiederci cosa sia la vita? Perché, cioè, al di là delle imperfezioni delle risposte che diamo, che richiedono riaggiustamenti continui, consideriamo comunque da sempre una distinzione importante quella fra ciò che è vivo e ciò che non lo è? Il bisogno di distinguere fin dai primordi evolutivi chi fosse simile a noi – capace di agire con intento, cooperare o rappresentare una minaccia – ha spinto la nostra specie a elaborare criteri sempre più raffinati per riconoscere l’altro come agente vivente. Nelle savane africane, riconoscere un predatore o un compagno poteva significare la differenza tra la vita e la morte, e il cervello umano ha sviluppato meccanismi rapidi per individuare traiettorie e comportamenti che evocano scopo. Fin dai primi mesi di vita, i neonati mostrano una preferenza e maggior interesse per movimenti autoreferenziali, che si svolgono, cioè, come se obbedissero a un’intenzionalità interna, e analoghi processi si ritrovano in stormi di uccelli o branchi di mammiferi sociali, dove capire chi agisce “per sé” e chi è semplice paesaggio è cruciale per cooperare o difendersi.
Questa predisposizione cognitiva venne poi formalizzata nelle grandi visioni filosofiche: Aristotele parlava di ψυχή come principio interno di moto e percezione, e i neoplatonici vedevano la vita come partecipazione a un’anima universale. Il pensiero cartesiano del Seicento, invece, separò nettamente mente e corpo, interpretando quest’ultimo come un automa meccanico privo di ogni principio vitale intrinseco; in reazione a questo modello, tra Sette e Ottocento emerse il vitalismo, che riteneva che alla materia corporea si dovesse aggiungere un “soffio” o una forza vitale irriducibile alle leggi meccaniche. Le due visioni si trovarono così in aperto antagonismo: da un lato la spiegazione meccanicistica di processi fisiologici e comportamentali come puro movimento di organi e fluidi, dall’altro l’idea che nessuna macchina avrebbe mai potuto esibire la coesione, la finalità e la dinamicità proprie degli organismi viventi.
Fu solo con la nascita della biologia molecolare e la decifrazione del codice genetico che la nozione di “forza vitale” venne definitivamente accantonata, lasciando spazio a processi chimicofisici descrivibili con formule precise. Tuttavia, questa vittoria della meccanica molecolare non ha eliminato la nostra pulsione a raggruppare funzioni complesse sotto l’etichetta “vita”: continuiamo a investire di significato categorie come organismo, individuo e persino ecosistema, pur sapendo che si tratta di astrazioni funzionali nate per comodità descrittiva. Con l’avvento degli studi sui sistemi complessi e delle proprietà emergenti si è tentato di oltrepassare la semplice distinzione tra processo meccanico e vitalismo, introducendo metriche quantitative tratte da studi di auto‑organizzazione, teoria dei sistemi complessi e termodinamica fuori equilibrio, e i criteri di autopoiesi di Maturana e Varela. Queste teorie cercano di misurare l’autonomia e l’integrazione interna di un sistema, ma finiscono per riproporre lo stesso meccanismo evolutivo di base: riconoscere in un’entità quel minimo di coesione e intenzionalità che ci rassicuri sulla sua “somiglianza” a noi. Oggi, la robotica autonoma e le IA generative spingono ancora più in alto la soglia di ciò che definiamo agente intenzionale, mentre approcci animisti e postumanisti ci ricordano che ogni confine vita–nonvita è culturalmente costruito e storicamente variabile.
Alla fine “la vita” non esiste come entità ontologica separata, ma come continuum dinamico di organizzazione complessa, processi e relazioni. Ogni nuova metrica di “somiglianza” – che si tratti di funzioni metaboliche, di capacità di apprendimento adattativo o di gradi di integrazione informazionale – rialza o abbassa inconsapevolmente la barra di quel confine, dimostrando che la soglia per definire vivente un sistema è un parametro mobile, plasmato tanto dalle nostre categorie concettuali quanto dal grado di similarità che decidiamo di riconoscere nell’altro. La necessità di stabilire nel modo più oggettivo possibile quella soglia non è solo un problema epistemico, ma il riverbero di un’antica strategia evolutiva: stabilire chi, tra i molti oggetti che percepiamo nel mondo, merita il nostro riconoscimento come agente vivente, capace di intenzioni e di interazioni complesse con noi. La vita, quindi, è una proprietà che sentiamo la necessità di attribuire (e quindi di definire) perché la capacità di esercitare l’attribuzione ha conferito un vantaggio evoluzionistico preciso tanto alla nostra specie, tanto a moltissime altre che discriminano almeno alcuni organismi viventi dal mondo inanimato traendone gli stessi vantaggi; ma vale a questo punto chiedersi se non ci possano essere altri vincoli derivati dalla nostra biologia che abbiano guidato il modo in cui effettuiamo la nostra classificazione fra vivente e non vivente.
A questo scopo, possiamo esaminare un punto rivelatore: indipendentemente dalla cultura e dalla società di appartenenza, noi tendiamo ad ordinare su una scala di valore diverso i viventi secondo un principio antropocentrico, che privilegia fra i viventi gli animali, e tra questi quelli capaci di scambio sociale ed emotivo con noi, fino a individuarli come portatori di diritti in alcune società occidentali. È evidente in questo caso l’impronta della nostra biologia di specie sociale: tanto più un organismo è in grado di connettersi emotivamente con noi, cioè di entrare a far parte idealmente del nostro gruppo sociale, tanto più attribuiamo valore a quell’organismo, indipendentemente dalla sua utilità pratica per noi. Non siamo solo noi (fin dall’antico Egitto) ad affezionarci a gatti, né ci leghiamo solo ad animali che, come quelli, sono utili perché per esempio acchiappano i topi: pappagalli parlanti, scimmiette o maialini allevati come figli in alcune tribù remote, animali di affezione di ogni natura sono presenti in culture di ogni sorta ed in epoche diverse, tutti caratterizzati dalla capacità di stabilire legami emotivi e comunicativi forti con gli esseri umani che li accudiscono.
Le vite di questi animali, e per estensione degli individui della loro specie, finiscono più o meno consapevolmente per assumere maggior valore ai nostri occhi: il motivo per cui li riteniamo meritevoli di maggiore tutela non è perché soffrono se maltrattati, come spesso si sente dire, ma perché essi riescono a canalizzare la nostra empatia meglio di altri animali che soffrono ugualmente se maltrattati, ma non sono in grado di comunicare efficacemente la loro sofferenza e di scatenare quindi quel tipo di risposte emotive che è indispensabile per mantenere coesi i gruppi sociali umani – le risposte basate appunto sull’empatia. Del resto, cani, gatti ed altri animali si sono adattati a sfruttare sempre meglio tali tipi di risposte; e il nostro bisogno di riconoscere un valore maggiore alla vita di questi animali, che come ho detto non risiede nella loro utilità pratica, è rivelatore del modo stesso in cui abbiamo forgiato il nostro concetto di vivente prima e di scala dei viventi dopo, ponendo molto più al di fuori dei “nostri” per esempio i maiali che non i gatti (pur non essendovi alcuna metrica oggettiva che possa giustificare questa distanza emotiva).
La necessità di identificare e distinguere agenti è alla base del nostro desiderio di identificare cosa sia la vita, e la nostra natura sociale – anche sfruttata dall’evoluzione di certe specie domestiche - ci ha spinto a creare una scala di importanza che, sebbene disconosciuta dalla scienza moderna, è quella che ancora applichiamo quando uccidiamo una mosca e nutriamo un cane, ed è la stessa che codifichiamo nella religione e nel diritto.

CATTIVI SCIENZIATI