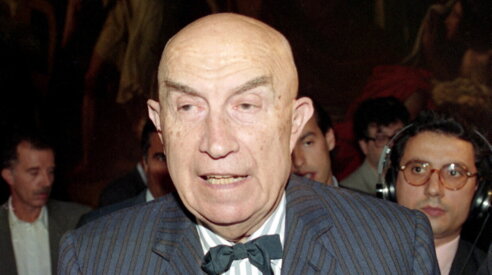
Gianfranco Miglio (foto ANSA)
Il libro
Fare chiarezza attorno all'idea di federalismo. La lezione di Gianfranco Miglio
Comprendere lo stato significa comprendere la sovranità, e dunque riconoscere il carattere specificamente moderno e artificiale di questo dispositivo politico che continua, ancora oggi, a plasmare le nostre istituzioni. Chiacchierata con i prof. Bassani e Palano
Federalismo è un concetto usato spesso in maniera impropria, attorno al quale giova fare un po’ di chiarezza. In questo sforzo, il recente volume Il federalismo in Italia e la lezione di Gianfranco Miglio (Rubbettino, 2025), che illumina il pensiero del politologo comasco, rappresenta una risorsa preziosa. Ne parliamo con Luigi Marco Bassani, storico del pensiero politico dell’Università Pegaso, e Damiano Palano, filosofo della politica dell’Università Cattolica, che al volume hanno contribuito.
La prima questione da sciogliere riguarda la dicotomia tra stato e sovranità da un lato, e federazione e federalismo dall’altro. “Lo stato è la risposta moderna, specificamente europea e occidentale, a un problema antico e ricorrente: quello dell’ordine politico”, spiega il prof. Bassani. “Il medioevo europeo era caratterizzato da un ordine profondamente policentrico, in cui il potere era frammentato e disperso tra una molteplicità di autorità concorrenti. Questa struttura produceva una certa instabilità. La modernità politica vi ha risposto attraverso un movimento di accentuazione e concentrazione del potere: lo stato moderno è la soluzione istituzionale e intellettuale alla dissoluzione dell’universo policentrico medievale”. La sovranità è il concetto che consente di cogliere la natura profonda dello stato: “Essa implica la possibilità — teoricamente illimitata — di accentrare e ridefinire costantemente i poteri all’interno di un determinato spazio politico. Non si tratta di una realtà ‘naturale’, ma di una costruzione concettuale”. In questo senso, la logica statuale si rivela profondamente inospitale nei confronti delle categorie federali, che si basano invece su una visione pattizia e contrattuale della comunità politica.
“Nel paradigma dello stato sovrano”, continua Bassani, “l’idea stessa di una divisione o condivisione del potere appare impossibile: di conseguenza, l’espressione ‘stato federale’ rappresenta un ossimoro. Comprendere lo stato significa pertanto comprendere la sovranità; e comprendere la sovranità implica riconoscere il carattere specificamente moderno e artificiale di questo dispositivo politico che continua, ancora oggi, a plasmare le nostre istituzioni”. Vi è poi una contrapposizione tra federazione e confederazione: “Chi utilizza lo schema confederazione-federazione, o anche termini quali ‘stato federale’ e ‘stato centrale’, conferisce validità a un’estensione a-problematica del conglomerato di concetti giuridici dello stato moderno di matrice europea a una realtà, quella federale, che è impossibile analizzare per mezzo di tali categorie”. Il prof. Bassani spiega come la distinzione confederazione-federazione sia tutta interna alla costruzione dello stato moderno e rimandi necessariamente a concentrazioni di potere sul territorio potenzialmente illimitate.
“Il nucleo della distinzione federazione-confederazione verte sul luogo di residenza della sovranità: nella federazione quest’ultima risiederebbe nello ‘stato federale’, nella confederazione nelle unità costitutive, gli ‘stati confederati’”. La differenza è che il primo è uno stato in senso proprio, il secondo un patto contrattuale fra stati sovrani. Il “politico” quindi non può essere pensato al di fuori dello stato e dei suoi paradigmi. “Il vero dramma della politica moderna”, continua Bassani, “non sta solo nella creazione, questa sì ‘oggettiva’, di un centro di potere irresistibile, ‘sovrano’ e potenzialmente illimitato. Ma soprattutto nella costruzione ‘soggettiva’ della sua indispensabilità, della assoluta necessità di tale potere, in realtà storicamente contingente. Ormai, in interiore homine habitat una veritas tutta edificata dallo stato”. Alla base delle riflessioni di Gianfranco Miglio risiede la dicotomia tra obbligazione politica e contratto-scambio: il prof. Palano li definisce due tipi di vincolo sociale.
“Il contratto-scambio si riferisce a relazioni orizzontali, in cui degli individui si scambiamo beni o servizi, accordandosi sull’oggetto della transazione e le sue modalità. La rendita che deriva da simili scambi è in questo caso aleatoria, incerta, ma può anche essere molto elevata. L’obbligazione politica è invece il vincolo politico per eccellenza. Coinvolge molti individui e ha un oggetto indeterminato, perché riguarda tutte le esigenze che potranno emergere nel futuro. Ha una struttura gerarchica, con un vertice e dei seguaci più o meno passivi. Questi ultimi offrono obbedienza, mentre la leadership garantisce protezione e distribuisce rendite politiche (mai molto elevate ma certe)”.
E’ convinzione di Miglio che questi due tipi di vincolo siano antitetici, ma che siano sempre presenti in ogni società: “La loro estensione è variabile. Quando l’area del contratto-scambio si dilata, quella dell’obbligazione politica si restringe, e viceversa”. In un precedente volume degli scritti dello scienziato della politica comasco curato da Damiano Palano – La lezione del realismo (Rubbettino, 2022) –, emerge con forza la natura realista del suo pensiero. Miglio, ci spiega Palano, è un esponente di quella tradizione eterogenea di pensiero che va da Tucidide a Carl Schmitt, passando da Machiavelli e Hobbes. Ritiene che ci siano alcune grandi “regolarità” che caratterizzano la politica e che possono essere imbrigliate dalle istituzioni, ma non eliminate, perché radicate nella “natura umana”.
“Il compito dello studioso di politica è dunque riconoscere queste regolarità, benché ciò significhi confrontarsi con aspetti brutali, come il conflitto, la contrapposizione amico-nemico, la sete di potere, le relazioni di dominio”. Una delle grandi ambizioni di Miglio è inoltre quella di sintetizzare in un quadro unitario – la teoria “pura” della politica – le varie regolarità scoperte dai realisti. “C’è indubbiamente in questo un’inclinazione ‘positivista’”, afferma Palano, “che lo avvicina a Pareto, più che a Schmitt”.
“Questo spiega anche il suo interesse per la sociobiologia di Wilson. Ma l’attenzione ai mutamenti storico-culturali – come la costruzione dello stato – non viene mai meno”.





