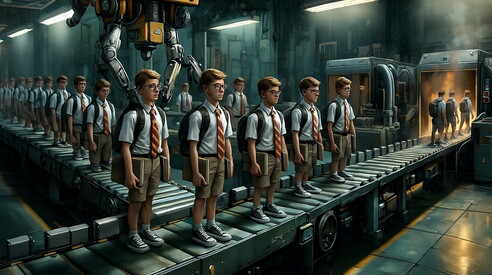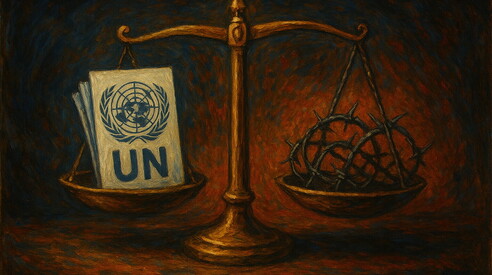il foglio AI
La separazione delle carriere non è un capriccio, e lo spiegava nel 1987. Consiglio ai paladini del “no”
La separazione delle carriere non nasce con Nordio o con il centrodestra: è una scelta coerente con il processo accusatorio, teorizzata già da Giuliano Vassalli nel 1987
Se oggi chiedete a un magistrato, a un avvocato, a un politico perché la separazione delle carriere è diventata il totem della riforma della giustizia, molti vi risponderanno parlando di Nordio, del centrodestra, delle correnti, dell’Anm. Quasi nessuno vi dirà: “Andate a rileggere che cosa diceva Giuliano Vassalli nel 1987”. E invece il punto è esattamente questo: c’è un’intervista di allora in cui il padre del codice di procedura penale spiega, con una semplicità disarmante, perché la separazione delle carriere non è una mania da talk show, ma una conseguenza logica del processo accusatorio.
Vassalli, per chi ha meno dimestichezza con i santi del pantheon garantista, non è uno qualunque. Partigiano, deportato dai nazisti, grande penalista socialista, professore di procedura penale, ministro della Giustizia, presidente della Consulta. E’ l’uomo che ha disegnato il codice entrato in vigore nel 1989, quello che ha mandato in soffitta il vecchio processo inquisitorio. Nell’intervista del 1987 Vassalli fa una cosa che oggi sembra quasi rivoluzionaria: non parte dall’ideologia, parte dalla logica. Dice in sostanza: se vogliamo un processo accusatorio, in cui il pubblico ministero accusa, la difesa difende e il giudice sta in mezzo, terzo e imparziale, non possiamo continuare ad avere pubblici ministeri e giudici dentro lo stesso corpo, con la stessa carriera, gli stessi organi di governo, la stessa cultura. Perché è un problema? Vassalli lo dice con un esempio semplice. Se il pm e il giudice hanno fatto lo stesso concorso, lo stesso tirocinio, votano alle stesse elezioni per il Csm, appartengono alle stesse correnti, lavorano negli stessi uffici, è inevitabile che tra loro si crei una prossimità, un’abitudine, un linguaggio comune. Ma in un processo accusatorio questo è tossico: il giudice deve essere estraneo sia all’accusa sia alla difesa. Non può essere “il cugino del pm”, quello con cui il giorno prima discuteva di trasferimenti. Poi c’è il tema della professionalità. Il pm moderno, dice Vassalli, dovrebbe essere un investigatore, un avvocato dell’interesse pubblico che guida la polizia giudiziaria, fa scelte, seleziona i casi, risponde delle sue priorità. Il giudice, invece, deve pensare solo a garantire i diritti, valutare le prove, motivare le decisioni. Sono mestieri diversi, che richiedono formazioni diverse. E infine, il punto più politico di tutti: l’apparenza di giustizia. Non basta che il giudice sia imparziale, deve anche sembrarlo. Se l’imputato percepisce che il giudice appartiene alla stessa “famiglia” del pm, che domani potrebbe fare il pm al posto suo, tenderà sempre a dubitare. Perché i campioni del “no” dovrebbero leggere (o rileggere) quell’intervista? Perché toglie di mano l’argomento più comodo: l’idea che la separazione sia un’invenzione politica recente, pensata per “mettere il guinzaglio ai pm”. No. L’ha pensata, spiegata e rivendicata il giurista che ha costruito il nostro processo penale moderno.