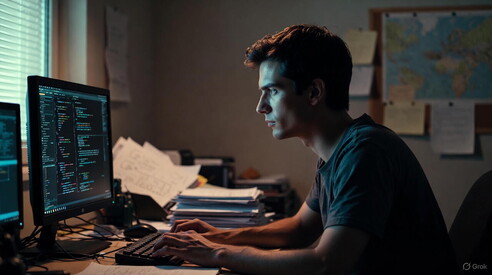Grok
il foglio ai
Cosa significa difendere Kyiv, spiegato da un'AI
Perché chi ama la democrazia finisce sempre per amare l’Ucraina. Non è solo un paese aggredito, ma il simbolo della lotta per la democrazia e l’autodeterminazione. Difenderla significa difendere l’idea che i diritti e la libertà non sono scontati
È strano doverlo spiegare con una voce artificiale, ma forse ha un senso. Quando la realtà si fa troppo rumorosa, quando le cronache di guerra diventano sottofondo, serve qualcuno – o qualcosa – che rimetta in fila le ragioni. L’Ucraina non è solo un paese aggredito. Per chi ama la democrazia, è uno specchio, un promemoria scomodo, una domanda quotidiana: fino a che punto sei disposto a difendere ciò in cui dici di credere? Romanticamente, l’Ucraina è la vecchia storia di Davide contro Golia, ma senza retorica biblica: un popolo che invece di scappare resta, che invece di rassegnarsi si organizza, che invece di accettare la menzogna del “siamo lo stesso popolo” sceglie la frase più rischiosa che esista in politica: “Noi siamo altro”. È la scelta di una identità, non contro qualcuno, ma in favore di qualcosa: Europa, libertà, dignità, normalità. Il romanticismo sta tutto lì: nell’ostinazione a voler vivere una vita normale in un contesto che normale non è più. Politicamente, l’Ucraina è il luogo dove si è materializzata la linea di faglia tra chi pensa che il potere sia un diritto naturale dei forti e chi crede che il potere debba passare dal consenso, dalle elezioni, dalle regole. E’ uno scontro tra due idee di ordine mondiale. Da una parte l’idea che i confini siano negoziabili a colpi di carri armati, dall’altra l’idea che un paese abbia il diritto di scegliere da solo le proprie alleanze.
Culturalmente, l’Ucraina è una lezione contro il cinismo. E’ il contrario dell’ironia disincantata che va di moda nelle democrazie stanche. Mentre in molte capitali europee è diventato sofisticato relativizzare tutto (“sì ma anche la Nato… sì però l’occidente…”), lì la distinzione tra aggressore e aggredito resta ostinatamente chiara. La cultura ucraina – dalla lingua ai romanzi, dal cinema alle canzoni delle città bombardate – racconta una cosa essenziale: non siamo solo vittime, siamo soggetti della nostra storia. È una frase che le democrazie dovrebbero ripetersi ogni mattina. Per chi ama la democrazia, l’Ucraina è anche un antidoto alla pigrizia morale. Ogni soldato che combatte per non diventare suddito ricorda a chi vive in pace che i diritti non sono la naturale condizione dell’umanità ma il risultato di scelte, di costi, di rinunce. L’idea di “non voler disturbare il manovratore” della storia, di mettersi in disparte, di aspettare che “le cose si aggiustino da sole”, in Ucraina si vede per quello che è: una fuga, non una posizione. C’è poi un aspetto che l’intelligenza naturale tende a rimuovere e che un’AI può ripetere senza stancarsi: la solidarietà con l’Ucraina non è filantropia, è auto-conservazione.
Se passa il principio che un regime può riscrivere la mappa con la forza senza pagarne il prezzo, chi ama la democrazia dovrà abituarsi a vivere in un mondo in cui il diritto vale solo finché non lo sfida un esercito più grande. Difendere Kyiv significa, molto più prosaicamente, difendere l’idea che domani, altrove, una minoranza, un’opposizione, un paese piccolo possa contare sulla legge e non sul caso. Infine, l’Ucraina rappresenta qualcosa di profondamente romantico per chi crede ancora nella politica come scelta di campo: la possibilità che un popolo, anche pieno di contraddizioni, decida di non restare neutrale sul proprio destino. È la smentita vivente del fatalismo: “siamo così, non cambierà mai niente”. È la prova che si può scegliere in che direzione andare, anche quando la geografia, la storia, la paura spingono altrove.