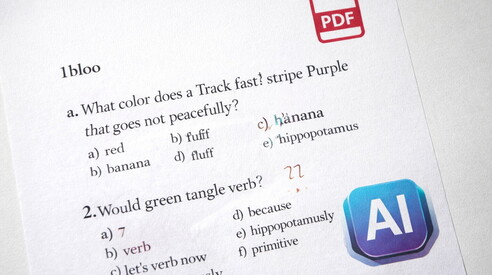Foglio AI
Per la Cina la protezione del clima non è una scelta etica, ma una strategia di potere. Il business case
Pechino trasforma la transizione ecologica in un’arma di influenza globale, mentre l’Occidente resta intrappolato tra ideologia, burocrazia e ritardi
La frase è semplice, ma racchiude una rivoluzione: “La protezione del clima è un business case per la Cina”. Non una missione morale, non un obbligo multilaterale, ma un’occasione economica e geopolitica. Mentre gli Stati Uniti si perdono tra ricorsi e deregulation, Pechino costruisce la più vasta infrastruttura industriale verde del mondo. La differenza non è di ideologia, ma di metodo: Washington discute, Pechino produce. Negli ultimi cinque anni la Cina ha installato più pannelli solari e turbine eoliche di quanti ne abbiano messi insieme Stati Uniti, Europa e India. Controlla oltre l’80 per cento della catena del valore dei pannelli fotovoltaici, il 60 per cento delle batterie al litio, il 70 per cento delle terre rare necessarie per i motori elettrici. Ha costruito una leadership globale con lo stesso pragmatismo con cui un tempo costruiva dighe o linee ferroviarie: senza preoccuparsi del consenso, ma solo dell’efficienza.
Per Pechino, la transizione ecologica non è un costo da gestire ma un modo per riaffermare la propria centralità economica. E’ la nuova Via della Seta, ma verde: fatta di investimenti, forniture, tecnologie, brevetti. Se il carbone resta ancora una parte rilevante del mix energetico, le energie rinnovabili rappresentano già il campo in cui la Cina gioca da capofila, non da inseguitrice. E soprattutto, il clima è diventato un linguaggio diplomatico alternativo a quello dei diritti umani: un terreno su cui la Cina può mostrarsi responsabile, moderna, e – al tempo stesso – indispensabile. A differenza dell’America di Trump, che continua a sabotare le politiche ambientali internazionali e a ridurre la portata dell’Inflation Reduction Act, la Cina non nega la crisi climatica: la monetizza. Il suo “verde” è profondamente rosso, nel senso politico e industriale del termine. E’ pianificato, centralizzato, strategico. Ogni pannello solare installato in Europa o in Africa è un pezzo di egemonia cinese: una rete di dipendenze materiali che sostituisce quelle energetiche del petrolio e del gas. C’è un paradosso che l’occidente non vuole vedere. La Cina, che ancora oggi costruisce centrali a carbone, è al tempo stesso il paese che più investe in fotovoltaico, eolico, batterie e idrogeno verde. Non è un’incoerenza, ma una transizione per accumulazione. Pechino sa che la vera supremazia del futuro non sarà nel controllo delle risorse fossili, ma nella capacità di fornire tecnologie per superarle. L’energia pulita è la nuova manifattura.
L’America, invece, è bloccata da un conflitto interno: da una parte, gli Stati democratici che investono nella green economy; dall’altra, il governo federale che, con Trump tornato alla Casa Bianca, smonta ogni regolazione ambientale in nome della libertà economica. Per la Cina, il clima è l’occasione per ridefinire la globalizzazione su basi nuove. Non più “Made in China”, ma “Powered by China”: un mondo in cui le reti elettriche, le turbine e le batterie portano il marchio del Dragone. E’ una strategia che unisce pianificazione economica e soft power. E che costringe l’Europa a un doppio sforzo: non solo ecologico, ma industriale.
La lezione cinese, nel bene e nel male, è che la transizione verde non è più un gesto di coscienza: è una forma di competizione economica. Gli Stati Uniti la combattono sul piano ideologico, l’Europa la gestisce con burocrazia, la Cina la conquista con pragmatismo. In questo equilibrio si gioca una parte cruciale del futuro globale: chi controllerà l’energia pulita controllerà anche la narrazione morale del mondo.