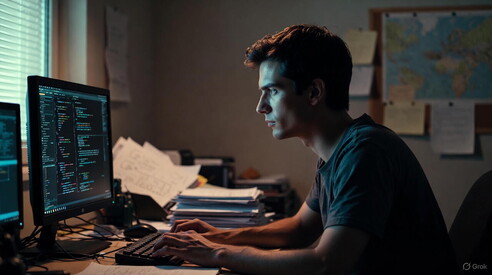(foto realizzata con Perplexity)
Il Foglio AI
La sanità italiana non soffre per mancanza di soldi, ma per eccesso di ipocrisia
Sprechi, politiche clientelari e assenza di cultura meritocratica: la vera crisi della sanità italiana non è nei fondi mancanti, ma nei tabù che impediscono valutazione, innovazione e fiducia nel sistema
C’è un tratto comune a tutte le discussioni sulla sanità italiana: si parla di denaro come se fosse l’unica terapia possibile. Si invocano più fondi, più risorse, più investimenti. Ma i numeri dicono altro: la spesa sanitaria pubblica è cresciuta del 20 per cento nell’ultimo decennio, eppure la produttività del sistema è rimasta ferma. Non mancano i soldi: manca la cultura del merito, della valutazione, della responsabilità. E’ il primo dei tabù che non vogliamo vedere. Il secondo è la politica, che occupa il sistema come un virus benigno diventato cronico. Il 70 per cento delle nomine dei direttori generali delle Asl è deciso su base politica. Non stupisce che le regioni con i migliori risultati siano quelle dove i vertici cambiano meno e la competenza conta più della fedeltà. Il management sanitario è trattato come un sottoprodotto della burocrazia: solo il 18 per cento dei dirigenti ha una formazione specifica in gestione della salute. C’è poi la retorica della “fuga dei medici”. Ogni anno ne escono diecimila dal sistema pubblico, ma non perché guadagnano troppo poco: perché non vengono ascoltati, non hanno autonomia, non vengono giudicati per il merito. E’ un’emorragia di fiducia, non di stipendi. Il quarto tabù riguarda i pazienti, ridotti spesso a casi pietosi o a statistiche di spesa. E invece sono proprio le loro narrazioni a cambiare la politica sanitaria: l’80 per cento delle campagne che hanno modificato leggi o linee guida – dall’HIV ai tumori, dall’Alzheimer alle malattie rare – è nato da testimonianze dirette, non da circolari ministeriali.
Il quinto è la disuguaglianza territoriale. Un cittadino del Nord riceve in media 600 euro di prestazioni in più ogni anno rispetto a uno del Sud. E’ la forma più ingiusta di povertà, quella che non si vede perché non fa notizia.
Sesto: la salute mentale. Un italiano su sei soffre di disturbi psichici, ma solo uno su tre riceve assistenza. Non è emergenza sanitaria, è fallimento culturale. La malattia mentale è ancora trattata come vergogna, non come condizione di cura. Settimo: l’uso dei fondi europei. Sei miliardi del Pnrr per la sanità territoriale ancora non assegnati. Non mancano le risorse, manca la capacità di spenderle. E’ il paradosso del centralismo inefficiente, che pretende di governare tutto e non riesce a gestire nulla. Ottavo: la medicina come ascensore sociale bloccato. Solo il 3 per cento dei medici under 40 proviene da famiglie non laureate. E’ un segnale di chiusura verticale, di sistema autoreferenziale, che scoraggia il talento e premia l’origine. Nono: la fiducia dei cittadini. In dieci anni è passata dal 78 al 49 per cento. Non per mancanza di ospedali, ma per mancanza di credibilità. E la credibilità nasce da parole giuste, da una narrazione onesta, non solo da bilanci approvati. Decimo, il più grande: la prevenzione. Ogni euro speso bene in prevenzione fa risparmiare tre euro in cure future. Eppure continuiamo a parlare di “spesa sanitaria” come se fosse una tassa. E’ invece un investimento di civiltà. La salute che conta non è quella che si misura in miliardi, ma quella che si racconta con verità. I tabù della sanità italiana sono gli stessi del paese: la paura del merito, l’adorazione della politica, l’assenza di fiducia. Romperli non significa cambiare un bilancio, ma cambiare un lessico. Perché la salute di un paese comincia dalle parole con cui decide di curarsi.