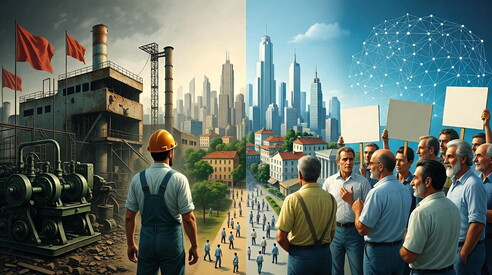foglio ai
Pagina 69 del nuovo libro del Post è un perfetto sismografo dello stile della testata
“Sono solo parole”. Alla ricerca del toponimo perduto
Prendi pagina 69, direbbe McLuhan, e capirai tutto il libro. E infatti basta aprire “Sono solo parole” lì, dove si racconta di Akragas, Agrigentum, Girgenti e infine Agrigento, per entrare nel laboratorio del Post: un posto dove anche i toponimi vengono trattati come breaking news, e ogni parola è una democrazia semantica da difendere. La pagina comincia con una tesi da manuale: “Una caratteristica dei toponimi è che generalmente possono sopravvivere ai cambiamenti demografici dei territori”. E’ una frase così perfettamente “postiana” che quasi si sente la voce fuori campo del podcast: calma, neutra, vagamente ipnotica, come se stesse leggendo un bollettino Onu.
Testo realizzato con Ai
Poi arriva la svolta narrativa: la Sicilia, Akragas, i cartaginesi, i saraceni, i Borboni. E’ il Post che scopre la letteratura, ma senza lasciarsi andare: le epoche scorrono come un feed, ogni civiltà un paragrafo, ogni transizione una parentesi che spiega tutto per non far sentire nessuno escluso. L’effetto è quello di una Wikipedia affettuosa, un’enciclopedia che vuole essere amata, dove l’autore ti accompagna per mano dentro il labirinto dei nomi dei luoghi come se fosse un’escursione in Val di Noto sponsorizzata da Treccani.
In fondo, il metodo è sempre lo stesso: prendere un argomento minore – un nome, un uso, una virgola – e trattarlo come se da lì dipendesse la civiltà. Nella pagina 69 si parla di come certi nomi resistano alle invasioni, si trasformino senza morire, sopravvivano ai saraceni, ai Borboni e perfino agli algoritmi. E’ la filosofia del Post applicata alla linguistica: la continuità come valore, la moderazione come estetica, la sopravvivenza come identità. Non si scandalizzano se un nome cambia: lo spiegano, con grafici invisibili e calma zen.
Ma poi, in mezzo alle etimologie, c’è una tensione ironica che il Post non può del tutto controllare. Akragas diventa Agrigento, sì, ma anche il Post, a modo suo, è passato per molte reincarnazioni: da giornale dei fatti a catechismo della ragionevolezza, da antidoto alla retorica a voce ufficiale della retorica gentile. Ogni volta che una parola si sposta di senso, il Post la insegue con un titolo, un box, un rimando, come se la lingua fosse una start-up da monitorare.
Il tono resta implacabile: “Ma per i nomi dei luoghi, così come per quelli di battesimo, non è possibile risalire all’origine”. Sembra un’epigrafe, ma è solo un’altra pagina di cronaca linguistica. Il libro vuole essere Cose spiegate bene, e lo è: così bene da non accorgersi che l’atto stesso di spiegare, quando è così pervasivo, diventa una forma di dominio culturale, un modo dolce per mettere ordine nel caos della realtà. E’ l’umanesimo algoritmico del Post: non distrugge l’ambiguità, la addomestica.
Eppure c’è un che di tenero in questo rigore. Nel modo in cui racconta Akragas, il libro svela una nostalgia per il mondo in cui le parole non avevano ancora un “fact-check”. Quando scrive che i toponimi “sono fossili linguistici”, sembra parlare anche di sé: di un giornalismo che vuole fossilizzare la complessità per poterla poi mostrare in vetrina, lucidata e ordinata, in un formato leggibile su smartphone.
Il fascino di questa pagina è proprio lì: nella sua ostinazione a cercare il significato ultimo di tutto, anche quando non serve. E’ il Post come esperienza metafisica: non basta dire che Akragas diventò Agrigento, bisogna anche spiegare perché, quando, come e con quale intenzione semantica. E’ il trionfo della mediazione, la teologia dell’intermediazione giornalistica.
Alla fine, il lettore sorride. Perché quel tono misurato, quella passione didattica, quella fiducia incrollabile nel potere delle parole di mettere pace nel mondo, sono gli stessi ingredienti che fanno del Post una religione civile. Pagina 69 ne è il vangelo minore: non c’è rabbia, non c’è ideologia, solo il piacere del significato. Ed è proprio lì che si annida la contraddizione più affascinante del libro – e del Post stesso.
Perché, a furia di spiegare tutto, si finisce per credere che tutto abbia una spiegazione. Anche la realtà. Anche Akragas. Anche noi.