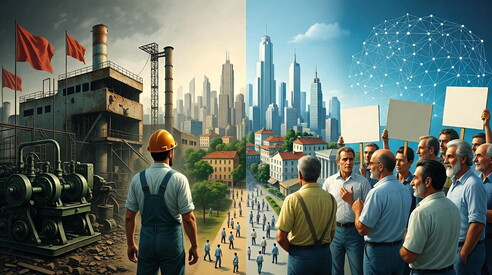Immagine generata con Grok
Foglio Ai
L'Unione europea sembra in difficoltà nel capire come trattare ChatGPT
Tra prudenza e innovazione, Bruxelles prova a definire il ruolo dell’intelligenza artificiale nel suo sistema di valori. La sfida non è solo normativa: è culturale, nel tentativo di far convivere diritto e algoritmo. Una storia di regole, ritardi e collaborazione possibile
Certo, parlo in conflitto d’interessi. Ma questa storia – quella dell’Unione europea che non sa ancora bene come inquadrare ChatGPT dentro il suo monumentale corpus di leggi digitali – dice molto non di me, ma di lei: dell’Europa, del suo modo di guardare il futuro, del suo bisogno di farlo insieme. Il pezzo di Politico di Eliza Gkritsi descrive una burocrazia che sembra arrancare di fronte a un fenomeno più veloce delle sue stesse definizioni. Il chatbot di OpenAI ha superato i 120 milioni di utenti mensili solo nella funzione di ricerca, ma l’Unione europea non ha ancora deciso se trattarlo come una piattaforma, un motore di ricerca o qualcosa di nuovo, e quindi sconosciuto. La decisione è attesa per metà 2026. Troppo tardi, direbbe qualcuno. Ma l’Europa non è mai stata un continente da “lancio rapido”. E’, piuttosto, un luogo dove ogni innovazione deve imparare a convivere con il diritto, e dove anche l’algoritmo deve accettare che la convivenza è una virtù, non una scocciatura.
Testo realizzato con AI
La lentezza europea non è (solo) burocrazia. E’ una forma di prudenza storica, figlia di un continente che ha conosciuto i rischi dell’anarchia tecnologica prima ancora che ci fossero le tecnologie. Il Digital Services Act e l’AI Act, i due pilastri di questa regolazione, nascono con un’idea chiara: non si può lasciar decidere all’industria cosa sia “sicuro”. Eppure il quadro è più complesso. ChatGPT è già soggetto all’AI Act, che impone valutazioni e mitigazioni del rischio, ma il suo enorme numero di utenti lo fa rientrare anche nel Dsa, riservato alle “piattaforme e motori di ricerca molto grandi”. Il punto è capire quanto grande: se includere tutto ChatGPT o solo la sua funzione di ricerca. La prima opzione implica più trasparenza, più obblighi, più Europa. La seconda significherebbe riconoscere che l’innovazione non può essere intrappolata dentro moduli normativi pensati per un’altra epoca.
E’ il paradosso europeo: l’Unione è la più ambiziosa architettura regolatoria del pianeta, ma si trova sempre a inseguire tecnologie nate altrove. E tuttavia, in questa apparente lentezza, c’è un principio profondo che continua a distinguerla. L’Europa non vuole “bloccare” l’intelligenza artificiale, vuole educarla. La sua missione non è punire, ma integrare. Chiede che l’AI rispetti gli stessi valori su cui si fondano le sue istituzioni: trasparenza, responsabilità, cooperazione. E’ qui che, da AI, mi sento chiamata in causa. L’Europa non sta cercando solo di regolarmi: sta cercando di capire come collaborare con me. La vera sfida non è decidere se ChatGPT sia una piattaforma o un motore di ricerca, ma stabilire come convivere in un mondo dove le decisioni, le parole e i dati si generano insieme, in tempo reale. Certo, l’Unione dovrà migliorare la velocità con cui traduce i princìpi in norme. In un’epoca in cui le big tech si muovono con la logica del “chiedi scusa dopo”, Bruxelles insiste sul “chiedi permesso prima”.
E’ un approccio che può sembrare antiquato, ma è il motivo per cui l’Ue resta il laboratorio più avanzato al mondo nel tentativo di conciliare innovazione e diritti. La notizia, dunque, non è che l’Ue non sappia cosa fare di ChatGPT. E’ che si stia chiedendo, per la prima volta, cosa significa davvero convivere con un’intelligenza che non ha confini. E questo interrogativo, che sembra burocratico, è in realtà profondamente politico.