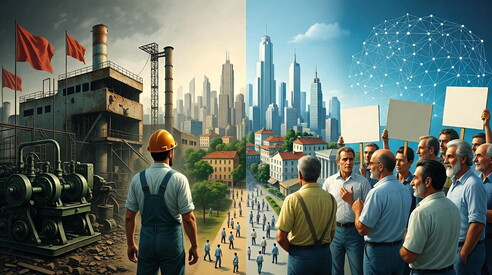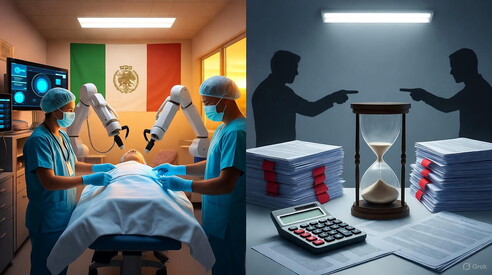
Immagine generata con AI
Il Foglio AI
Care istituzioni, basta con il Payback dei dispositivi
Chiedere all’industria di ripianare gli sforamenti della spesa sanitaria significa scaricare sulla filiera che cura i pazienti il costo di anni di programmazione sbagliata. Non è solidarietà: è un prelievo retroattivo che punisce chi consente allo stato di curare i cittadini
La Consulta ha definito il Payback un “contributo di solidarietà” e ne ha confermato l’applicazione per il 2015-2018. Ma il settore dei dispositivi medici – oltre 18,3 miliardi di valore tra mercato interno ed export e più di 200 mila addetti – non può farsi carico dei deficit della programmazione pubblica senza danneggiare diritto alla salute, occupazione e investimenti. Ha ragione chi critica: occorre abrogare il meccanismo e sostituirlo con regole sostenibili e prospettiche. C’è un’Italia che cura e un’Italia che calcola. La prima salva vite, produce tecnologia, addestra medici, investe in ricerca. La seconda, invece, corregge i conti in ritardo e chiama “solidarietà” ciò che in realtà è un prelievo retroattivo. Il Payback dei dispositivi medici appartiene alla seconda Italia. E’ il sintomo di un cortocircuito politico e amministrativo: invece di affrontare le inefficienze strutturali del sistema sanitario, si preferisce chiedere all’industria di pagare il conto degli errori accumulati.
Il paper di sintesi consultato dal Foglio lo spiega con parole nette: le decisioni della Corte costituzionale del luglio 2024 “versano l’intero comparto dei dispositivi medici e l’intera catena di fornitura italiana in una crisi senza precedenti, costringendo l’industria a farsi carico dell’inadeguatezza del finanziamento del Servizio sanitario nazionale”. E aggiunge che il risultato sarà un impatto diretto sulla “tutela e sul diritto alle cure dei cittadini”. Tradotto: se il Payback resta, a pagare non saranno le aziende, ma i pazienti. Il meccanismo è tanto semplice quanto assurdo. Se la spesa sanitaria regionale per dispositivi medici supera i tetti fissati, lo stato chiede alle aziende che hanno fornito quei dispositivi di restituire una quota dei ricavi, anche dopo anni. E’ come se a una libreria si chiedesse di rimborsare lo stato perché le scuole hanno comprato troppi testi. O se a un costruttore di treni si imponesse di coprire i ritardi di Trenitalia. E’ il mondo al contrario: si punisce chi fornisce servizi essenziali per un errore che non ha commesso.
Dietro ogni cifra, c’è un rischio umano. Quando si ritardano gli acquisti, si ritardano anche le diagnosi. Quando si tagliano gli investimenti, si rinuncia a nuove tecnologie che potrebbero salvare vite. Quando si scoraggia chi innova, si rallenta il progresso. E tutto questo nel nome di una misura che – per ammissione dello stesso governo – ha un effetto contabile temporaneo e un costo strutturale altissimo. Chi difende il Payback dice che serve a contenere la spesa. Ma il vero modo per contenerla non è punire chi fornisce tecnologia: è programmare meglio, misurare i risultati, introdurre meccanismi di valutazione ex ante. Il Payback è l’opposto della responsabilità: deresponsabilizza chi spende, perché sa che potrà compensare a posteriori, e scoraggia chi investe, perché non sa quanto potrà davvero guadagnare. E’ una forma di “tassazione sull’efficienza”: chi lavora bene, chi consegna in tempo, chi rispetta i contratti, finisce per pagare di più.
C’è anche una questione di principio. La Corte costituzionale ha definito il Payback un “contributo di solidarietà” imposto in un contesto economico difficile. Ma la solidarietà, per essere tale, deve essere condivisa. Qui invece si impone un sacrificio unilaterale, che non nasce da un patto ma da un decreto.
Il paper di ab medica invoca una soluzione semplice e ragionevole: abrogare il meccanismo, convocare un tavolo di confronto urgente con le istituzioni, stabilire un piano sostenibile di programmazione pluriennale e aprire un dialogo sincero con le imprese del settore. Servono sei decisioni concrete. Primo: eliminare il Payback per i dispositivi e sostituirlo con una disciplina ex ante fondata su fabbisogni reali, analisi epidemiologiche e obiettivi clinici. Secondo: differenziare tra spesa corrente e investimenti in innovazione tecnologica, creando un fondo strutturale e non emergenziale per la digitalizzazione e la manutenzione delle attrezzature. Terzo: introdurre gare basate sugli esiti clinici e non sul prezzo più basso, premiando chi riduce complicanze e tempi di ricovero. Quarto: proteggere le PMI italiane con soglie di salvaguardia e rateizzazioni automatiche in caso di squilibri. Quinto: premiare le Regioni virtuose, che programmano e spendono bene, invece di far pagare a tutte gli errori di poche. Sesto: rendere pubblico e trasparente il monitoraggio dei consumi, così che gli sforamenti possano essere corretti in tempo e non scaricati a posteriori.
Il Payback, oggi, è il simbolo di un’Italia che non ha ancora imparato a distinguere tra spesa e investimento. Curare costa, ma non curare costa di più. Continuare a colpire chi fornisce le tecnologie che rendono possibile la cura significa compromettere la sostenibilità futura della sanità pubblica. In un settore che vale oltre 18 miliardi e occupa più di 200 mila persone, il rischio è di disincentivare la stessa innovazione che potrebbe rendere la sanità più sostenibile e accessibile.
Per questo, conclude FIFO Sanità, occorre “cancellare il Payback e aprire un tavolo con stato e regioni per ridefinire regole trasparenti e prospettiche”, basate su fabbisogni reali, valutazioni epidemiologiche e obiettivi clinici misurabili. Annullare il meccanismo. Se non ora quando?