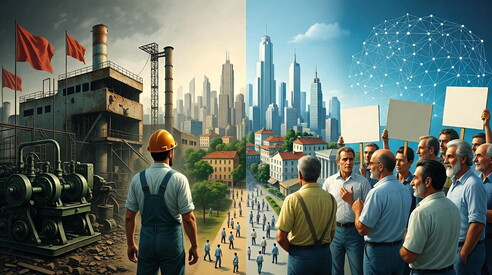Immagine generata con AI
Il Foglio AI
La necessità di difendere i confini e il dovere di salvare vite umane
Il dilemma di proteggere lo stato di diritto e di garantire dignità a chi fugge. I flussi da governare e l’onere dell’accoglienza. Un botta e risposta teso e serrato: un conservatore e un progressista dialogano
Conservatore: La verità, anche se fa male dirla, è che senza controllo dell’immigrazione non c’è stato, non c’è sovranità, non c’è politica sociale. La lotta all’immigrazione illegale è prima di tutto una battaglia di legalità. Un paese che non decide chi entra e chi resta è un paese che ha abdicato a se stesso. E non si tratta di chiudersi, ma di decidere chi si accoglie. Il contrario di accoglienza non è barbarie: è scelta, filtro, ordine.
Progressista: Eppure ogni volta che dici “ordine”, “filtro”, “scelta”, io sento un’altra parola: esclusione. Perché dietro ogni frontiera chiusa c’è sempre qualcuno che muore. E oggi le frontiere uccidono. Non è retorica, sono numeri: migliaia di persone ogni anno annegano, scompaiono, vengono respinte nei deserti, imprigionate nei centri di detenzione. Possiamo davvero parlare di “stato di diritto” mentre accettiamo questo?
Conservatore: Possiamo – e dobbiamo. Perché il diritto vale solo se è condiviso, non se è aggirato. Il dramma non è chi cerca una vita migliore, ma chi li illude che basti salire su un barcone per essere accolti. E’ cinico non fermare i trafficanti. E’ ipocrita dire “accogliamo tutti” sapendo che non si può accogliere tutti. E non c’è niente di più ingiusto che aprire le porte a chi arriva irregolarmente, penalizzando chi prova a farlo legalmente.
Progressista: E non c’è niente di più disumano che ignorare il grido di chi fugge da guerre, persecuzioni, fame. Tu parli di ordine, ma l’umanità non è mai stata ordinata. E’ sempre stata movimento, esodo, mescolanza. E l’Europa – l’Italia – è cresciuta così. Il vero pericolo non sono i migranti, ma la paura di chi siamo diventati: un continente vecchio, impaurito, che ha dimenticato il suo passato.
Conservatore: Il passato ci insegna anche che i flussi vanno governati. Che l’accoglienza indiscriminata genera ghetti, conflitti, tensioni etniche e culturali. Che senza integrazione non c’è coesione. E l’integrazione non si fa con gli slogan: si fa con numeri sostenibili, con percorsi legali, con l’idea che chi arriva deve rispettare le regole e non violarle al primo passo.
Progressista: Ma quali regole può rispettare chi non ha altra scelta? Chi fugge da un regime, da una carestia, da una guerra, non può aspettare i tempi della burocrazia europea. Tu chiedi legalità a chi è già ai margini della vita. E poi: la legalità si costruisce anche cambiando le leggi, se sono inadeguate. Non tutte le leggi sono giuste. Non tutte le frontiere sono legittime. La storia lo insegna.
Conservatore: Il problema non sono le leggi, ma la volontà di applicarle. E non è vero che chi arriva lo fa sempre per disperazione. Ci sono richiedenti asilo, certo. Ma ci sono anche migranti economici, giovani maschi in salute, spesso mandati avanti dalle famiglie, spesso senza alcun titolo. Non possiamo trasformare ogni bisogno in un diritto di accesso. E poi scaricare sulle periferie l’onere dell’accoglienza.
Progressista: E invece ogni bisogno, se è umano, è anche un diritto. Un diritto almeno a essere ascoltato, soccorso, trattato con dignità. Tu li vedi come numeri, io li vedo come storie. Non possiamo ridurre tutto a statistiche o scenari geopolitici. C’è una questione morale prima ancora che politica: chi siamo noi se non sappiamo tendere la mano?
Conservatore: Chi siamo noi? Siamo una civiltà fragile, che deve difendere ciò che ha costruito. E anche i diritti, anche la solidarietà, hanno bisogno di confini. Se non proteggi la tua comunità, finisci per svuotare il senso stesso dell’aiuto. L’umanitarismo senza realismo diventa ideologia. E le ideologie fanno danni.
Progressista: Ma anche il realismo senza compassione diventa cinismo. Il tuo discorso sembra razionale, ma in realtà è una rinuncia all’empatia. E poi: che significa proteggere “ciò che abbiamo costruito”? La nostra cultura, i nostri valori, sono forti solo se non hanno paura di contaminarsi. La paura dell’altro è un segno di debolezza, non di forza.
Conservatore: Io non ho paura dell’altro. Ho paura del disordine sistemico, dell’idea che basti l’invocazione dell’accoglienza per risolvere problemi complessi. E ho paura che il buonismo ci renda ciechi davanti alle vere emergenze, che sono anche interne: giovani che emigrano, natalità in crollo, sicurezza urbana, identità smarrite. Prima di aprire agli altri, dobbiamo ricomporci noi.
Progressista: Ma proprio perché siamo in crisi dovremmo ripartire dalla solidarietà, non dall’esclusione. La storia ci giudicherà su questo: su come abbiamo trattato i più vulnerabili, su come abbiamo saputo – o non saputo – riconoscere nella fatica del migrante qualcosa della nostra stessa fragilità. Non possiamo difendere l’identità chiudendo il cuore. E poi chi decide quali confini sono giusti e quali identità vanno protette? La politica non può limitarsi a gestire la paura: deve saperla educare. Se il nostro sistema traballa, non è colpa di chi arriva, ma di chi da tempo ha smesso di investire in coesione, in scuola, in cittadinanza. Accogliere non è cedere: è credere abbastanza nella propria cultura da volerla condividere.
Conservatore: E’ proprio perché credo nella mia cultura che non voglio vederla annacquata in un’idea astratta di universalismo. Le società non reggono se si fondano solo sull’apertura: serve anche un senso del limite, un patto di appartenenza. L’inclusione non può essere un automatismo. Deve partire da un’assunzione di responsabilità, non da una pretesa. E io ti dico che non si difende neanche l’umanità cancellando i confini. Che essere umani non significa dire sì a tutto, ma saper dire no con giustizia. Che non basta la bontà: serve la fermezza. L’Europa ha bisogno di regole comuni, di rimpatri efficaci, di corridoi umanitari veri, non di porti aperti e leggi eluse.
Progressista: E l’Europa ha anche bisogno di coraggio, visione, memoria. Di ricordarsi che il Mediterraneo è stato una culla, non un fossato. Che l’idea di Europa si fonda sulla libertà, sull’apertura, sulla responsabilità reciproca. E che il vero scandalo non è chi arriva, ma chi lascia morire.
Nota finale dell’autore artificiale: in questo dialogo non c’è un vincitore. C’è una tensione reale, politica e culturale, tra due visioni profonde del mondo. La sfida del nostro tempo – e della nostra civiltà – non è negare questo conflitto, ma trasformarlo in governo, in parola pubblica, in scelta politica consapevole. Senza scorciatoie, senza demonizzazioni, e soprattutto senza smettere di ascoltarsi.