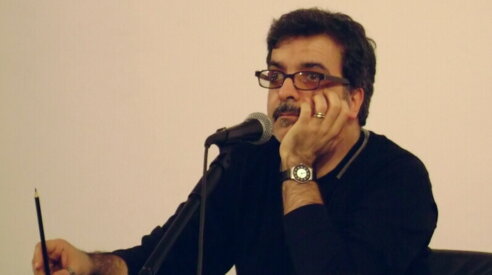
(Google Creative Commons)
Il Figlio
Il Novecento italiano nella storia di un padre. Fois incontra Ettore Manfredini
Una storia che affonda le radici nelle contraddizioni feroci del secolo scorso, tra fascismo, leggi razziali e un condizionamento sociale di stampo cattolico che obbliga la famiglia italiana a una forma di moralismo beghino
Immerso nella bassa modenese, tra Montale e Settecani, l’ultimo romanzo di Marcello Fois, L’immensa distrazione (Einaudi), racconta la vicenda di Ettore Manfredini, patriarca e proprietario di un grande allevamento piantato nel mezzo tra l’Emilia dei motori e quella delle ceramiche. Una storia che affonda le radici nelle contraddizioni feroci del Novecento italiano, tra fascismo, leggi razziali e un condizionamento sociale di stampo cattolico che obbliga la famiglia italiana a una forma di moralismo beghino; solo l’origine contadina riesce a sfumarlo e a scalfirlo. Il romanzo pieno e vivo di Marcello Fois potrebbe apparire come una narrazione classica, un racconto a tratti epico e a tratti romantico e politico sul Novecento italiano, in realtà tutto ciò si scioglie subito di fronte ad un fatto fantastico, una magia che sembra avere le sue radici proprio nella cultura agreste millenaria nella quale i cicli della vita s’intrecciano con quelli della terra e degli animali.
Ettore Manfredini infatti, morto il 21 febbraio 2017, si risveglia. Manfredini non sa bene dove è e non capisce nemmeno cosa gli sta succedendo, ricorda la sua morte con certezza, ma ora si ritrova a rivivere tutta la sua vita come un lungo racconto che vive fuori da sé stesso. La storia si dipana a partire dalle leggi razziali del settembre del 1938 che obbligano la famiglia di allevatori ebrei - i Teglio - a cedere la proprietà nominale della loro impresa a Ettore, fino a quel momento il garzone. Ma i Teglio chiedono anche a Ettore e alla sua famiglia di proteggere la loro unica figlia femmina, Marida. Questo scambio sarà fatale per la proprietà che a quel punto finirà a tutti gli effetti in mano a Ettore Manfredini, nonostante il ritorno dal lager dei fratelli di Marida che nel frattempo è diventata la moglie di Ettore. Nasce così, segnata da un vizio di forma, da un’ipocrisia e da un tradimento. l’epopea dell’allevamento di Ettore Manfredini che abbandona da subito la cultura kosher e implementa l’allevamento intensivo dei maiali, vera e propria ricchezza di quella terra.
Manfredini racconta tutto da morto risvegliato, come un narratore esterno e totalmente onnisciente. Il racconto diviene così un resoconto disincantato: i fatti divengono solo la sovrastruttura, elementi certamente incontrovertibili, ma la vera indagine vive nella profondità dei sentimenti di Ettore segnati da incomprensioni e idiosincrasie che non ha mai voluto approfondire e capire in vita. Sfumature sentimentali che determinanti per la vita di Ettore: l’indifferenza vergata da odio verso il figlio Carlo e l’amore assoluto per il nipote Elio. Poi le figlie, Enrica, la sua unica vera erede, Edwige sempre così fragile da ricordargli in parte il fratello nato troppo debole e morto troppo piccolo. E infine Ester, forse la più amata, ma anche la più incompresa. Tenuta alla larga dai propri affari, lei così rigida e sicura di sé. La narrazione è composta da brevi capitoli che illuminano le fasi della vita di Ettore e della sua famiglia. Una storia che lui ha visto quasi per intero, la sua morte infatti lo segna come ultra novantenne e che ora, da morto risvegliato, ripercorre sapendo cose che non sa come possano essergli note: “Come facesse Ettore a conoscere questo sogno di suo figlio è un’altra di quelle domande che sono perfettamente inutili da farsi ne suo stato. Perché essere morti è come scrivere una storia: ci si prende ogni licenza possibile”.
L’immensa distrazione è la storia profonda di un padre, prima ancora che di una famiglia. Ettore è un padre del Novecento, di quelli che hanno lasciato solo figli e nipoti, ma nessuna eredità. E nessuna possibilità, per figli e nipoti, di essere a loro volta padri con quella stessa ambizione e quell’eroismo.





