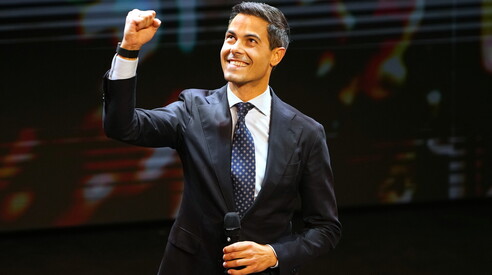Un cartello dalle recenti manifestazioni “No Kings” negli Stati Uniti (foto Ap, via LaPresse)
magazine
Il corpaccione dell'Impero
La tendenza imperiale d’occidente è evidente. C’entrano la crisi sociale e della democrazia. Ma anche i nuovi poteri tecnologici senza confini. Non è solo colpa di Trump, gridare “No Kings” non basta. Servono “i due corpi del re”
“I due corpi del re formano così un’unità indivisibile, essendo ciascuno pienamente contenuto nell’altro. Tuttavia non può sorgere alcun dubbio sulla superiorità del corpo politico su quello naturale”.
(Ernst H. Kantorowicz, “I due corpi del Re”)
"No Kings”, nessun re. Le manifestazioni piene d’ironia e di pupazzi gonfiabili dello scorso sabato negli Stati Uniti contro Donald Trump e il suo dispotismo non illuminato raccontano due cose positive.
Una che è viva la preoccupazione per il destino della democrazia: il corpo stesso, quasi mistico, dell’America.
L’altra è che persino nell’America dilaniata dall’odio antropologico si può combattere senza perdere l’allegria e la forza d’aggregazione, che è il contrario della disgregazione. Di solito per abbattere i re i toni sono più cupi e violenti, come in Che la festa cominci…, vecchio film di Bertrand Tavernier che raccontava la psicologia sociale della Rivoluzione che stava per arrivare.
Del resto in Francia un re democratico è appena finito alla Santé, decapitazione simbolica dell’Eliseo, in un clima rancoroso contro il potere costituito. C’è un dettaglio delle manifestazioni No Kings che invece funziona meno. La cosa che non torna, a ben guardare, è proprio il “King”, il nome simbolico dato al modello di potere che si vuole contestare. Il destino della democrazia, col suo declino formale, non è un tema soltanto americano. Basterebbe ricordare l’appello di Ursula Von der Leyen nell’ultimo discorso sullo Stato dell’Unione a proposito della necessità di introdurre il voto a maggioranza qualificata per poter far camminare un’Europa spesso bloccata nei cristalli delle sue forme; o dare una sbirciata alle percentuali di voto in Toscana e ai sondaggi in Germania. E’ il potere democratico, sovrano, a zoppicare un po’ ovunque.
Ma Trump non è un re: è un imperatore. O vorrebbe esserlo. I suoi obiettivi sono imperiali in casa e all’estero. I modi con cui li persegue non appartengono alla sovranità costituzionale – il presidente degli Stati Uniti è un re costituzionale: John F. Kennedy non viveva forse nella sua Camelot ideale, attorniato da consiglieri-cavalieri della Tavola rotonda? –, sono atti d’imperio. L’immigrazione, l’uso esponenziale dei poteri presidenziali, la Guardia nazionale, il condizionamento della Giustizia, lo stato d’emergenza evocato come anticamera di un possibile stato d’eccezione (si paventa che il tycoon in chief potrebbe sospendere le future elezioni). Per non parlare della politica estera, dei dazi. Il modo feudale, basato sulla fiducia personale, di scegliere gli interlocutori. Anche l’ultima personalistica iniziativa di Trump, l’abbattimento della East Wing della Casa Bianca per far spazio a una nuova neroniana, o putiniana, ballroom va in questa direzione simbolica. La piccola Casa Bianca, un cottage borghese, è la dimora naturale di un re pro tempore. Sventrarla per trasformarla in una domus aurea in formato qatariota è molto più che uno sfregio architettonico. Non è soltanto colpa di Trump. Ovunque si va affermando una costituzione materiale di tipo neo imperiale – da non confondere con neo imperialista – o almeno ci si dirige verso una dimensione sovranazionale del potere di tipo imperiale (tocca dare ragione a Toni Negri). Anche tralasciando imperi orientali come Cina e Russia, che garanzie democratiche non ne conoscono. A Sharm el-Sheikh, del resto, Trump ha convocato il sultano di Istanbul e il faraone del Cairo. Li ha messi al tavolo, primus inter pares, e sul piatto da spartire c’era la testa degli eredi dello scià di Persia. Il nostro caotico mondo è stato generato dalla Prima guerra mondiale, alla fine della quale caddero ben cinque imperi che ora cercano di rimettere le cose al loro posto, compreso l’ex Mandato britannico. I cittadini americani, al pari di quelli europei, dovrebbero pregare per la salute dei loro re costituzionali.
Nella storia occidentale, persino nel medioevo dei re per diritto divino (ma la Magna Charta ha otto secoli) e nell’epoca dell’assolutismo il re rappresenta la stabilità e la garanzia di un ordine sociale, politico e dei diritti. Può essere un poco di buono, può essere anche un tiranno, accade spesso che i bambini lo vedano nudo. Ma non gli si dovrebbe mai mozzare la testa, di solito non finisce bene. C’è un libro affascinante, che sembra entrarci poco con le manifestazioni anti Trump e invece ha molto da dire. Si intitola I due corpi del Re, pubblicato a Princeton nel 1957 dal grande storico tedesco e poi americano (le origini erano ebraiche) Ernst H. Kantorowicz. Il suo lungo studio, che dal medioevo arriva all’età moderna, è dedicato a comprendere e spiegare questa idea creduta e sopravvissuta nei secoli, sostenuta da filosofi e giuristi: che il re possedesse, letteralmente, due corpi. Uno, il suo corpo mortale; e un altro invece simbolico (in epoca medievale era addirittura mistico e sacrale), che incarna l’essenza del potere, del diritto, del governo e della proprietà. Kantorowicz sapeva di indagare un tema scabroso, un paradosso o un assurdo per i moderni. Lui stesso elenca i casi e gli esiti più bizzarri di questa teoria, come quello di Giorgio III “che dovette presentarsi al Parlamento per ottenere il permesso di avere una certa terra come uomo e non come re”, perché al re quel diritto “privato” veniva negato dai giudici. Una simbologia del potere che nasce dalla teologia – Kantorowicz evoca le immagini del “Volto Santo” nelle quali Gesù è incoronato come Re – ma in epoca elisabettiana quella “finzione di verità” diventerà la base politica e giuridica per affermare che il potere dello stato, della monarchia, sopravvive al singolo. Il succo, ridotto all’osso, del magnifico saggio sul potere e il diritto di Kantorowicz è che dalla “invenzione” che una parte del corpo del re sia immortale discende che la sua autorità non è soggetta alla volubilità né sua né di altri. E questo fonda il diritto anche per il popolo.
Quando morì Elisabetta II le simbologie analizzate da Kantorowicz tornarono per un attimo d’attualità, giusto per spiegare allo stupefatto pubblico mondiale la stabilità di un’istituzione medievale eppure capace di resistere a tutto e di rappresentare “il corpo” della nazione. Oggi il modo sicuro da parte di Carlo III di amministrare il suo potere simbolico e reale è un esempio lampante di ciò che Kantorowicz racconta. Persino malato, e senza nascondere la debolezza del suo primo corpo, Carlo sta rafforzando il secondo corpo – la cacciata del fratello Andrea – e l’immagine della monarchia-nazione. E in un momento non particolarmente semplice anche per la democrazia britannica, che vede incrinarsi l’architrave del bipartitismo, Carlo con i suoi due corpi suscita fiducia e tranquillità. Trump è un’altra cosa. E’ un imperatore, non nel senso migliore. Somiglia a un Gran Khan orientale, svuota l’istituzione e ambisce a sostituirsi a essa con la sua persona “privata”. L’esibizione ipertrofica della sua figura, il ciuffo, la risata, i continui meme digitali ne sono una prova. Incalzato e bullizzato dal corpaccione privato dell’arrembante imperatore, il re costituzionale non serve più.
Non è tutta colpa di Trump. La poderosa spinta politica e populistica che lo ha portato al potere ha molte molle e rampe di lancio. Lo scontento di intere fasce sociali per un declino economico scambiato per destino etnico, la crisi demografica scambiata per complotto, l’insofferenza per i modelli culturali elitari, i malfunzionamenti della burocrazia. In più la débâcle concettuale della sinistra. La lista è sostanziosa, si sono scritte milioni di pagine. Infine ci sono i media, gli algoritmi, il potere incontrollabile della Camelot impenetrabile dove si intrecciano idee, destini e business dei cavalieri trumpiani dell’Illuminismo oscuro. Kirk in America, i gilet jeune in Francia, la Brexit, il nostro populismo d’accatto sono stretti parenti, spinte repulsive contro la democrazia liberale e welfarista come l’abbiamo conosciuta. Trump ritiene di avere per sé un destino imperiale – intervistato dall’Economist Steve Bannon dice che si ricandiderà nel 2028 – come del resto lo pensano Orbán o persino Farage. Ma non sono la contingenza del favore popolare o l’ambizione personalistica a essere decisive. L’elemento che va preso sul serio è che è in atto un cambiamento di paradigma, o episteme (tocca dare ragione anche a Foucault), nel concetto stesso di potere politico e nella sua percezione. Cose che vanno ben oltre l’esagitato inquilino della Casa Bianca.
Dall’Economist in giù, dal suo insediamento, molti commentatori sottolineano che quella di Trump è una repubblica imperiale, un disegno politico articolato già presente nel Project 2025 per modificare l’assetto costituzionale e politico degli Stati Uniti. Ha detto Russell Vought, direttore dell’ufficio del Bilancio di Trump: “Abbiamo bisogno di essere radicali nel disfarci o nel ripensare i paradigmi legali che hanno limitato la nostra abilità di ritornare alla costituzione originale”. Trump non è un accidente della storia, ma l’espressione di tendenze destinate a segnare il prossimo futuro. E’ interessante che, in Europa e in Italia, i più preoccupati dal cambio di paradigma americano siano gli intellettuali di sinistra, quelli fino all’altro ieri critici della democrazia “imperialista” americana in quanto tale. La filosofa Nadia Urbinati ha scritto tempo fa per la Fondazione Italianieuropei che a muovere “i seguaci di Bannon e i seguaci di Vance” non c’è un calcolo razionale ma delle “passioni tristi”: soprattutto “il risentimento, la passione triste dei populisti” che alimenta “odio e bisogno di vendetta”. Nella lettura di Urbinati, dualistico-tradizionale, in America si sono confrontate una visione nobilmente egemonica, quella dei democratici che hanno imposto l’allargamento dei diritti, della giustizia sociale, e un “progetto politico di reazione”, che da Reagan in poi impone una “costruzione ideologica neoliberista” che in Trump diventa “dominio”. La Camelot di JFK era egemonica ma buona, il dominio repubblicano invece no. Il punto non è se questa visione binaria sia giusta o sbagliata. Il punto è che appare inadeguata a leggere il grande cambiamento in corso. Che non è fatto solo di “dominio”, i ricchi contro i poveri, i bianchi contro gli altri, ma di una messa in discussione e liquidazione di molte cose. Trump non vince perché promette soldi ai poveri, ma perché promette un cambio del sistema.
Basterebbe prendere (seriamente) in considerazione il pensiero di Peter Thiel, il padrone di Palantir, intellettuale contrarian e figura centrale della nuova destra tecno-imperiale per definire il quadro. Thiel, di cui Liberilibri ha appena pubblicato l’illuminante Il momento straussiano, aveva terremotato da studente a Stanford l’accademia liberal – con David Sacks, futuro venture capitalist della Valley, aveva scritto Il mito della diversità: il multiculturalismo e l’intolleranza politica nei campus, testo fondativo del futuro trumpismo anti universitario. Da anni teorizza la disuguaglianza come motore del progresso, l’inutilità della democrazia – più precisamente: “La democrazia non è più compatibile con la libertà” –, la sostituzione della politica con l’analisi dei big data, l’individualismo radicale, la sostituzione antropologica attraverso la bioscienza. Quelle che in Elon Musk sono spesso boutade creative (una giovanile: “Sono la reincarnazione dello spirito di Alessandro Magno”), in Thiel hanno struttura di pensiero politico. Non è strano che i padroni della Silicon Valley, che da decenni hanno abbandonato “l’ideologia californiana” liberal, siano affascinati dall’impero romano. E terrorizzati dall’immagine del suo declino e caduta, a cui si sono dati la mission di reagire.
Vittorio Emanuele Parsi ha scritto mesi fa su Le Grand Continent che “l’inclusione di Elon Musk nel ruolo di gran consigliere del presidente… non costituiva solo la punta dell’iceberg della pressoché totale oligarchizzazione della repubblica, ma in realtà riproduceva la dinamica dell’imperator con il suo libertus”. Più che per Musk, l’immagine è calzante per Thiel, liberto tedesco-namibiano. Il liberto più influente di Augusto fu Mecenate: il vero ideologo, diremmo oggi, del disegno imperiale di Ottaviano. Thiel è l’intellettuale del gruppo vicino a Trump: i “presidenti”, al plurale, come li ha chiamati Monica Maggioni in un libro-ritratto giornalistico, illuminante proprio perché evita le teorie. L’industria digitale, l’AI, le neuroscienze sono universi autodeterminati, in grado di dominare il mondo con l’appoggio di un presidente amico, o anche senza nemmeno quello: è Trump che garantisce Palantir, o è Palantir che gli permette di governare? L’unica cosa sicura è che Trump passerà, ma saranno Palantir e i suoi fratelli a scegliere il prossimo imperatore. Sergio Mattarella, usando non a caso un’immagine imperiale, aveva lanciato un allarme contro “i neo feudatari del Terzo millennio – novelli corsari a cui attribuire patenti – che aspirano a vedersi affidare signorie nella dimensione pubblica, per gestire parti dei beni comuni rappresentati dal cyberspazio nonché dallo spazio extra-atmosferico, quasi usurpatori delle sovranità democratiche”. Luciano Violante aveva usato un paragone simile, a proposito delle big company digitali: “La Compagnia delle Indie o quella della Baia di Hudson erano soggetti privati cui era concesso però di avere un esercito, amministrare la giustizia, esercitare poteri sovrani su grandi territori sovranazionali”. Come per Trump i confini possono essere superati dall’atto personale, così i grandi poteri economici – il potere della conoscenza, il più importante – sono tendenzialmente legge a sé stessi. Che interesse possono avere per il corpo simbolico del re? Al massimo hanno interesse, come dice Bannon all’Economist, per lo “strumento divino” rappresentato da Trump.
Alla manifestazione di Washington il senatore Chris Murphy ha detto: “Non siamo sulla soglia di una presa di potere autoritaria, ci siamo nel pieno”. Ma certi passaggi d’epoca non si realizzano con due presidenze. Curtis Yarvin, aka il blogger Mencius Moldbug, parte dell’inner circle, inventore dell’“Illuminismo oscuro”, intervistato dal New York Times ha ripreso uno dei suoi cavalli di battaglia: il presidente democratico Franklin Delano Roosevelt, il padre del New Deal. “A volte cito gli ultimi dieci paragrafi del primo discorso inaugurale di FDR, in cui dice essenzialmente al popolo americano: ‘Datemi il potere assoluto o lo prenderò comunque’. FDR ha davvero assunto quel livello di potere? Sì, l’ha fatto”. Si possono prendere con le molle le idee del blogger antidemocratico, ma il tema della logica emergenziale nelle crisi di sistema non è banale.
Non è una gioiosa camminata verso il sol dell’avvenire – fosse pure il Sol Invictus di Eliogabalo, imperatore visionario e pop, non a caso fallimentare. C’è un sentimento di paura da allontanare. Si è spesso citata, a proposito dei piedi d’argilla dell’imperatore, altro che i suoi vestiti nuovi, la “legge di Ferguson”. Lo storico scozzese sostiene che “quando la curva della spesa per interessi sul debito pubblico supera quella per la difesa o militare, se si preferisce, uno stato, qualunque esso sia, finisce in overstretching”, insomma fallisce. E’ capitato agli imperi del passato, è il caso ora degli Stati Uniti come dimostrano gli studi economici. Il tentativo di risolvere in fretta le guerre, oltre ai sette Nobel da conquistare, è determinato anche da questa consapevolezza. Ugualmente, molte delle sgangherate idee economiche di Trump sono tentativi disperati di rivitalizzare un paese reale che arranca. Parsi ha immaginato Trump come un Cesare, e un futuro presidente Vance come l’Augusto che compirà il passaggio. Ma la Roma di Augusto ha simboli di tutt’altro tipo che una ballroom pietroburghese, e poco o nulla di manesco. L’Ara Pacis è lo scrigno di infiniti simboli e di una visione di pace e prosperità. Il suo impero fu sì lo svuotamento di una democrazia che non teneva più, travolta da guerre civili su scala mondiale, ma fu realizzato senza bagni di sangue, col consenso del Senato e del popolo. E fu una grande restaurazione degli antichi costumi, dell’antica religione, nel segno di una morigeratezza sociale persino bacchettona. Chissà, un giorno, con un Vance-Costantino. Il futuro impero dinastico di Trump ha qualcosa di più minaccioso. Ma ancora una volta non è solo “colpa” di Trump. E’ la logica di poteri che non riconoscono confini e contrappesi. Putin ha il suo modello in Ivan Grozny, il “Minaccioso”, il suo potere si regge sulla continua pressione contro i nemici. La visione di Xi Jinping è quella di rifunzionalizzare un impero mandarino e millenario, retto da una burocrazia occhiuta e onnipotente in cui i concetti di libertà e diritti individuali non ci sono. Una democrazia che non sappia preservare il secondo corpo del suo Re, è a forte rischio di essere travolta da forze storiche enormi. Riassume alla perfezione un post su X di Giovanni Nuvoletti: “Finché continueremo a combattere sul piano razionale chi opera sul piano simbolico, continueremo a perdere. Trump ha trasformato la politica in linguaggio psichico perché ha capito che la battaglia decisiva si combatte nell’immaginario collettivo”. Non è sufficiente, i meccanismi economici e di formazione del consenso sono molto più di una questione di simboli. Ma come insegna Kantorowicz, la simbologia del potere del re viene prima del suo potere reale, lo plasma e lo determina. Dopo Trump può venire di meglio, forse. Come dopo Domiziano venne Traiano, dopo Caligola venne Claudio. Ma oggi più che mai servono i due corpi del Re. Altrimenti un giorno ci troveremo a dire: “Right or wrong, my emperor”.